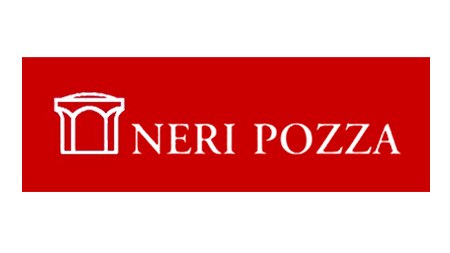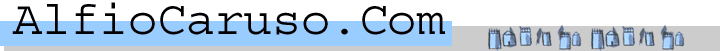
|
|
|
|
1
All’origine c’è un direttore di banca
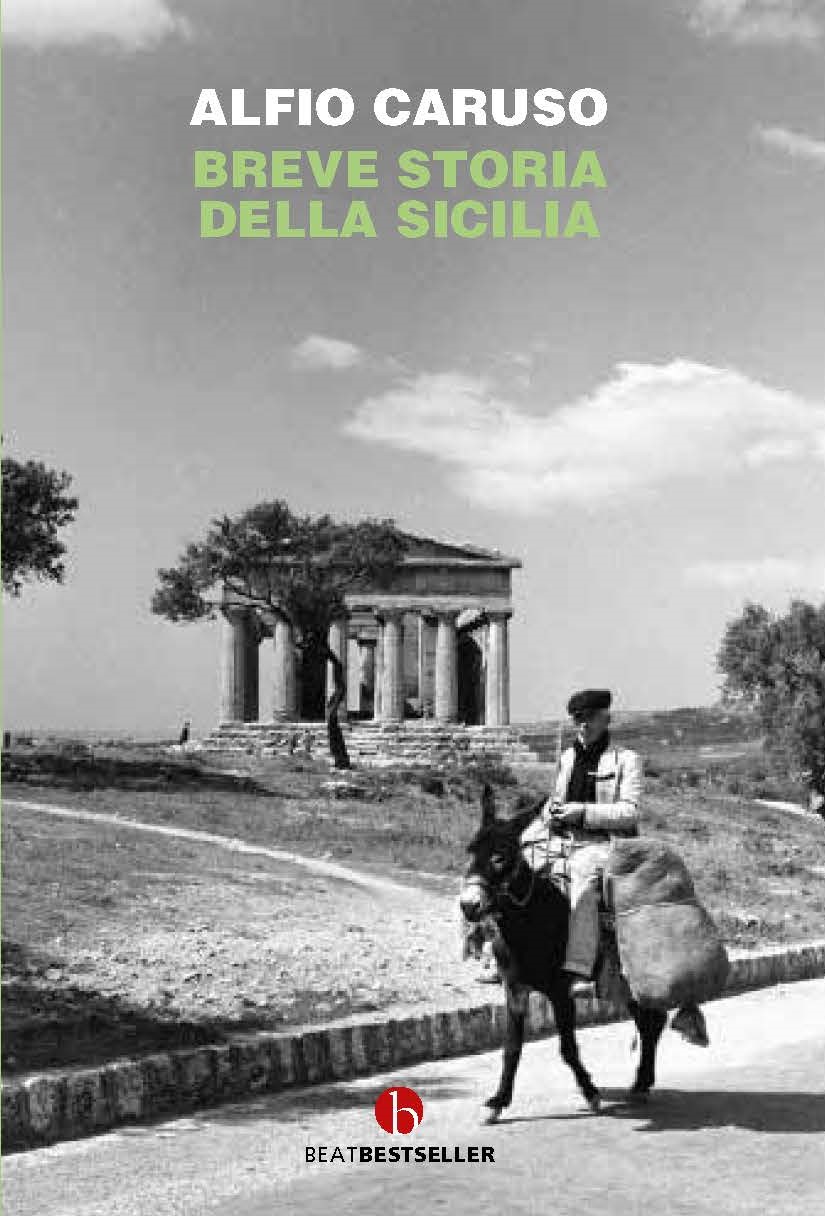 Da mezzo secolo in Sicilia i colti muoiono dalla voglia di veder trionfare le intuizioni di Gerlando Bianchini. Elegante e riservato, durante la settimana esaminava e accordava prestiti e fidi nella filiale agrigentina della banca da lui diretta, mentre nel tempo libero andava a caccia del passato più passato che esistesse. In tal modo individuò una quarantina di siti attorno al fiume Platani contenenti manufatti litici: attesterebbero la presenza nell’isola degli australopitechi, cioè le scimmie del sud appartenenti alla famiglia degli ominidi, da cui infine saremmo discesi noi. Se avesse ragione Bianchini, ma la gran parte degli esperti ha molto da obiettare, la presenza umana in Sicilia compirebbe un prodigioso balzo all’indietro di un milione di anni e la stessa Sicilia, più o meno come accade adesso, sarebbe trasformata nella base di lancio dell’emigrazione dall’Africa verso l’Europa. Insomma, la Storia che continua a ripetersi al di là delle più rosee previsioni di Vico. Solo che questo trasferimento di bipedi, appena elevatisi in posizione eretta, presupporrebbe anche la profonda trasformazione geologica dell’area mediterranea: al tempo di cui parliamo barche non ce n’erano, di conseguenza si poteva viaggiare soltanto a piedi, quindi niente mare, al suo posto una placca continua dalle attuali coste africane all’Italia. E qui a dissentire sono anche i geografi.
Da mezzo secolo in Sicilia i colti muoiono dalla voglia di veder trionfare le intuizioni di Gerlando Bianchini. Elegante e riservato, durante la settimana esaminava e accordava prestiti e fidi nella filiale agrigentina della banca da lui diretta, mentre nel tempo libero andava a caccia del passato più passato che esistesse. In tal modo individuò una quarantina di siti attorno al fiume Platani contenenti manufatti litici: attesterebbero la presenza nell’isola degli australopitechi, cioè le scimmie del sud appartenenti alla famiglia degli ominidi, da cui infine saremmo discesi noi. Se avesse ragione Bianchini, ma la gran parte degli esperti ha molto da obiettare, la presenza umana in Sicilia compirebbe un prodigioso balzo all’indietro di un milione di anni e la stessa Sicilia, più o meno come accade adesso, sarebbe trasformata nella base di lancio dell’emigrazione dall’Africa verso l’Europa. Insomma, la Storia che continua a ripetersi al di là delle più rosee previsioni di Vico. Solo che questo trasferimento di bipedi, appena elevatisi in posizione eretta, presupporrebbe anche la profonda trasformazione geologica dell’area mediterranea: al tempo di cui parliamo barche non ce n’erano, di conseguenza si poteva viaggiare soltanto a piedi, quindi niente mare, al suo posto una placca continua dalle attuali coste africane all’Italia. E qui a dissentire sono anche i geografi.
Diventa allora obbligatorio rifarsi al percorso ufficiale, che data l’arrivo dell’uomo dal Continente fra il 30.000 e il 20.000 a.C. Il primo essere umano, di cui si ha traccia sull’isola si chiama Tea, una donna vissuta tra 14 e 11mila anni fa, nel Pleistocene superiore. Fu ritrovata negli anni Trenta del Novecento ad Acquedolci, paese che si affaccia sul mar Tirreno di fronte alle Isole Eolie e antica frazione della cittadina collinare di San Fratello, precisamente nella grotta di San Teodoro, da qui il suo nome. Tea aveva circa trent’anni, longeva per le aspettative di vita del tempo: significa che conducesse un sano stile di vita; alta 1 metro e 65, il bacino molto più largo rispetto a quelli rinvenuti negli scheletri maschili: fa pensare che probabilmente ebbe dei figli e che forse morì di parto. L’appartenenza a un ceto sociale elevato lo testimoniano la dentatura perfetta, dunque nessun problema di alimentazione, e le articolazioni per nulla logorate, s’immagina che mai abbia lavorato. Probabilmente Tea era al vertice della sua piccola comunità, di conseguenza toccava a lei decidere, gestire, organizzare i lavori dei compagni. I ricercatori hanno dedotto che dovesse essere una sacerdotessa o una principessa, perciò è stata definita la “principessa preistorica”, anche se i suoi discendenti la chiamano familiarmente «a zzà Tea» ed è considerata affettuosamente la nonna di tutti i siciliani. Tea viveva in gruppo: nella stessa grotta, infatti, sono stati individuati i resti di altre sei persone, quattro maschi e due femmine, dediti alla caccia e alla raccolta di frutta e verdure spontanee, non ancora all’agricoltura. L’esistenza dei contemporanei di Tea si sviluppò fra caverne e grotte: in quelle dell’Addaura, vicino Palermo, sono state rinvenute fondamentali incisioni rupestri. Nella Grotta del Tuono, sull’isola di Marettimo, un cervo fossile e resti di cibo suggeriscono di anticipare al Mesolitico le prime rotte finora attribuite al Neolitico. A Lipari hanno, invece, scoperto tracce strabilianti delle civiltà colonizzatrici dal Neolitico (VI millennio a.C.) in avanti. L’isola eoliana rappresentava, infatti, il principale centro di estrazione e distribuzione dell’ossidiana. Costituiva il materiale più tagliente dell’epoca, ricercatissimo per qualsiasi attività lavorativa. Attorno all’ossidiana si svilupparono intensi traffici commerciali: portarono in tutto l’Arcipelago prosperità, visitatori e nuovi residenti. Lo dimostra il ritrovamento di un villaggio a Cala Junco (Panarea) con una cinquantina di capanne circolari e ovali, intessute di legname e frasche, capienti per oltre duecento persone. Si svilupparono insediamenti fortificati, spesso recintati da fossati scavati nella roccia. Sorsero nuove forme di organizzazione sociale, che sconvolsero gli arcaici ordinamenti tribali, fondati sulle gerarchie degli anziani. Furono introdotti altri arnesi di offesa (asce, lance, accette levigate, lame di ossidiana e punte di frecce), una nuova industria della selce levigata, un’accentuata evoluzione delle forme economiche e commerciali. Il diffondersi di una varietà di modelli e di stili decorativi nella produzione della ceramica segnala la nascita del gusto artistico. La ricchezza e il peso strategico solleticarono l’appetito dei popoli già organizzati militarmente come gli Ausoni: tra il XIV e il XIII secolo a.C. sotto il comando di Liparo occuparono i sette isolotti dell’arcipelago. Dalle Eolie transitava anche il metallo più ambito, lo stagno, diretto dalla Britannia all’Oriente attraverso lo stretto di Messina. Contemporaneamente nella parte sud-orientale della Sicilia, con epicentro Noto, si affermava la cultura di Castelluccio. Gli scavi nella necropoli hanno portato alla luce ceramiche di tipo egeo in grado di fissare le intense relazioni con Malta e con altre aree del Mediterraneo, su tutte Micene cuore di ogni commercio. Nell’area è stata rinvenuta anche una giara con tracce di olio risalente al 2.000 avanti Cristo, il prodotto più antico. Poco lontano, nei pressi di un’altra necropoli, quella di Grotticelle, dalle parti di Gela, è stata scoperta una «pietra-calendario»: un megalite forato non dalla natura, ma dagli uomini dell’età del bronzo, che lo utilizzavano come orologio solare per misurare le stagioni e gli anni avendo come riferimento i movimenti del sistema astrale. L’isola a tre punte aveva, dunque, già assunto per i contemporanei le sembianze di un luogo mitico, come racconteranno Omero ed Esiodo, ma appariva anche una terra fertile, ricca di foreste, di frutteti, di grano, facile da occupare e più ancora di godersela. Si delineò da subito il suo amaro destino: invasa da tutti e conquistata da nessuno. Una Sicilia, insomma, sempre pronta a ossequiare il vincitore di turno, ma non a consegnargli l’anima. A metà del XIII secolo si presentarono i Sicani. Provenivano dalla penisola iberica; si sarebbero fermati in Settentrione, se i Liguri non li avessero bastonati e costretti alla fuga. Eppure, non faticarono nel sottomettere i residenti, che Tucidide identificava con i giganteschi Ciclopi, della cui stupidaggine avete letto nell’Odissea. I Sicani si stabilirono fra Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo. I loro dirimpettai nella parte orientale erano i Siculi, giunti attorno al XV secolo, di ascendenze latine, probabilmente fra gli abitanti di Albalonga, la progenitrice di Roma. Importarono una primitiva organizzazione sociale, il culto dei morti, l’uso del cavallo con la consuetudine, ancora oggi praticata fra Siracusa e Catania, di apprezzarne a tavola le bistecche. Ma il cavallo era anche un micidiale strumento bellico in tempi di fanteria appiedata: i Siculi lo sfruttarono al meglio nelle guerricciole con i Sicani, obbligati a sottoscrivere in diversi trattati il ridimensionamento del proprio territorio. Alla fine il confine venne fissato lungo il tracciato del fiume Salso, in provincia di Enna. E forse in onore di questo successo i vincitori ottennero di conferire all’isola il proprio nome, derivante da quello del loro re, Siculo. Non erano, viceversa, finiti i guai per i malcapitati Sicani. Pagarono anche la generosità nei confronti di alcuni fuggiaschi da Troia, ai quali era stato concesso d’insediarsi sulla costa trapanese. Li comandava Elimo, tramandato quale figlio illegittimo di Anchise e dunque fratellastro di Enea. Per decenni gli Elimi accolsero profughi ed esuli; si mescolarono così a liguri e a egei, fondarono Segesta ed Erice, crebbero di numero sino ad abbisognare di nuovi spazi. E a chi sottrarli se non ai Sicani, sormontati dal mutato rapporto di forze? La crescita degli Elimi portò il timido affacciarsi di un popolo di valenti marinai, con i quali trafficavano, i Fenici. Di origine semita erano basati nell’odierno Libano. Possedevano la più importante flotta commerciale del Mediterraneo, avevano impiantato colonie su ogni litorale. La Sicilia divenne il riparo dei fenici cacciati dagli insediamenti greci. La prima città fondata fu Mozia sull’isola di San Pantaleo nello Stagnone di Marsala. Le loro attività manifatturiere – la tessitura colorata, la filatura della lana, le opere di concia, la lavorazione del vetro, la distillazione di essenze profumate, la produzione di ornamenti, bronzetti, amuleti e ceramiche – spopolarono tra i residenti ancora legati a stili di vita alquanto primitivi. I nuovi arrivati conclusero ottimi affari, tuttavia ebbero il grande merito di portare l’alfabeto, il più antico tra quelli conosciuti, puramente consonantico, altrettanto prezioso che navi, tessuti, spezie. Da questo alfabeto grazie al futuro inserimento di ogni suono del linguaggio, comprese le vocali, sarebbero derivati gli altri giunti fino a noi, l’ebraico, il greco, il latino, l’arabo, il cirillico. In tale continuo sviluppo rientrò pure la nascita, nell’814, di Cartagine, nord della Tunisia. Talmente lontana dal luogo di partenza dei suoi fondatori, Tiro, da esser chiamata Nuova Città: Kart Hadasht in lingua fenicia, Karchedon in greco, Carthago in latino. Le bastarono pochi decenni per assurgere a epicentro del Mediterraneo occidentale. Crebbe fino a 300mila abitanti, varò la più potente flotta commerciale, cui affidare spezie, sete, attrezzi e soprattutto i prodotti dei magnifici frutteti, uliveti, vigneti sbocciati a gran velocità per la notevole perizia di contadini e agronomi. Cartagine divenne la perfetta pedana di lancio di ogni espansione nel Mediterraneo. E che cosa di più invitante della Sicilia raggiungibile in un giorno di mare? Ottant’anni dopo furono poste le fondamenta di Mabbonath, Palermo, in origine modesto insediamento dei Sicani. Il terzo polo divenne Solunto sul monte Califano, a due chilometri da Santa Flavia, però permangono parecchi dubbi. Gl’indizi archeologici indurrebbero, infatti, a ritenerla città sicana. Sostiene il contrario il sommo Tucidide, cui si devono la gran parte delle notizie sulla Sicilia preellenica, benché le sue fonti, come Antioco di Siracusa, vadano creduti sulla parola. Tucidide afferma che al momento della prima colonizzazione greca, la cittadina fosse occupata dai fenici. Ed è sempre Tucidide a spiegarci che l’emigrazione dei suoi connazionali sia stata la conseguenza delle lotte intestine scatenatisi all’interno delle città-stato al ritorno delle milizie dalla guerra di Troia. Quanti si erano assentati per un decennio trovarono i posti di comando occupati e il loro rango di aristocratici messo in discussione. Per molti l’unica alternativa fu di armare una nave e cercare fortuna assieme ai propri accoliti dapprima in Campania, la Magna Grecia di Ischia e Cuma, in seguito sulla costa orientale della Sicilia. A cominciare dall’VIII secolo a.C. i calcidesi fondarono Naxos, il primo insediamento guidato dall’ateniese Teocle, Messina (Zancle), Catania, Lentini; corinzi e megaresi Siracusa e Augusta (Megara Iblea); cretesi e rodii Gela. Scelte oculate trattandosi di porti lungo la rotta commerciale assai battuta, che collegava il Tirreno allo Jonio grazie allo Stretto di Messina. Continuava a essere la via più breve per approvvigionarsi di metalli: allo stagno si era infatti aggiunto il ferro della Toscana. I rapporti con le altre popolazioni si complicarono immediatamente. I greci avevano trasformato la superiorità culturale, in cui rientrava l’adattamento dell’alfabeto fenicio alle proprie necessità, in strumento di benessere. I locali, perciò, mal sopportavano la formazione, all’interno delle proprie città, di enclavi elleniche dedite alla compravendita di merci e prodotti. Ne pativano la concorrenza e non era stato ancora inventato il protezionismo. Ma l’irritazione si trasformò in profonda avversione a causa delle donne, e qui ciascuno può leggerci l’anticipazione di una consuetudine siciliana dura da sradicare. I greci le avevano lasciate a casa, quindi si rivolsero a quelle che trovarono, sulle quali però vigilavano un marito, un padre, un fratello, un fidanzato. La situazione fu incarognita dalle usanze predatorie dell’epoca: al corteggiamento, alla via diplomatica, che spesso si traduceva nell’acquisto della fanciulla, quasi sempre si preferivano le vie spicce, cioè il rapimento. Il che comportava lo scatenamento di rivalse, di faide, che ci mettevano niente a superare la dimensione familiare e a coinvolgere il buon nome della comunità di appartenenza. Si andò alle armi e gli scontri segnarono un’altra sconfitta di Siculi e Sicani: dovettero abbandonare i ricchi insediamenti sulla costa, retrocedere gradualmente verso l’interno. Ne derivò una tensione continua per la definizione dei confini e per la proprietà dei fiumi. I greci portarono l’ordinamento democratico delle città d’origine. La ferrea divisioni in classi – popolani, borghesi, oligarchi – lasciava spazi alla scalata sociale. Accanto a operai, contadini, commercianti, professori, avvocati, ingegneri sorse una genia di legislatori dei quali il catanese Caronda, lodato da Aristotele, fu il capofila. Ma la prerogativa principale era la difesa o la conquista del territorio. Questo vivere pericolosamente condusse all’affermazione di alcune personalità. Ricevuto o preso il potere, si sforzarono di mantenerlo con qualsiasi strumento. Sul modello greco venivano definiti «tiranno», ma il termine, di origine microasiatica, all’inizio significava «signore della città» e non conteneva l’accezione negativa assunta proprio dopo l’esperienza siciliana. Il primo fu Falaride ad Agrigento (Agrakas) nel 570, per decenni però non ebbe proseliti: tutti concentrati nell’accumulare beni di prima necessità e nel mettere su famiglia non avevano tempo e voglia di occuparsi della gestione della res publica. Gli stessi fenici apparivano lieti della pacifica convivenza: la loro capitale, Mozia, fino al VI secolo fu sfornita di mura e la rappresentanza ellenica vi poté progredire senza ostacoli. Il cambiamento si produsse sul finire del 500 a Gela con l’ascesa di Cleandro, cui succedette il fratello Ippocrate. L’ambizione lo spinse a una scriteriata campagna di conquiste a danno degli stessi connazionali: Messina, Naxos, Lentini entrarono nella sua orbita, sbatté invece contro Siracusa. Deviò allora su un obiettivo minore, Ibla, che rappresenta un bel rebus storico. Ne esistevano tre e Tucidide, Pausania ed Erodoto non sono riusciti ad accordarsi sugli spalti di quale delle tre Ippocrate incontrò la morte. Il suo posto fu preso da Gelone appartenente a una rinomata famiglia gelese, allevato per ascendere alle cariche pubbliche, ma affermatosi da guardia del corpo d’Ippocrate e assassino di Cleandro. L’abilità negli intrighi e la spregiudicatezza gli consentirono di sbarazzarsi dei concorrenti e di resistere alla mancata conquista di Messina, della quale ingolosiva il porto, passaggio obbligato di ogni trasporto marittimo. Ebbe la meglio il tiranno di Reggio, Anassilao, che vi si trasferì lasciando il figlio Leofrone sull’altro lato dello Stretto. Gelone rispose con una mossa geniale: partecipò ai Giochi panellenici di Olimpia e conquistò l’alloro nella corsa delle quadrighe. La fama sportiva suggerì di aprire la corte a poeti e artisti affinché diffondessero nel mondo l’eccellenza di Gela. Ma l’occhio rimaneva ben posato sugli equilibri politici della Sicilia: lo confermò l’inattesa alleanza con Tirone, il tiranno di Agrigento, di cui sposò la figlia Demarete. Un annuncio di burrasca per quanti si fossero rifiutati di entrare nell’orbita del duo. Ad aiutare Gelone provvidero gli agrari (gamoroi) di Siracusa esiliati dai vincitori della disputa elettorale: i popolari (demos) uniti ai figli dei nativi (killichirioi). Ne chiesero l’intervento pacificatore. Entrato da mediatore, Gelone ci mise poco ad assurgere a tiranno con il consenso più o meno esplicito dei litiganti, mentre il fratello Ierone ne assumeva le veci a Gela (485 a.C.). Già polo di attrazione per l’import-export con la madrepatria e con l’Asia, Siracusa aumentò la propria importanza. Lo permisero la crescita demografica, favorita dal trasferimento della popolazione di Gela e di altre cittadine sottomesse con la forza, come Augusta; il rafforzamento della flotta e dell’esercito, il solo contingente dei mercenari salì a 10 mila effettivi. In pochi anni la ricchezza e il prestigio di Gelone varcarono i confini dell’isola. Fu persino in grado di donare quasi mille tonnellate di derrate alimentari alla fresca repubblica di Roma devastata da una brutale carestia. Tuttavia, nel cono occidentale della Sicilia un paio di città si opponevano: Termini Imerese (Imera) e Selinunte, entrambe greche, però in stretti rapporti commerciali con Cartagine. Il contrasto era legato agli affari, ai permessi, alle zone franche, non a caso fu definita dagli storici la «guerra degli emporia». Greci contro greci: il blocco dorico (Siracusa, Gela, Agrigento) contro il blocco calcidese (Reggio, Messina, Termini Imerese). Insomma, una questione di piccioli con l’aggravante che il reggitore di Termini, Terillo, non solo era il suocero dell’inviso Anassilao, ma vantava uno stretto rapporto con Amilcare, il signore di Cartagine, esponente di una dinastia che chiedeva un posto nella Storia. E ai Punici veniva ascritta l’eliminazione, alcuni decenni prima, dello spartano Dorieo, fratello maggiore nientemeno di Leonida, l’eroe delle Termopili. Reduce da sfortunate esperienze militari, Dorieo si era installato nell’area di Trapani (Drepanon) fondando Eraclea, però dava fastidio agli Elimi di Segesta. Con l’aiuto dei Punici era stato attaccato e ucciso assieme ai suoi. «Vendichiamo Dorieo» fu il pretesto adoperato da Tirone per cacciare Terillo da Termini (483). Ai perdenti non rimase che rivolgersi al santo protettore. Amilcare impiegò tre anni per raccogliere fra le città sottomesse a Cartagine 300 mila armati da sbarcare a Palermo. Vi arrivarono però soltanto 200 navi, senza quelle da carico affondate durante una tempesta. Di conseguenza, possiamo immaginare che l’esercito condotto ad assediare Termini non superasse i 100 mila uomini. Una forza comunque impressionante, alla quale le truppe di Terone opposero tenace resistenza. Ma la sola speranza degli assediati consisteva nel soccorso di Gelone, alle prese con un delicato problema politico-strategico. Da Atene e Sparta erano giunti a Siracusa emissari per sollecitare una sua partecipazione al grande sforzo panellenico in vista dell’imminente invasione organizzata dal re persiano Serse. Gelone rifiutò lamentando l’indifferenza di Atene e Sparta ai suoi inviti di unirsi contro Cartagine. Successivamente avrebbe, però, offerto 200 triremi 20.000 opliti (fanteria pesante), 2000 cavalieri, 2000 arcieri e 2000 frombolieri, oltre al rifornimento di grano per tutto l’esercito, in cambio del comando militare, se non dell’armata, almeno della flotta. Conoscendo lo smisurato orgoglio dei greci, poteva essere soltanto un modo elegante di farsi dire no. Come in effetti avvenne. Così Gelone fu libero di dedicarsi al nemico più impellente. Marciò alla volta di Termini con 50.000 fanti e 5.000 cavalieri: una robusta differenza numerica, ma per sua fortuna differenti erano anche le motivazioni. Gli armati di Amilcare non avevano troppo voglia di morire per una Cartagine, che sentivano matrigna. L’esito fu deciso da una delle prime operazioni d’intelligence: Gelone venne avvisato dell’arrivo della cavalleria di Selinunte in sostegno di Amilcare. I suoi cavalleggeri la intercettarono impossessandosi pure delle insegne. Con esse riuscirono a introdursi nell’accampamento avversario e a menar strage dei cartaginesi, fra le vittime anche Amilcare. In quel 480 a.C. la squillante vittoria di Termini fece il paio con quella della flotta greca a Salamina: consentì al mondo ellenico di respingere il doppio assalto di persiani e cartaginesi, d’accordo o no che fossero. Bruciate le navi cartaginesi, Gelone si ritrovò con 10 mila prigionieri: venduti come schiavi contribuirono insieme con il resto del corposo bottino alla prosperità e all’abbellimento di Siracusa, di cui il Teatro Greco rappresentò la perla più luminosa. Fra un paio di secoli sarebbero seguiti quelli di Taormina e di Tusa, nel messinese: assieme avrebbero fornito un contributo determinante alla crescita culturale e più ancora alla prosopopea dei siciliani. Non appena il primo sprovveduto di passaggio avesse provato a mettere in dubbio il loro grado di civiltà, sarebbe stato ripagato dall’immancabile risposta: «Quando i tuoi avi giocavano sugli alberi con le scimmie, i miei già recitavano Eschilo, Euripide, Pindaro e Platone al teatro greco». Gelone si mostrò lungimirante nella gestione del successo. Avuta mano libera nei commerci e ricevuto l’ossequio delle altre città, compresa Selinunte, non perseguitò Anassilao, una cui figlia diverrà moglie di Ierone, e a Cartagine chiese la semplice rinuncia ai sacrifici umani nelle cerimonie religiose. Il gesto contribuì alla sua fama e più ancora a rasserenare i rapporti con l’influente metropoli punica, ritenuta da Gelone indispensabile partner commerciale. Per tre anni poté godersi il frutto delle sue conquiste prima che un edema addominale lo stroncasse. Sul letto di morte indicò quale successore il fratello Ierone, mentre l’altro fratello, Polizelo, ricevette l’incarico di capo militare (stratega). Erano i migliori presupposti per fomentare la rivalità tra i due. Lo schierarsi del popolo con Polizelo, malgrado gl’indubbi benefici economici ricevuti dalla conquista di Catania, di Naxos e dall’arrivo di 5mila coloni dal Pelopponeso, indusse Ierone a instituire un embrione di polizia segreta. La felice spedizione di Polizelo in soccorso degli esuli sibariti angariati da Crotone inasprì la contrapposizione tra i fratelli. Vi s’inserì Terone, che era pure suocero di Polizelo. Sembravano le avvisaglie della guerra civile, ma nello stupore generale, visti anche i tempi, i due contendenti decisero di affidarsi all’arbitrato di un poeta, Simonide di Ceo. Ebbe la meglio Ierone. Risolte in tal modo le questioni interne, poté riprendere la politica interventista di Gelone. Rimesso a cuccia Anassilao – imbaldanzito dal successo olimpico nella corsa dei carri tirati dai muli (480) aveva allargato gl’intrighi da Messina e Reggio a Locri – l’obiettivo divenne Termini. Approfittando della disputa dinastica i suoi indomiti abitanti avevano tentato di scrollarsi di dosso la tirannia agrigentina, rappresentata da Trasideo, il figlio di Terone. Commisero, però, l’errore di rivolgersi a Ierone, che denunciò i loro piani per riallacciare con Terone, di cui aveva anche sposato una nipote. La repressione fu spietata, gli uccisi superarono i sopravvissuti. Un simile uso di forza e cinismo fruttò la richiesta d’aiuto dei greci di Cuma, stremati dalle razzie degli Etruschi. Fu varata una flotta imponente: il cozzo nelle acque prospicienti Cuma regalò una grande vittoria a Siracusa (474). Seguirono accordi commerciali, dislocazione di truppe: l’estensione degli interessi all’area tirrenica implicò un alternarsi di alleanze più impegnative che produttive. Nel 471 il decesso di Terone e la successione di Trasideo ad Agrigento ruppero l’antico legame. Trasideo mobilitò l’esercito, arruolò mercenari, convinse Termini a sollevarsi di nuovo contro Siracusa. Benché malato, Ierone ottenne un’altra eclatante affermazione. Avrebbe voluto dedicare gli ultimi anni al mecenatismo, alle opere d’arte, ai versi elogiativi, un tanto a rima, di Eschilo e Pindaro ospiti prediletti della sua corte, ma il complesso edificio di aggregazioni, conquiste, colonizzazioni scricchiolava. Plutarco ci racconta che nel 466 Ierone fu lapidato fino a spirarne, senza chiarire autore e motivo. Il suo posto fu assunto da Trasibulo, l’ultimo dei quattro fratelli figli di Dinomene, fin lì tiranno di Gela. Il sanguinario dispotismo utilizzato per conservare il doppio dominio gli alienò le simpatie del popolo. Al malcontento dei sudditi si unì quello delle città di antica o di fresca rivalità, da Termini e Selinunte ad Agrigento e Gela. L’intervento di un numeroso contingente di truppe sicule causò nel 465 la cacciata di Trasibulo, la sparizione della dinastia dinomenida, l’instaurazione di una democrazia moderata a Siracusa e nelle città a essa collegate. Ma non cessarono i contrasti, soprattutto con Catania: e a farne le spese furono sempre gli abitanti ora espulsi, ora forzati a rientrare. Nell’assedio di Catania emerse fra le truppe siracusane un ufficiale siculo ellenizzato, Ducezio, forse nativo di Mineo, forse di Noto. I soldati lo ammiravano e dunque ascoltarono con attenzione, soprattutto i discendenti dei nativi arresisi ai greci, il suo richiamo alla rivolta. Attorno a lui si formò una lega sicula capace di tenere in scacco le truppe nemiche. La sua abilità di comandante portò alla distruzione di due importanti capisaldi, Paternò e Morgantina; la crescita demografica di sicani, siculi, elimi e financo dei punici dette l’opportunità di occupare diversi punti strategici, fra i quali la nuova capitale nella piana etnea, Palagonia. Acclamato re, Ducezio guidò un autentico movimento di liberazione contro il quale Siracusa e gli alleati impiegarono dieci anni per abbatterlo. Solamente nel 450 Ducezio fu sconfitto dapprima nei pressi di Noto e poi a San Cataldo, dove venne anche catturato. Esiliato a Corinto, ritornò in Sicilia nel 444 con un piccolo gruppo di greci. Fondò Caronia sull’omonimo monte, alzò nuovamente il vessillo della ribellione, ma si ritrovò solo e malato. Non gli rimase che morire (440). Contemporaneamente a Ducezio tramontò il sogno dell’indipendentismo siciliano. Siracusa ristabilì in toto il proprio ordine, che in seguito sarebbe stato apparentato a quello dei cimiteri. Ma anche questa precaria pace non durò a lungo. Sull’isola si abbatterono le conseguenze della guerra del Peloponneso, Sparta contro Atene, ciascuna con il proprio contorno di alleati. In Sicilia le parti di Atene furono assunte da Lentini, quelle di Sparta da Siracusa: l’una distava dall’altra pochi chilometri, le controversie della madrepatria erano solo la scusa di contrasti molto più spiccioli, basati sulla brama di possesso, cioè di nuovi territori in grado di assicurare ulteriore ricchezza. Nella guerra (427) Catania, Naxos, e Camarina (pochi resti oggi sul colle Cammarana vicino Ragusa) si schierarono con Lentini; Termini e Gela con Siracusa. L’elemento estraneo e, paradossalmente, determinante fu il modesto corpo di spedizione inviato da Atene. Siracusa lo usò per incitare le altre città alla resistenza contro lo straniero. Al termine di piccole schermaglie, accese per salvare la faccia dei contendenti, la pace fu firmata nel 424. Il massimo propugnatore fu il politico siracusano più eminente, Ermocrate, all’occorrente pure abile stratega. La sua allocuzione in favore di un’indipendenza della Sicilia greca, anche a costo di andar contro le origini e la tradizione, colpì talmente Tucidide, che nella sua personale classifica lo piazzò alle spalle dell’inarrivabile Pericle. E dire che Ermocrate si era espresso con durezza contro Atene e in special modo contro la presenza delle sue truppe in Sicilia, le quali, compresa l’antifona, rientrarono in patria. Ma ai reggitori siracusani l’intesa raggiunta non bastava: riuscirono ad accordarsi con il partito oligarchico di Lentini, che si mosse per subentrare al partito popolare. La guerra civile offrì a Siracusa il pretesto dell’intervento: nel 422 Lentini fu rasa al suolo, agli amici oligarchi i siracusani offrirono un’adeguata ospitalità nei nuovi quartieri, con cui la città festeggiava la propria magnificenza. Esauritosi in Grecia, il conflitto si riaccese (416) nella Sicilia occidentale. Siracusa fu proiettata dentro il cono d’ombra delle superpotenze, Atene e Sparta, con l’arrembante Cartagine sullo sfondo. Gl’immancabili sconfinamenti da un territorio all’altro inimicarono Selinunte e Segesta. La prima vantava l’appoggio di Siracusa, la seconda si mise all’affannosa ricerca di un solido contraltare. In nome degli antichi legami venne interpellata Cartagine, ma la risposta fu negativa. Non rimase che rivolgersi alla nemica di Siracusa, cioè Atene. La scomparsa di Pericle aveva privato la gloriosa repubblica della sua mente più lucida. Com’era avvenuto dieci anni prima, anche questo secondo intervento in Sicilia fu deciso al buio, senza aver valutato rischi e controindicazioni ambientali. Sotto la spinta di Alcibiade, membro di spicco della famiglia più aristocratica, prevalse la sicumera di poter occupare l’isola e privare Sparta degli abituali rifornimenti di grano, in vista di una ripresa delle ostilità contro di essa. Gli oracoli, che avevano dato parere avverso, furono sostituiti con altri più accomodanti. Sotto la guida di Alcibiade, Nicia e Lamaco fu allestita nel 415 una squadra navale di 134 triremi, tra le quali, 60 navi veloci, con 5.100 opliti, 700 fanti leggeri, 480 arcieri, 700 frombolieri. Alla vigilia della partenza un inquietante episodio, tuttora misterioso, sconvolse Atene: la mutilazione di tutte le statue raffiguranti Ermes. Per l’epoca era peggio di un sacrilegio. La voce pubblica additò uno dei colpevoli in Alcibiade, accusato di voler minare le basi della democrazia per impiantare la tirannia del suo clan. L’urgenza della missione suggerì di procrastinare il definitivo chiarimento al ritorno dell’armata. Alcibiade, che avrebbe voluto invece far piena luce prima, partì a malincuore. E ne aveva ben donde. All’arrivo a Catania trovò una trireme pronta a riportarlo ad Atene in compagnia degli altri suoi compari accusati dello scempio. Alcibiade chiese di seguirli con la sua nave, invece si rifugiò a Thurii, in Calabria. Fu condannato a morte in contumacia, le proprietà confiscate, una taglia sulla testa. Per evitare l’estradizione fece avvertire i siracusani che il piano strategico dei suoi compatrioti, dopo i primi piccoli successi, comportava l’occupazione di Messina e il controllo dello Stretto. Il contingente ateniese venne così bloccato, il conflitto entrò in stallo. Alcibiade ne approfittò per raggiungere Sparta, mettersi sotto la sua protezione, sollecitare l’invio di rinforzi ai siracusani in difficoltà. Sparta tergiversava, ancora offesa dal rifiuto di Siracusa nel 431 di stringere un patto di mutua assistenza. Gli ammonimenti di Alcibiade sui progetti imperialisti di Atene, del quale era stato il massimo assertore, produssero l’intenzione di valutare l’invio di una modesta forza, 700 opliti guidati da Gilippo. Toccò a Lamaco e a Nicia scoprire che la realtà siciliana era ben differente da quella immaginata ad Atene: le altre città della Magna Grecia avevano rifiutato qualsiasi appoggio all’antica madrepatria; inesistenti le vantate ricchezze di Segesta, con le quali l’alleata avrebbe dovuto contribuire ai costi della spedizione (5.000 talenti, circa 25 miliardi di euro), che avevano dissanguato le casse ateniesi; l’assalto frontale a Siracusa reso impossibile dalle nuove fortificazioni fatte erigere da Ermocrate. Fu tentata una diversione a sud del Porto Grande, ma l’effimero successo era legato all’assenza della cavalleria aretusea. La pausa invernale servì per far giungere da Atene una ventina di navi con 4.000 uomini. Gli ateniesi espugnarono Augusta e Centuripe. Stretta d’assedio, Siracusa nominò due nuovi generali, Euraclide e Sicano, e restrinse da 15 a 3 il numero degli strateghi, l’altro era l’inamovibile Ermocrate. Non bastò per evitare la sorpresa di un attacco notturno: le truppe di Lamaco s’infiltrarono in un quartiere della città. Cominciò la costruzione di un muro per interrompere l’acquedotto e impedire ogni comunicazione dei siracusani con l’esterno. Da lontano Gilippo suggerì l’innalzamento di un contro muro. Fra questi sbarramenti si consumarono diversi scontri dall’esito alterno, la flotta ateniese tentò invano di assestare il colpo decisivo. Nonostante l’uccisione di Lamaco, cui seguì la forzosa promozione di Nicia, più politico che soldato, la situazione di Siracusa peggiorò. Il blocco navale fece sentire i suoi effetti. La popolazione imputò il tracollo al triumvirato, ne impose la sostituzione. Il partito filo ateniese ottenne l’avvio di colloqui con Nicia. A un passo dalla capitolazione si presentò un’imbarcazione corinzia con l’annuncio che Gilippo era in arrivo alla testa di un’armata: ai 700 spartani si erano aggregati un migliaio di siculi e un migliaio d’imeresi. L’abilità del generale spartano risultò subito determinante. La progressione degli invasori fu stoppata in più di un’occasione. A Siracusa importava guadagnare tempo per logorare il nemico, impossibilitato a ricevere rinforzi continui. Fu avviata l’erezione di un secondo e di un terzo muro. Ma la risoluzione decisiva consistette nell’approntare una nuova flotta per sfidare gli aggressori lì dove si sentivano più forti: sul mare. Lo scontro nel Porto Grande risultò caotico: gli ateniesi, appena rinforzati dagli etruschi, gridarono vittoria, tuttavia gli armati di Gilippo, sostenuti dalle navi corinzie, s’impadronirono delle fortificazioni necessarie per dominare tutti gli attracchi. Nelle settimane successive la cavalleria siracusana intercettò i rifornimenti via terra: il cibo cominciò a scarseggiare tra gli assedianti. Emerse in tutta la sua gravità l’impreparazione di Nicia, per di più afflitto da una devastante nefrite. Rifiutava ogni proposta di armistizio, però mancava le occasioni per chiudere la contesa. Demoralizzato, chiese al governo di ritirare gli uomini o d’inviare un altro contingente e un nuovo comandante. Ad Atene vararono una terza spedizione: 73 triremi, 5.000 opliti, un migliaio di arcieri, frombolieri e tiratori agli ordini di Demostene ed Eurimedonte, il primo per le truppe di terra, il secondo per la flotta. Malgrado alcuni successi, le perdite di soldati e materiali, l’insorgere di epidemie spinsero Demostene a suggerire la resa. Nicia rifiutò: confidava ancora nel soccorso del partito filo ateniese a Siracusa. Anche lui però dovette rassegnarsi all’evidenza. La sera in cui fu ordinato di puntare su Catania per imbarcarsi verso casa l’eclissi di luna gettò nello sconforto i soldati: sembrò l’annuncio di una disgrazia. Il 9 settembre 413 a.C. 76 triremi siracusane mossero contro 86 ateniesi. La mossa appariva priva di senso strategico, tuttavia costò la vita a Eurimedonte. Demostene decise di tentare una sortita l’indomani caricando tutti gli uomini sulle rimanenti 115 navi. Ne sortì una battaglia caotica, spezzettata in mille duelli dentro spazi angusti. Negli assalti da nave a nave prevalsero i reparti di Gilippo meglio addestrati e motivati. Il segnale determinante fu il passaggio della squadra etrusca sotto le insegne di Sparta. Invano Demostene provò nei giorni seguenti a convincere gli equipaggi a ingaggiare un’ennesima battaglia. Fu assunta la decisione di marciare verso Catania, ma la cavalleria avversaria costrinse alla deviazione su Gela. I giorni si fecero drammatici per gli esausti fuggitivi. Alzò le mani la retroguardia di Demostene. Il 18 settembre a Fiumara di Noto fu la volta del grosso dell’esercito. Dei 50 mila spediti complessivamente da Atene si salvarono in pochissimi e ancor meno tornarono in patria per confermare la notizia del disastro portata da un viandante. Demostene e Nicia furono processati e giustiziati. 7 mila furono catturati, impiegati nella cave di pietra, infine venduti come schiavi, dopo esser stati marchiati. Plutarco racconta che venisse ridata la libertà ai prigionieri in grado di recitare Euripide. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |