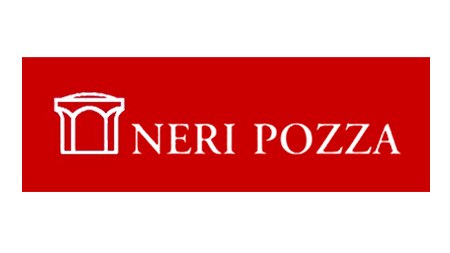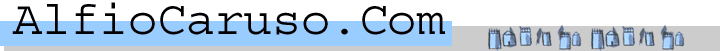 |
|
|
| - Primo capitolo - acquista il libro on line
torna all’archivio
Un altro 2000  Agli italiani che vi sono immersi il nuovo millennio sembra annunciare un’era di fondamentali cambiamenti. Il computer promette di rivoluzionare la nostra esistenza, soprattutto di allungarla preservandola dalle malattie. Il ventunesimo secolo coincide, infatti, con la conoscenza forse più importante, ed inquietante, nella storia dell’Umanità, scaturita per l’appunto dall’impiego contemporaneo di centinaia di computer: la mappa dei geni, che concorrono a fare di ogni essere vivente quella stupenda creatura che è. Avremo la possibilità di studiare e di affrontare molti mali finora inesorabili, ma saremo esposti, noi e le generazioni future, ai rischi insiti nello sfruttamento di ogni grande scoperta, com’è capitato con il ferro, con la polvere da sparo, con la scissione dell’atomo. Agli italiani che vi sono immersi il nuovo millennio sembra annunciare un’era di fondamentali cambiamenti. Il computer promette di rivoluzionare la nostra esistenza, soprattutto di allungarla preservandola dalle malattie. Il ventunesimo secolo coincide, infatti, con la conoscenza forse più importante, ed inquietante, nella storia dell’Umanità, scaturita per l’appunto dall’impiego contemporaneo di centinaia di computer: la mappa dei geni, che concorrono a fare di ogni essere vivente quella stupenda creatura che è. Avremo la possibilità di studiare e di affrontare molti mali finora inesorabili, ma saremo esposti, noi e le generazioni future, ai rischi insiti nello sfruttamento di ogni grande scoperta, com’è capitato con il ferro, con la polvere da sparo, con la scissione dell’atomo. Questo clima di stupore e di attesa ci riporta a un altro 2000, quello avanti Cristo, quando gli abitanti dell’Italia, che ancora è una penisola senza nome, escono dalle caverne in cui vivono per assistere esterrefatti al passaggio di alcune tribù provenienti dal Centro Europa. Non sono turisti, ma emigranti alla ricerca di luoghi più accoglienti dove insediarsi. Succede anche oggi, solo che allora chi giungeva da fuori voleva ripagarsi del viaggio e delle fatiche sottomettendo i residenti. Superate le Alpi, i nuovi arrivati scoprono, come faranno tanti altri in seguito, l’incanto del Belpaese e decidono di metter fine al vagabondaggio. Le loro usanze sconvolgono gli indigeni abituati a rintanarsi nelle caverne per proteggersi dai pericoli esterni. Gli ospiti invece prediligono vivere all’aperto. Costruiscono capanne di sterco e di fango ricoperte con la paglia su travi infisse nell’acqua (da qui la definizione di ’palafitte’); intorno, per proteggerle, alzano bastioni di mota e di terra battuta. Allevano animali (cani, galli, pecore, maiali), coltivano il suolo, tessono le stoffe. E poi posseggono la vera arma segreta dell’epoca: da alcune tribù della loro etnia insediatesi in Germania hanno appreso la lavorazione del ferro. Sono quindi in grado di fabbricare utensili e armi, che li mettono in posizioni di preminenza rispetto a quei poveracci dei locali ancora fermi agli oggetti in pietra. Al Nord sono Liguri e abitano Piemonte, Liguria, una fetta di Lombardia e una di Emilia e Romagna; al Sud sono Siculi e risiedono in prevalenza nella Sicilia. Oltre alla povertà e a una vita densa di pericoli, hanno in comune la testa a forma di pera e un’altezza che non supera il metro e mezzo. Rappresentano l’evoluzione di una specie apparsa al di qua delle Alpi circa 130.000 anni prima. Probabilmente ignorano che nel 3500 in Mesopotamia (la terra in mezzo a due fiumi, il Tigre e l’Eufrate, nell’Asia occidentale, dove allora prosperavano i Babilonesi, i Sumeri, i Persiani e dove ora si trovano l’Iran, l’Iraq, la Siria) è stata inventata la scrittura; che nel 3300 hanno costruito la prima ruota, che nel 3100 sono state edificate le prime case con mattoni di argilla e che nel 3000 in Egitto è comparsa la candela di sego destinata a scacciare definitivamente il buio dalle abitazioni. Differenze abissali tra aree geografiche oggi quasi confinanti, ma cinquemila anni addietro talmente distanti che occorreranno secoli e secoli prima che alcuni avventurosi marinai, i fenici, le mettano in contatto. Finché questo contatto non avverrà è proprio in quella fetta di Africa e di Medio Oriente che incomincia la Storia del Mondo. Lì gli uomini seminano, sperimentano, costruiscono, si fanno la guerra e studiano il Cielo, perché nella loro ricerca di risposte avvertono che lassù agisce il Motore Primo di ogni vicenda. Gli Assiri e i Babilonesi progrediscono a forza d’intuizioni, dunque ignorano che la Luna, la Terra e gli altri corpi celesti intravisti roteano attorno al Sole. Ritengono che siano magie inspiegabili, di conseguenza per secoli e secoli trattano i pianeti come se fossero dei: li pregano, li onorano, li temono. Chiamano i giorni della settimana con il loro nome: Lunedì (Luna), Martedì (Marte), Mercoledì (Mercurio), Giovedì (Giove), Venerdì (Venere), Sabato (che può essere il giorno di Saturno, come nella traduzione inglese, saturday, oppure quello dedicato al riposo se si accetta la radice ebraica di shabbaz), Domenica (anche qui doppio significato: giorno del sole nella traduzione inglese, sunday, oppure il giorno del Signore, Dominus, nel tardo latino). Il progresso cammina in mezzo al deserto, tra fiumi impetuosi come il Nilo, i cui straripamenti rendono ogni anno fertile la terra e costringono i contadini egiziani a prender confidenza con i primi elementi di geometria per ridisegnare i vecchi confini degli appezzamenti spazzati via dalle acque. Non è un caso che la raccolta di leggi più antica, il codice di Hammurabi, provenga da Babilonia, della quale Hammurabi intorno al 1700 fu un re saggio e giusto come si desume dalle sue leggi. L’Umanità ha un debito enorme nei confronti di queste genti, i cui successori adesso sbrigativamente indichiamo come gl’immigrati provenienti dal Terzo Mondo: in realtà è stato il Primo. E se ci spostassimo nell’Oriente ancora più profondo, quello che nei romanzi d’avventura viene tuttora definito ’lontano e misterioso’, resteremmo ammaliati dalle straordinarie invenzioni, che sbocciano in Cina. Essa, però, è talmente ai confini della Terra allora conosciuta che bisognerà veder transitare mille soli e mille lune prima di poter godere delle sue mirabolanti conquiste. Di tanto fiorire - nel 2500 in Egitto vengono realizzate le prime perline di vetro: testimoniano il superamento delle necessità basilari - ben poco o forse niente si sa nelle pianure e negli acquitrini, che si stendono tra le Alpi e gli Appenini. Proprio qui s’installano i popoli giunti dal Centro Europa: sono i Veneti, gli Japigi (affini agli Illirici), gli Umbri, i Sabini, i Volsci, i Latini gli Etruschi. Appartengono al ceppo indoeuropeo, tranne gli Etruschi, figli di padre sconosciuto, ma da qualunque parte siano piovuti, sono comunque una benedizione perché saranno i maestri dei Romani e per secoli ne costituiranno il polo d’attrazione. Gli Umbri, i Sabini, i Volsci, i Latini saranno poi indicati come gli Italici: in origine, però, gli Itali sono una minuscola tribù arroccata fra il golfo di Sant’Eufemia e quello di Squillace. La Penisola è conosciuta come Esperia o Enotria o Ausonia, dal nome di popoli del gruppo latino-siculo. Italia è chiamata una piccola fetta di Calabria, da qui l’appellativo si diffonde, risale il Paese fino a indicarlo nella sua interezza intorno al II secolo a.c.. La prima ’civiltà’ dei nostri antenati risale ai fondatori di Villanova, città nei pressi dell’odierna Bologna. Si allarga alle altre regioni portando con sè l’obbligo di dare una sepoltura ai defunti oppure di cremarli. Chissà, i villanoviani hanno forse appreso che gli uomini al di là del mare, gli Egizi, gli Assiri, i Babilonesi, riservano ai morti grandi onori, che approntano tombe, sarcofaghi, mausolei zeppi di oggetti di lusso e che addirittura i sovrani dell’Egitto, i Faraoni, impiegano migliaia e migliaia di schiavi per erigere altissime piramidi, le quali fungeranno da sepolcro per l’intera famiglia reale. S’inizia il culto dei morti, da quei giorni una costante degli umani costumi. E da noi un preciso giorno dell’anno, il 2 novembre, è dedicato ai defunti: li si visita nei cimiteri portando quegli splendidi fiori autunnali, i crisantemi, che nei paesi di origine, la Cina e il Giappone, sono considerati, invece, fiori ornamentali per eccellenza. Ma in talune regioni del Sud il 2 novembre è un giorno molto atteso dai bambini: al risveglio trovano giocattoli e doni inviati, secondo la tradizione, da chi non c’è più, mentre in realtà sono stati acquistati da genitori e parenti. Mentre gli egiziani si servono già della meridiana per misurare il trascorrere dei mesi e delle stagioni, i nostri avi si regolano con le albe e con i tramonti. D’altronde i loro bisogni sono molto meno raffinati, hanno ancora da difendersi dalle belve, dal freddo e dall’umido degli Appenini, attorno ai quali sono accampati. La ricerca di luoghi più temperati li conduce, intorno al 1000 (quando i cinesi cominciano a utilizzare il carbone come combustibile e il ghiaccio per conservare il cibo), tra la foce del Tevere e la baia di Napoli. Ormai si è sviluppata una mescolanza in cui si sono persi i caratteri distintivi di coloro che una volta erano i residenti e di coloro che erano gli invasori, ma questo non elimina i motivi di attrito. Sorgono una miriade di villaggi. Nel tempo si trasformeranno in grandi città: da Bologna, chiamata Felsinea, a Milano, chiamata Melpo con il contorno di Piacenza, Ravenna, Modena, Parma e di tanti altri capoluoghi del Nord in continuo sviluppo grazie all’influenza etrusca. Lo stesso avviene con gli Umbri, con gli Oschi dai quali derivano i Sanniti, i Sabini, i Volsci, i Marsci e altri ancora di cui si è quasi perso il ricordo. Insomma, sono più o meno tutti imparentati tra loro, abitano in posti che distano pochissimi chilometri l’uno dall’altro, sono angustiati dai medesimi problemi di sopravvivenza, ma ogni scusa è buona per incrociare la daga (la spada corta e robusta in uso all’epoca) e a volte per farli riappacificare non bastano neppure i fulmini delle divinità. L’Italia dei mille campanili, delle infinite dispute comunali è già nata. Il Paese è un gran pentolone in ebollizione sotto il quale accende l’ultimo fuoco l’ennesima corrente migratoria sviluppatasi intorno all’Ottavo secolo: dalla Grecia giungono frotte di coloni smaniosi di nuovi spazi e di terre più fertili di quelle abbandonate nella loro pietrosa Penisola. Divisi in patria, i greci lo sono anche negli insediamenti in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Campania. I Calcidesi fondano Naxos (come dire Taormina), Catania, Messina, Lentini, Reggio e Cuma; i Corinzi Siracusa; i Megaresi Megara Iblea (cioè Augusta); i Dori Crotone, Sybaris, Metaponto; gli Spartani Taranto. Questi immigrati con la puzza sotto il naso, verbosi, litigiosi, individualisti si portano appresso le istituzioni e le regole che hanno trasformato i loro antichi villaggi in città-stato facendone al contempo un modello del vivere civile. Dobbiamo a essi la paroletta magica, che racchiude la forma più avanzata di governo degli uomini: democrazia. Il termine è composto da due sostantivi, demos e kratos, che si traducono con popolo e potere, quindi il potere del popolo, il quale attraverso il voto elegge i propri rappresentanti. Il sogno per cui si sono battuti e sono morti intere generazioni in ciascuno dei cinque Continenti. In realtà nell’ordinamento greco il sostantivo demos non indicava tutti i cittadini, ma soltanto alcune classi sociali. In ogni caso rappresentava quanto di più avanzato si potesse auspicare. Oltre alla paroletta magica, i greci portano un’usanza molto più comune, tuttavia di grande praticità: la maniera di contare gli anni. Per loro il riferimento sono le Olimpiadi. Il nome deriva dal luogo dove sono nate e dove si svolgono ogni quattro anni a partire dal 776: Olimpia, la cittadella consacrata al numero uno degli dei, Zeus. Accanto ai templi, con i quali cercano di accattivarsi il favore di Zeus e della sua turbolenta e dispettosa famiglia, i greci hanno avuto l’accortezza di costruire un campo sportivo: tradotto in soldoni, un’immensa spianata. In occasione dell’appuntamento quadriennale, che fa camminare a braccetto sport e religione, i giovani più prestanti accorrono da ogni angolo della Grecia per inseguire l’alloro olimpico. Non è soltanto amore per lo sport. Oltre alla mitica corona, una vittoria nella lotta, nella corsa a piedi o a cavallo, nel lancio del disco e del giavellotto garantisce tanti concreti privilegi al punto da indurre i più spregiudicati ad accordi sottobanco più o meno leciti, quando non si ricorre all’imbroglio bell’e buono. In pratica la copia conforme di ciò che avviene anche oggi. Eppure il valore simbolico delle Olimpiadi è immenso da subito: si tratta dell’unica occasione in cui vengono interrotte le interminabili guerriciole, che all’ombra delle due città-stato per eccellenza, Sparta e Atene, infestano l’intera Grecia. Di rincalzo ai greci approdano sulle coste del Meridione i più audaci e fantasiosi marinai dell’antichità, i Fenici, gli antenati dei Palestinesi. Provengono da quella fetta di Asia abitata dagli ebrei, con i quali si sono sempre guardati in cagnesco. Le loro città, Tiro e Sidone, sporgono sul mare e da esso traggono nutrimento. Alla pesca i fenici hanno presto aggiunto il commercio. Su barchette appena più grandi di una scialuppa scorrazzano per il Mediterraneo. Nei porti dove attraccano espongono una mercanzia, che fa immediatamente presa: utensili di grande aiuto per la vita quotidiana, monili, stoffe colorate, soprattutto di porpora, che fanno scoprire la vanità alle donne. In mezzo a tanti popoli bellicosi, sempre propensi ad affidano le proprie sorti alle armi, i Fenici sono gli unici a puntare sul commercio. Sono i primi uomini d’affari della Storia. Appena in una zona intravedono la possibilità di concludere accordi vantaggiosi piantano le tende e creano uno scalo commerciale, che spesso crescerà fino a trasformarsi in città. Non volendo imporsi con le armi, i Fenici vengono accolti bene ovunque e sono una manna per chi li ospita giacchè hanno in serbo un dono ancora più prezioso delle loro ambite merci: l’alfabeto. Sì, proprio quell’elenco di 26 vocali e consonanti, studiato sin dal primo giorno di scuola e senza il quale saremmo nei pasticci. A chi sia venuta l’idea e per quale preciso motivo, lo si ignora. Probabilmente, come spesso accade, fu il bisogno. Ai Fenici serviva uno strumento veloce e duttile sia per stilare contratti sia per mandare e ricevere notizie da casa durante le lunghe assenze. I geroglifici degli egizi, la scrittura cuneiforme dei babilonesi erano complessi e laboriosi, da qui la trovata geniale dei 26 segni rappresentanti 26 suoni, con i quali si formano tutti i vocaboli occorrenti. Dopo tremila anni sono scomparsi i fenici, ma il loro modello di scrittura è stato adottato da quasi tutte le lingue del pianeta. Non hanno preoccupazioni di scrittura i latini intenti a espandersi nel basso Lazio. Il loro problema vitale è la ricerca di terre fertili per le colture, per il bestiame. La capitale Albalonga (all’incirca Castelgandolfo), un borgo appena più esteso degli altri, è ormai insufficiente a contenere la crescita della tribù. Soprattutto i più giovani manifestano - come si ripete da tremila anni - voglia di avventure, di un’esistenza diversa da quella dei loro genitori. Un gruppo di essi lascia Albalonga, si dirige al Nord, cioè a una trentina di chilometri, vicino al Tevere. Zona piena di acquitrini, di stagni, con l’insidia della malaria, ma con il vantaggio di essere libera, a disposizione di chi se ne impossessa. E’ proprio ciò che cercano quegli avventurosi coloni - cinquanta, cento? - la cui identità è sconosciuta e per i quali la leggenda si sovrappone alla realtà. Magari nel gruppo ci sono davvero due fratelli, magari i loro nomi hanno qualcosa in comune con Romolo e Remo, magari i due avranno bisticciato, ma la lite, l’aratro che traccia il confine, l’omicidio appartengono alla leggenda. La cruda e misera realtà apparirà squalificante alla Roma del IV secolo, che comincia ad affacciarsi sul mondo con fiere ambizioni. A quegli orgogliosi guerrieri sembrerà impossibile, e soprattutto umiliante, che a dare inizio alla storia, e che storia, siano stati braccianti e pecorai senz’arte né parte. No, occorrevano natali molto più nobili. Si forma così la leggenda di Enea, l’eroe buono dell’Iliade, che, fuggito da Troia in fiamme portando sulle spalle l’anziano padre Anchise e in mano le immagi votive dei defunti, vagabonda in lungo e in largo prima di sbarcare nel Sud dell’Italia. Da qui raggiunge il Lazio, sposa Lavinia, la figlia del re Latino, fonda una città alla quale dà il nome della moglie. In seguito suo figlio Ascanio fonda Alba Longa, sul cui trono dopo circa duecento anni sedevano due loro discendenti, Numitore e Amulio. Ma due è il numero sbagliato se c’è posto per uno solo. Così, quando Amulio decide di essere quell’uno, caccia Numitore, gli uccide tutti i figli maschi e tiene in vita l’unica femmina, Rea Silvia. La confina, però, tra le sacerdotesse della dea Vesta, obbligate al voto di castità. Amulio, infatti, desidera evitare che Rea Silvia abbia figli in grado di vendicare il nonno. Rea Silvia, invece, ha tanta voglia di un figlio, o di un marito, che i suoi segreti pensieri convincono Marte ad accontentarla. E alla ragazza deve sembrare il più appagante dei sogni dato che l’impetuoso dio della guerra la mette incinta mentre dorme. Dalla sbrigativa unione nascono due gemelli, Romolo e Remo, per l’appunto. Zio Amulio però sta in agguato: fa adagiare i gemelli su una piccola e traballante zattera, che poi viene abbandonata sul Tevere nella certezza che le acque del fiume o, caso mai, quelle del Tirreno provvederanno a ingoiarla. In questa parte della leggenda, che sarà rifinita ai tempi di Augusto, si avverte l’influenza di un’altra avventura sul fiume a lieto fine: il miracoloso salvataggio di Mosè dalle acque del Nilo. La futura guida del popolo d’Israele deve la vita alla predilezione del Padreterno, Romolo e Remo la devono, invece, al vento, che conduce la rudimentale zattera su una secca. Richiamata dagli strilli delle due piccole pesti giunge una lupa, che anzichè sbranarli prende ad allattarli: in tal modo si garantirà l’eterna riconoscenza dei romani. Verrà, infatti, eletta a simbolo della città. Tentando poi di umanizzare la leggenda qualcuno sosterrà che la sentimentale e caritatevole bestia fosse una donna in carne e ossa, Acca Larentia, detta ’la lupa’ per i suoi modi selvaggi e per le corna che infliggeva al povero marito. La sostanza della vicenda comunque non muta: Romolo e Remo crescono sani, robusti, ribaldi. Arrivati alla maggiore età, ai due è svelata la loro rocambolesca avventura, il nobile lignaggio da cui discendono, i soprusi subiti dai parenti. Essendo figli di Marte ci mettono un niente a tornare ad Albalonga, a organizzare una rivolta, a uccidere Amulio, a ricollocare sul trono Numitore. Ma le vicissitudini del nonno hanno fatto intendere ai ragazzi che non si può regnare in due: decidono di cercare altrove gloria e spazi capienti per entrambi. La sede prescelta è quella dove la zattera si era arenata: la circondano sette colli. Faticando ad accordarsi sul nome da conferire alla città, anche se al momento sono un paio di casupole e nulla più, salgono Remo sull’Aventino e Romolo sul Palatino. Chi vedrà più uccelli avrà il diritto di scelta. Remo ne vede sei, Romolo dodici: si chiamerà Roma, colei che è destinata a realizzare un Potere mondiale la cui durata è finora imbattuta. Stabilito il nome, bisogna tracciare i confini attorno al Palatino. Due bianchi buoi servono a scavare il solco, lungo il quale viene eretto il primo muro di cinta. Romolo costringe Remo a giurare che uccideranno chiunque oserà oltrepassarle, ma Remo non ha digerito la sconfitta e per dimostrare che quelle mura sono fragili con un gran calcio ne sbriciola una fetta. A Romolo non pare neanche vero di potersi liberare dello scomodo gemello, del timore che se non fosse stato lui a ucciderlo con un colpo di badile, un giorno sarebbe stato Remo a spaccare la sua testa.. Forse è in quest’occasione che viene formulato uno dei più famosi proverbi romani, ’mors tua, vita mea’, per molti, ahinoi, una regola di comportamento. Così l’avventura di Roma s’inizia quel 21 aprile del 753 avanti Cristo. Data tuttora festeggiata nella Capitale e che allora cambiò il modo di contare gli anni, soppiantando la moda greca di fare riferimento alle Olimpiadi. Poi sarebbe arrivato il Cristo e sarebbe cominciata tutta un’altra Storia. - acquista il libro on line torna all’archivio |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |