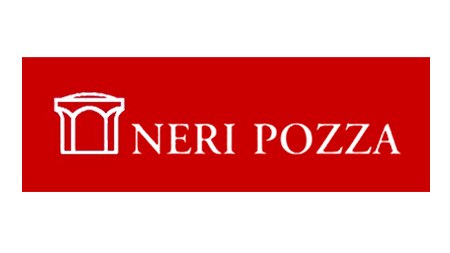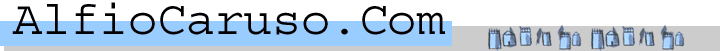 |
|
|
| - Primo capitolo -
acquista il libro on line torna all’archivio Ai siciliani che non si fanno incantare dal clima, dal mare, dal sole, dagli aromi, dagli odori, dagli uomini di rispetto, dagli Amici, dai Bravi Ragazzi, dagli ’sperti e malandrini’, dai gattopardi, dai galantuomini, dai compari. Un mare di tormenti
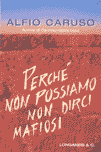 I siciliani non amano il mare. Dicono di esserne grandi appassionati, di non poterne fare a meno, ma è un’esibizione, uno sfoggio di vanità. Adesso che il mare ha soppiantato la montagna, le terme, i laghi quale luogo ideale di vacanza, i siciliani, anche quelli dell’entroterra, tengono a far sapere che il mare ce l’hanno in uso perpetuo e gratuito, che a differenza degli altri non devono andare a cercarselo. Per quanti se ne riempiono gli occhi e i polmoni ogni giorno dell’anno, è un’altra prova della particolare benevolenza divina, la spiegazione più evidente del nostro essere un popolo speciale. Storia e mito si sono alternati su questo mare aspro, mai addomesticato. Scilla e Cariddi; Polifemo e Ulisse; Cartaginesi e Romani; la grande battaglia navale di Milazzo, la prima di cui si parla nei libri di storia; i velieri turchi e la fantasmagorica adunata della flotta cattolica a Messina in attesa del decisivo scontro di Lepanto; per finire con le grandi navi da sbarco alleate nel ’43, l’inizio della campagna europea, che avrebbe condotto alla sconfitta del Fascismo e del Nazismo.
Ce ne facciamo un vanto, ma continuiamo a considerare il mare un nemico, la principale minaccia alla nostra insularità. Vi pare un paradosso? Ma noi siamo tutto un paradosso. Dunque avremmo voluto essere un’isola irraggiungibile. Dal mare invece sono giunti gl’invasori, che comandavano, che depredavano, che figliavano: fenici, greci, cartaginesi, romani, longobardi, bizantini, arabi, normanni, angioini, aragonesi, asburgici, borbonici, piemontesi, americani.
Nel tardo autunno del 1943 il Foreign Office britannico inviò precipitosamente a Palermo un magro e legnoso professore di antropologia dell’università di Cambridge. Si chiamava George Robert Gayre, aveva anche scritto libri di qualche successo. Nei piani del Foreign Office il professor Gayre, che esibiva i gradi di tenente colonnello e collaborava con i servizi segreti, avrebbe dovuto contrastare la dilagante simpatia degli isolani per gli Stati Uniti, per tutto ciò che era a stelle e strisce. Gayre organizzò un corso di antropologia sociale all’università palermitana e un ciclo di conferenze in diversi centri della Sicilia. Sosteneva che nella popolazione s’individuavano due ceppi etnici. Il primo, contraddistinto dai capelli neri e dalla carnagione scura, di chiare ascendenze fenicie e quindi con una mescolanza arabo-africana, anche se l’occhialuto e cauto professore questo non lo diceva esplicitamente avendo percepito che ciò che unisce i siciliani è la permalosità. Il secondo ceppo, contraddistinto da carnagione chiara e occhi azzurri, Gayre lo definiva di netta marca normanna. E fin qui, se volete, eravamo a una felice riscoperta dell’acqua calda. Ma ecco il colpo di scena: Gayre affermò che discendendo dai normanni i siciliani erano cugini alla lontana degli inglesi, anzi "le caratteristiche antropologiche dei siciliani sono molto più vicine a quelle degli anglosassoni che non a quelle degli italiani". Ergo - era la conclusione del professore mezzo spione - è giusto che la Sicilia si separi dall’Italia e magari si federi con la Gran Bretagna. Tesi ribadite qualche mese dopo in un libro ("La posizione della Sicilia nel complesso etnologico europeo") tradotto dal professore messinese Gaetano Martino, liberale, massone, futuro ministro degli Esteri e uno dei padri dell’Europa unita. Gli inviti del professor Gayre caddero nel vuoto, la stagione dell’indipendentismo già svaniva: gli Usa avevano percepito che un’Italia unita era più funzionale agli interessi dell’Alleanza Atlantica.
Delle lezioni di Gayre, delle sue conferenze rimase l’eco di quell’apparentamento con gli anglosassoni, uno dei più arditi mai avanzati. Un professore di filologia romanza dell’università di Catania ci raccontò che avendo condotto alcuni suoi studenti ad ascoltare una conferenza di Gayre il giorno dopo li sentì commentare: "quindi anche gli inglesi hanno preso qualcosa dai siciliani"...
Abbiamo la rara capacità di metterci al centro del mondo, di ritenere che il pianeta giri intorno a noi. Ci viene naturale, non ci costa sforzo. E’ la conseguenza della singolare forma di razzismo che abbiamo sviluppata nei secoli. Nessun desiderio di preservare una purezza oramai impossibile: dai letti delle donne siciliane sono passati rappresentanti di tutti i popoli. Al suo posto un radicato complesso di superiorità. C’è una frase che lo fotografa. Una frase che non udirete mai pronunciare in pubblico, ma che è un ritornello nelle discussioni domestiche, nelle private polemiche di ciascuno ogni qualvolta, cioè sempre, si sente toccato da un’affermazione di chi sta in Continente (per noi incomincia a Reggio Calabria): " Parlano loro, i cui avi giocavano sugli alberi con le scimmie, mentre i miei recitavano già Platone…" Ammesso che sia così, anche i celebrati testi di Platone potevano essere giunti soltanto dal mare assieme a quegli intraprendenti marinai greci e fenici, che ci spalancarono il cammino verso la civiltà. Dobbiamo molto, se non tutto, al mare. Tuttavia non è bastato per indurci a considerarlo una via di ricchezza, di conquiste, di crescita, quale è stato pure nelle traversie che ci ha causato. Prendete l’invasione saracena del nono secolo. Erano pirati, predatori di donne e di bambini, feroci schiavisti, ma dopo che la conquistarono assieme a un fisco esoso regalarono alla Sicilia un periodo di splendore e di gioiosa esistenza. Allorché il resto dell’Italia stava nel buio della storia, angosciata dalle pene dell’inferno, tartassata da carestie ed epidemie, nell’isola si esibivano ballerine indiane e spogliarelliste algerine, si giocava a scacchi, si scopriva la fragrante pasticceria araba, divenuta nei secoli rappresentazione gastronomica della nostra propensione agli eccessi: la frutta candita, le paste di mandorle, la ricotta lavorata con la cannella, con il pistacchio e con il cioccolato. Palermo e Catania si riempirono di quartieri residenziali, le palazzine sfoggiavano grandi terrazze, le stanze erano abbellite da specchiere e candelabri, ogni cortile interno esibiva fontana e piante esotiche, mentre le altre città della Penisola erano casupole addossate l’una sull’altra. Lungo le pubbliche vie i monelli siciliani si guadagnavano la mancia girando con grandi specchi nei quali maschi di tutte le età controllavano l’abbigliamento, la capigliatura. Nello stesso periodo su Roma, su Milano, su Napoli, sui borghi desolati delle valli e delle pianure calava la proibizione del clero di ridere in determinati giorni della settimana.
L’altra faccia di questa medaglia appariscente era la nostra posizione di popolo sottomesso. Facevamo la bella vita, però non comandavamo a casa nostra: noi eravamo i vinti, gli arabi i vincitori. Noi siamo sempre stati i vinti. Vinti da tutti e conquistati da nessuno: non tanto per orgoglio quanto per l’incapacità di sentirci parte di un insieme. Se è vero che ciascuno è la risultante dei libri che ha letto, noi siciliani dobbiamo essere la risultante dei libri che non abbiamo letto. Ci pavoneggiamo con Tomasi di Lampedusa perché il ’Gattopardo’, soprattutto dopo il film di Visconti, è diventato una citazione facile sotto ogni latitudine, ma quasi ignoriamo De Roberto perché ’ I viceré’ continua a essere un coltello nella ferita aperta. Eppure l’uno è un accattivante minuetto retto da un’intelligente operazione nostalgica, l’altro un vibrante atto d’accusa, un racconto e una scrittura intessuti di sangue, di muscoli, di carne. Con anticipo perfino su Sciascia, De Roberto profetizzò che i mali della Sicilia sarebbero diventati i mali dell’Italia.
Ci piacciono i difetti altrui perché ci confortano nella certezza che nessuno sia migliore di noi. Tuttavia inseguiamo il consenso di chi viene da fuori come i girasoli inseguono la luce. La nostra leggendaria e asfissiante ospitalità esprime il bisogno ossessivo di sentirci apprezzati, di sapere che siamo considerati unici, come unici riteniamo che siano il nostro sole, il nostro mare, il nostro clima, il nostro cibo, la nostra intelligenza, la nostra astuzia. Sommergiamo l’ospite, qualsiasi ospite, di doni e di carinerie non per esserne ricambiati, ma affinché egli ci creda sulla parola quando gli racconteremo la nostra verità.
Non abbiamo un grande avvenire dietro le spalle, eppure si insiste nell’inseguire un aureo, ma inesistente passato. Nei mesi scorsi alcuni professori hanno proposto l’abolizione dei ’Promessi sposi’ dal programma scolastico: vorrebbero sostituirli con opere di scrittori siciliani e la preferenza va a Camilleri più che a Verga, perché la lingua di Camilleri è un ibrido permeato sul dialetto e non il perfetto italiano di Verga arricchito dai contributi gergali. Riemerge periodicamente il desiderio di chiuderci in noi stessi, di usare il mare come un barriera invalicabile dagli altri. Nel subconscio di tanti continua a valere ciò che il massimo ideologo dell’indipendentismo, il professore palermitano Mario Canepa, scrisse in ’La Sicilia ai siciliani’: "La Sicilia è un’isola. Da ogni parte la circonda il mare. Dio stesso, nel crearla così, volle chiaramente avvertire che essa doveva rimanere staccata, separata dal continente. Ecco ciò che la geografia c’insegna. Questa separazione non sempre è stata mantenuta. Gli uomini si sono ribellati ai voleri di Dio. E hanno voluto riunire con la forza quei territori che Dio aveva ben separato. Non sono stati, però, i siciliani a passare lo stretto di Messina per andare a comandare sul continente. Sono stati gli uomini del continente a passare lo stretto con la pretesa di venire a comandare in Sicilia".
Nelle ballate dei cantastorie dispensatori di onore e di destrezza persino a chi non li meritava non c’è traccia d’imprese marinare, non si narra di partenze gioiose cariche di aspettative bensì di bastimenti carichi d’emigranti con le lacrime agli occhi. In letteratura, poi, è un mare foriero di tragedie, il mare patrigno dei ’Malavoglia’ e di ’Horcynus Orca’. Un mare di paura e di destini segnati, un mare di sventura e mai di avventura, un mare sul quale non sono cresciuti né grandi condottieri né capitani coraggiosi né esploratori. Un mare considerato quale semplice passatempo e banco di prova delle giovani leve, che, però non ha cresciuto velisti, canoisti, canottieri, nuotatori di piscina e di gran fondo, pallanotisti in grado di primeggiare. Soltanto nell’ultimo decennio il nostro accentuato gusto per il paradosso ha regalato una stupefacente fioritura di pallanotiste.
Lontano dalle chiacchiere salottiere, dalla vanagloria, dalle parole e parole di progetti turistici sempre rimasti sulla carta, il mare non è più la prova di una particolare benevolenza, ma di una condanna divina. I pescatori si sentono gli ultimi dannati della terra, salgono sulle barche con la stessa rassegnazione con cui i minatori gallesi scendevano nelle gallerie sottoterra. Il presente e il passato sono uniti da racconti di sacrifici, di privazioni, di lutti. Tutto si tiene: dall’imperversare degli elementi alle mitragliatrici delle motovedette tunisine e libiche. A esse è riservato il ruolo classico dei cattivi. Ci si addolora per i tragici bollettini di motopescherecci colpiti e catturati nel canale di Sicilia, viene però nascosto che quei motopescherecci hanno invaso le acque altrui e le motovedette, esasperate dal ripetersi di tali infrazioni, hanno semplicemente difeso lo spazio territoriale. Quella dei pescatori è una sfida quotidiana, abbisogna di fegato e di spregiudicatezza. Le doti che sono mancate per impedire a Cosa Nostra di allungare le mani sul mercato del pesce. Uomini che in mare affrontano la morte, a terra diventano succubi di chi li sfrutta, di chi con la sopraffazione succhia la loro stessa vita.
Il pescespada e il tonno costituiscono la ricchezza delle acque siciliane. Per controllarne la vendita si sono combattute sanguinose guerre di mafia. Agli acquirenti quotidiani il pescespada costa dai 25 ai 35 euro al chilo. I pescatori sono costretti a cederlo per 3-4 euro. Una cifra ridicola dalla quale bisogna detrarre il 10% incamerato dalle ’famiglie’ per non tradire l’implacabile legge del ’pizzo’. Va anche peggio con il tonno. Il suo valore commerciale è ridotto, non figura tra i rinomati piatti di pesce fresco. L’eccezione sono i giapponesi, che ne consumano grandi quantità. Gli importatori del Sol Levante trattano grosse partite, ma i pescatori faticano a consorziarsi per venderle direttamente. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno gioco facile nell’imporre i propri intermediari: ai pescatori non vanno mai più di 4 euro a chilo, agli intermediari il quadruplo. Nessuno, però, denuncia. Ogni tanto qualche pestaggio - di cui la vittima non sa indicare responsabili e movente - induce magistratura e polizia a indagare. Scattano gli arresti, i sequestri di società, le confische di beni, poi tutto ritorna come prima.
A Catania esiste un mare dell’innocenza ed esiste un mare dell’ambiguità.
Il mare dell’innocenza è verso sud, in direzione di Siracusa: spiagge di sabbia tenera, acqua opaca, fondali bassissimi pieni di telline. Le mamme ci portano i bambini perché giocano a pallone, perché difficilmente annegano (l’unico pericolo sono le fosse scavate dai pescatori per coltivare le telline), perché trovano compagnia adeguata. Da quelle spiagge siamo passati tutti. I pediatri ne magnificano le virtù curative. Nei sei mesi di sole a picco, di caldo opprimente, di afrori carnali che si mescolano ai profumi delle granite, delle brioches calde, della schiuma dello zabaione, nei sei mesi della lunga estate che incomincia il 1° maggio e finisce il 31 ottobre, si scorgono file di bimbi sdraiati sulla sabbia, i più ubbidienti ne vengono perfino ricoperti. Fanghi rudimentali, che nelle raccomandazioni di nonne e di mamme sono l’antidoto più efficace alle influenze e alle tonsilliti invernali.
Il gran privilegio di nascere e di vivere in Sicilia.
Oggi come ieri viene detto ai siciliani di domani che la Sicilia è un paradiso naturale senza eguali, che è stata creata da Dio in un momento di particolare altruismo, che è amata, desiderata, invidiata in tutto il mondo. Noi ci abbiamo creduto e immaginiamo che ci abbiano creduto quelli che avranno vent’anni nel 2010 e che ci crederanno quelli che avranno vent’anni nel 2020. Ma voltandoci indietro ci accorgiamo che il nostro destino è stato deciso dal treno su cui siamo saliti non per sfuggire a una realtà che comunque amavamo, ma perché c’impedivano di fare l’unico mestiere per il quale ci sentivamo tagliati. Non siamo scampati al peggio per nostra scelta, ma perché un signore ci ha detto no, ci ha indotti a emigrare. Grazie a quel cortese rifiuto abbiamo assistito da lontano al massacro di una generazione dentro cui potevamo essere risucchiati. E sarebbe troppo comodo dire che ci saremmo trovati dalla parte giusta. Sulla sponda del diritto e sulla sponda del sopruso si sono affrontati volti conosciuti, volti amati, volti di ragazzi assieme ai quali abbiamo condiviso gli sbadigli in classe e le partite di calcio sulla spiaggia vicino al mare dell’innocenza. Quanti morti, quante lacrime. Eppure ci sentivamo tutti figli di un Dio Maggiore, l’espressione più riuscita di una razza eletta. Ciascuno è andato a morire per dimostrarlo. Ci si fa ammazzare dalla mafia per gli stessi motivi per i quali la mafia ammazza. L’Eterno Paradosso Siciliano nella sua estrinsecazione più atroce. I camposanti sono pieni di siciliani uccisi per non essersi lasciati incantare dal clima, dal mare, dal sole, dagli aromi, dagli odori, per non aver ceduto alla suggestione degli uomini di rispetto, degli Amici, dei Bravi Ragazzi, degli ’sperti e malandrini’, dei gattopardi, dei galantuomini, dei compari. I migliori di noi sono finiti sotto una croce per testimoniare che esiste un’altra Sicilia, che questa Sicilia non si arrende e non si arrenderà mai, che ci sarà sempre una voce libera pronta ad alzarsi contro l’assuefazione al peggio, contro il ributtante imbroglio che sia esistita una mafia buona, un’onorata società con le sue regole, con i suoi uomini d’onore, con le sue donne sante e ignare di tutto. Nello stesso minuto in cui voi leggete queste righe almeno mille siciliani sono pronti a giocarsi la vita per non partecipare all’immondo carnevale che impazza nelle nostre strade e nelle nostre piazze.
Il mare dell’ambiguità è verso nord, in direzione di Taormina. Ad Aci Castello comincia la riviera dei Ciclopi, dirimpetto ad Aci Trezza si stagliano i Faraglioni (gli enormi coni di pietra lavica scagliati, secondo la leggenda, da Polifemo contro Ulisse in fuga), sotto Acireale sembra di stare dentro un cratere dell’Etna. Questa costa è figlia del vulcano, le rocce hanno l’identica matrice. Un legame fortissimo, saldato da visceri millenarie. Da secoli gli abitanti convivono con la diceria dell’eruzione che si mangerà Catania, ma il vero terrore è il sottosuolo che si scuote, la terra che si apre, il mare che si alza. Quand’è pulita, è l’acqua più verde e più trasparente che si possa trovare. Ma è verde e trasparente un giorno su cento, gli altri novantanove è torbida per gli scarichi delle migliaia di villini sorti lungo la costa in assenza di piani regolatori. Quell’acqua - come potrebbe essere, com’è - rispecchia la Sicilia: come sarebbe potuta essere, com’è. In uno degli angoli più suggestivi della riviera costruirono all’inizio degli anni Settanta un residence. Doveva essere il primo passo per lo sfruttamento turistico della zona. Nell’attesa del secondo passo il residence divenne il luogo di villeggiatura dei fratelli Calderone, i capi della ’famiglia’ mafiosa. Vi trascorrevano l’intera estate assieme a luogotenenti e guardaspalle. Quando furono detronizzati da Santapaola, anche il residence cambiò clientela: a soggiornarvi furono il popolare Nitto, il ragazzo più in gamba della città, e i suoi cari. I quali rimasero ospiti graditi e riveriti anche nei lunghi anni, undici, in cui il capofamiglia, in tutti i sensi, era costretto a fare il latitante.
Siamo sempre stati un mondo a parte. Isolati e soli. Da sempre marginali benché ci atteggiamo a protagonisti. Lontana la Sicilia dalla Capitale di pertinenza; lontani i latifondi dai centri del potere; lontani Enna e Caltanissetta da Palermo e Catania; lontani i paesi dalle città; lontane le campagne dai paesi. I siciliani hanno sempre escluso che ci fosse un giudice a Palermo, a Catania; hanno appreso che poteva essercene uno a Berlino, ma i prussiani, purtroppo, sono stati fra i pochi a non attraversare lo Stretto. All’interno di questa società chiusa le mire e le prepotenze di una minoranza hanno avuto il sopravvento sui sogni, sulle aspirazioni, sui desideri della maggioranza. In ottocento anni è cambiato pochissimo della struttura dei siciliani e dei meccanismi del potere. Dai normanni in avanti la classe dominante ha dato il massimo appoggio a ogni conquistatore. Per un intreccio d’ignoranza, di cecità, di arretratezza civile, solitamente spacciato per superiore qualità umana, gli sfruttati non hanno mai ambito a eliminare gli sfruttatori, bensì a farne parte. Tutti attratti dall’esercizio della supremazia, che spesso si trasforma nell’esercizio della soverchieria. Non abbiamo mai ritenuto che ’u cumannari fosse megghiu du futturi’ per il semplice fatto che il ’futturi’ è parte integrante del ’cumannari’. Che cos’altro è la nascita della mafia se non l’uso dell’arbitrio da parte dei massari nei confronti dei contadini? Un arbitrio protetto dai proprietari terrieri, unici interlocutori dell’autorità, che ai massari chiedevano il soddisfacimento dei bisogni materiali, le rendite per vivere bene in città.
E’ così incominciata una gara al peggio mai conclusasi. A parte le normali eccezioni, non è stata inseguita una maggiore giustizia o minore ingiustizia. I servi della gleba hanno aspirato a diventare massari, i massari proprietari. La voglia indistinta e generalizzata è stata ed è la roba. Un’accumulazione selvaggia: il gusto di possedere, non di fare. Le disfide imprenditoriali non attraevano e non attraggono. Le dinastie del lavoro si contano sulle dita di una sola mano. Da secoli dominano gli stessi cinquanta cognomi e gli stessi dieci nomi in un rincorrersi di nonni, di padri, di nipoti, di cugini, di zii. Hanno avuto e hanno una sola stella cometa: il potere. Per non perderlo hanno tradito, hanno spergiurato, hanno complottato, hanno baciato tutti i deretani continentali in circolazione, si sono truccati ora da sfrenati progressisti ora da seriosi conservatori.
Amiamo il tutto e subito, per questo motivo era piaciuto Internet. Aveva scatenato una sorta di corsa all’oro, sui giornali si è scritto di una ’Etna Valley’: speriamo che sia meno iettatorio di quando Piovene definì Catania la ’Milano del Sud’. Finora il meglio del nostro ingegno l’abbiamo dispiegato nel non sfruttare le strabilianti risorse del clima e della natura. Ma il turismo presuppone organizzazione, rispetto della collettività, tutela d’interessi molteplici. Difficile accordarlo con la voglia esplicita d’imporre il proprio tornaconto, con il timore che se non viene accolto il nostro punto di vista ne riceveremo un danno. Non è soltanto egocentrismo o, peggio, malafede, gioca pure una scarsa educazione a comprendere le ragioni altrui. L’ambiente insegna che soltanto chi prevale merita rispetto. E più i metodi sono spregiudicati, più si è rispettati.
La stessa mafia imprenditrice è una pia invenzione. Le sole imprese che si sono sviluppate l’hanno fatto all’ombra degli appalti pubblici con il capo bastone a fungere da garante e da collettore. Le proteste, le rivolte hanno riguardato la salvaguardia di un privilegio. La nostra storia è piena di episodi nei quali la speranza di un miglioramento si è legata all’intervento del re - fosse quello di Spagna o, addirittura, il Borbone di Napoli - giacché soltanto dal trono poteva giungere una soluzione meno iniqua. La Sicilia non si è mai sollevata nel nome di un bene comune, di un obiettivo condiviso. Persino la fiammata dell’indipendentismo nel ’44-’46 fu espressione di un’esigua minoranza massone, detentrice di sterminati terreni, allacciata con la mafia. Agitando la bandiera di una nazione siciliana, alla quale la maggioranza dei siciliani rimaneva indifferente, il vertice indipendentista difendeva precise convenienze. Coincidevano con i feudi dei possidenti. Costoro temevano la democrazia, temevano la minaccia rossa, temevano di esser costretti a misurarsi con la modernità. Da quel giorno il contesto non è mutato. Ogni volta che appare una sigla indipendentista, ogni volta che un nuovo partito proclama di esser stato fondato per il riscatto della Sicilia, dietro si agita la mafia, dietro si muovono gli intrallazzatori.
Raramente i siciliani militano al servizio di un’idea. Troviamo molto più consono che sia l’idea a mettersi al nostro servizio. Abbiamo allevato generazioni e generazioni di voltagabbana. Ci sono siciliani che hanno indossato più magliette di quanti capelli hanno in testa. A ogni tornata elettorale lo sforzo maggiore è d’intuire su chi si poserà l’aureola del trionfatore. Nelle tante votazioni del 2001 il Polo delle Libertà ha colto una straripante affermazione. Ha giocato a suo favore il desiderio di vendicarsi della pressione imposta per dieci anni dal partito dei professionisti dell’antimafia, tuttavia la spinta maggiore è giunta dalle budella profondamente amorali dell’isola. Un’amoralità ecumenica, che a secondo dei bisogni spazia da destra a sinistra e quindi è in grado di coprire ogni spostamento, ogni alleanza fatta in nome del bottino. Nel dopoguerra questa amoralità ha trovato la sua degna rappresentazione nella democrazia cristiana. Una dc senza nerbo, senza cuore, senz’anima, che sollecitò l’iscrizione dei grandi boss - Vizzini, Genco Russo, Navarra, Sacco, i cugini Greco di Ciaculli - e dei loro picciotti. Sparita la dc, sono comparse altre sigle: ma quella e queste non sono state e non sono che il sembiante del Partito Unico Siciliano, capace al momento opportuno di amalgamare gli interessi più disparati. Il Pus vince sempre: vince con la faccia di Lima, vince con la faccia di Orlando Cascio, vince con la faccia di Miccichè, vince con la faccia di Mattarella, vince con la faccia di La Loggia. Facce importanti, facce che contano: dietro ognuna di esse si dipanano decenni di tradizione, di esperienze, di consolidati rapporti parentali. E i pochi che credono nella Destra e nella Sinistra - ieri fascisti e comunisti, oggi conservatori e progressisti - rimediano la figura di utili idioti, se alleati, di poveri gonzi, se avversari.
Ogni elezione è un mercato a cielo aperto nel quale la mafia sta da pascià. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno bisogno della democrazia per mettere a frutto il bene più prezioso: il ferreo controllo del territorio. In una dittatura senza libere elezioni la mafia appassisce, è ridotta al ruolo di spettatore, come capitò durante il ventennio fascista. Con il sistema dei partiti, quando ogni singola preferenza ha un valore, le azioni di Cosa Nostra volano. Alle elezioni nazionali del maggio 2001 sono stati offerti pacchetti di voto a 100.000 lire l’uno, alle regionali il costo è aumentato in proporzione al numero dei candidati. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno votato e fatto votare rappresentanti di tutti i partiti: l’accordo è con la singola persona, mai con ciò che rappresenta. Gli Amici e i Bravi Ragazzi sono sicuri che nel momento del bisogno la concretezza, i ’piccioli’ - l’appalto da un lato, la tangente dall’altro - prevarranno sul resto: ideologia, disciplina di partito, coerenza personale. In passato è capitato perfino con gli esponenti del vecchio Pci. Erano quelli che spiegavano di non voler criminalizzare i siciliani, Riina compreso; che sostenevano di essere aperti a comprendere le ragioni di tutti. La genia non si è estinta: alcuni esponenti della sinistra sono sotto inchiesta per voto di scambio.
Cosa Nostra racchiude e sublima la zavorra che abbiamo accumulato in trenta secoli di megalomania, di vittimismo, di magniloquenza, di presunzione, di alterigia, di eccesso d’intelligenza. Gli Amici e i Bravi Ragazzi non hanno inventato il peggio della Sicilia, ne sono semplicemente l’espressione più compiuta. I genitori che consegnano il figlio collaboratore di giustizia ai suoi carnefici affinché costoro lavino con il sangue l’onta di avere in casa un ’infame’; la madre che distrugge la lapide della figlia ribellatasi all’omertà e accusatrice degli assassini del padre e del fratello; il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre e che con il proprio silenzio e con la complicità dei parenti copre il vero colpevole, un cugino in ’carriera’, non sono la raccapricciante manifestazione di una mentalità mafiosa, ma il cascame della cultura siciliana.
I siciliani non amano il mare. Dicono di esserne grandi appassionati, di non poterne fare a meno, ma è un’esibizione, uno sfoggio di vanità. Adesso che il mare ha soppiantato la montagna, le terme, i laghi quale luogo ideale di vacanza, i siciliani, anche quelli dell’entroterra, tengono a far sapere che il mare ce l’hanno in uso perpetuo e gratuito, che a differenza degli altri non devono andare a cercarselo. Per quanti se ne riempiono gli occhi e i polmoni ogni giorno dell’anno, è un’altra prova della particolare benevolenza divina, la spiegazione più evidente del nostro essere un popolo speciale. Storia e mito si sono alternati su questo mare aspro, mai addomesticato. Scilla e Cariddi; Polifemo e Ulisse; Cartaginesi e Romani; la grande battaglia navale di Milazzo, la prima di cui si parla nei libri di storia; i velieri turchi e la fantasmagorica adunata della flotta cattolica a Messina in attesa del decisivo scontro di Lepanto; per finire con le grandi navi da sbarco alleate nel ’43, l’inizio della campagna europea, che avrebbe condotto alla sconfitta del Fascismo e del Nazismo.
Ce ne facciamo un vanto, ma continuiamo a considerare il mare un nemico, la principale minaccia alla nostra insularità. Vi pare un paradosso? Ma noi siamo tutto un paradosso. Dunque avremmo voluto essere un’isola irraggiungibile. Dal mare invece sono giunti gl’invasori, che comandavano, che depredavano, che figliavano: fenici, greci, cartaginesi, romani, longobardi, bizantini, arabi, normanni, angioini, aragonesi, asburgici, borbonici, piemontesi, americani.
Nel tardo autunno del 1943 il Foreign Office britannico inviò precipitosamente a Palermo un magro e legnoso professore di antropologia dell’università di Cambridge. Si chiamava George Robert Gayre, aveva anche scritto libri di qualche successo. Nei piani del Foreign Office il professor Gayre, che esibiva i gradi di tenente colonnello e collaborava con i servizi segreti, avrebbe dovuto contrastare la dilagante simpatia degli isolani per gli Stati Uniti, per tutto ciò che era a stelle e strisce. Gayre organizzò un corso di antropologia sociale all’università palermitana e un ciclo di conferenze in diversi centri della Sicilia. Sosteneva che nella popolazione s’individuavano due ceppi etnici. Il primo, contraddistinto dai capelli neri e dalla carnagione scura, di chiare ascendenze fenicie e quindi con una mescolanza arabo-africana, anche se l’occhialuto e cauto professore questo non lo diceva esplicitamente avendo percepito che ciò che unisce i siciliani è la permalosità. Il secondo ceppo, contraddistinto da carnagione chiara e occhi azzurri, Gayre lo definiva di netta marca normanna. E fin qui, se volete, eravamo a una felice riscoperta dell’acqua calda. Ma ecco il colpo di scena: Gayre affermò che discendendo dai normanni i siciliani erano cugini alla lontana degli inglesi, anzi "le caratteristiche antropologiche dei siciliani sono molto più vicine a quelle degli anglosassoni che non a quelle degli italiani". Ergo - era la conclusione del professore mezzo spione - è giusto che la Sicilia si separi dall’Italia e magari si federi con la Gran Bretagna. Tesi ribadite qualche mese dopo in un libro ("La posizione della Sicilia nel complesso etnologico europeo") tradotto dal professore messinese Gaetano Martino, liberale, massone, futuro ministro degli Esteri e uno dei padri dell’Europa unita. Gli inviti del professor Gayre caddero nel vuoto, la stagione dell’indipendentismo già svaniva: gli Usa avevano percepito che un’Italia unita era più funzionale agli interessi dell’Alleanza Atlantica.
Delle lezioni di Gayre, delle sue conferenze rimase l’eco di quell’apparentamento con gli anglosassoni, uno dei più arditi mai avanzati. Un professore di filologia romanza dell’università di Catania ci raccontò che avendo condotto alcuni suoi studenti ad ascoltare una conferenza di Gayre il giorno dopo li sentì commentare: "quindi anche gli inglesi hanno preso qualcosa dai siciliani"...
Abbiamo la rara capacità di metterci al centro del mondo, di ritenere che il pianeta giri intorno a noi. Ci viene naturale, non ci costa sforzo. E’ la conseguenza della singolare forma di razzismo che abbiamo sviluppata nei secoli. Nessun desiderio di preservare una purezza oramai impossibile: dai letti delle donne siciliane sono passati rappresentanti di tutti i popoli. Al suo posto un radicato complesso di superiorità. C’è una frase che lo fotografa. Una frase che non udirete mai pronunciare in pubblico, ma che è un ritornello nelle discussioni domestiche, nelle private polemiche di ciascuno ogni qualvolta, cioè sempre, si sente toccato da un’affermazione di chi sta in Continente (per noi incomincia a Reggio Calabria): " Parlano loro, i cui avi giocavano sugli alberi con le scimmie, mentre i miei recitavano già Platone…" Ammesso che sia così, anche i celebrati testi di Platone potevano essere giunti soltanto dal mare assieme a quegli intraprendenti marinai greci e fenici, che ci spalancarono il cammino verso la civiltà. Dobbiamo molto, se non tutto, al mare. Tuttavia non è bastato per indurci a considerarlo una via di ricchezza, di conquiste, di crescita, quale è stato pure nelle traversie che ci ha causato. Prendete l’invasione saracena del nono secolo. Erano pirati, predatori di donne e di bambini, feroci schiavisti, ma dopo che la conquistarono assieme a un fisco esoso regalarono alla Sicilia un periodo di splendore e di gioiosa esistenza. Allorché il resto dell’Italia stava nel buio della storia, angosciata dalle pene dell’inferno, tartassata da carestie ed epidemie, nell’isola si esibivano ballerine indiane e spogliarelliste algerine, si giocava a scacchi, si scopriva la fragrante pasticceria araba, divenuta nei secoli rappresentazione gastronomica della nostra propensione agli eccessi: la frutta candita, le paste di mandorle, la ricotta lavorata con la cannella, con il pistacchio e con il cioccolato. Palermo e Catania si riempirono di quartieri residenziali, le palazzine sfoggiavano grandi terrazze, le stanze erano abbellite da specchiere e candelabri, ogni cortile interno esibiva fontana e piante esotiche, mentre le altre città della Penisola erano casupole addossate l’una sull’altra. Lungo le pubbliche vie i monelli siciliani si guadagnavano la mancia girando con grandi specchi nei quali maschi di tutte le età controllavano l’abbigliamento, la capigliatura. Nello stesso periodo su Roma, su Milano, su Napoli, sui borghi desolati delle valli e delle pianure calava la proibizione del clero di ridere in determinati giorni della settimana.
L’altra faccia di questa medaglia appariscente era la nostra posizione di popolo sottomesso. Facevamo la bella vita, però non comandavamo a casa nostra: noi eravamo i vinti, gli arabi i vincitori. Noi siamo sempre stati i vinti. Vinti da tutti e conquistati da nessuno: non tanto per orgoglio quanto per l’incapacità di sentirci parte di un insieme. Se è vero che ciascuno è la risultante dei libri che ha letto, noi siciliani dobbiamo essere la risultante dei libri che non abbiamo letto. Ci pavoneggiamo con Tomasi di Lampedusa perché il ’Gattopardo’, soprattutto dopo il film di Visconti, è diventato una citazione facile sotto ogni latitudine, ma quasi ignoriamo De Roberto perché ’ I viceré’ continua a essere un coltello nella ferita aperta. Eppure l’uno è un accattivante minuetto retto da un’intelligente operazione nostalgica, l’altro un vibrante atto d’accusa, un racconto e una scrittura intessuti di sangue, di muscoli, di carne. Con anticipo perfino su Sciascia, De Roberto profetizzò che i mali della Sicilia sarebbero diventati i mali dell’Italia.
Ci piacciono i difetti altrui perché ci confortano nella certezza che nessuno sia migliore di noi. Tuttavia inseguiamo il consenso di chi viene da fuori come i girasoli inseguono la luce. La nostra leggendaria e asfissiante ospitalità esprime il bisogno ossessivo di sentirci apprezzati, di sapere che siamo considerati unici, come unici riteniamo che siano il nostro sole, il nostro mare, il nostro clima, il nostro cibo, la nostra intelligenza, la nostra astuzia. Sommergiamo l’ospite, qualsiasi ospite, di doni e di carinerie non per esserne ricambiati, ma affinché egli ci creda sulla parola quando gli racconteremo la nostra verità.
Non abbiamo un grande avvenire dietro le spalle, eppure si insiste nell’inseguire un aureo, ma inesistente passato. Nei mesi scorsi alcuni professori hanno proposto l’abolizione dei ’Promessi sposi’ dal programma scolastico: vorrebbero sostituirli con opere di scrittori siciliani e la preferenza va a Camilleri più che a Verga, perché la lingua di Camilleri è un ibrido permeato sul dialetto e non il perfetto italiano di Verga arricchito dai contributi gergali. Riemerge periodicamente il desiderio di chiuderci in noi stessi, di usare il mare come un barriera invalicabile dagli altri. Nel subconscio di tanti continua a valere ciò che il massimo ideologo dell’indipendentismo, il professore palermitano Mario Canepa, scrisse in ’La Sicilia ai siciliani’: "La Sicilia è un’isola. Da ogni parte la circonda il mare. Dio stesso, nel crearla così, volle chiaramente avvertire che essa doveva rimanere staccata, separata dal continente. Ecco ciò che la geografia c’insegna. Questa separazione non sempre è stata mantenuta. Gli uomini si sono ribellati ai voleri di Dio. E hanno voluto riunire con la forza quei territori che Dio aveva ben separato. Non sono stati, però, i siciliani a passare lo stretto di Messina per andare a comandare sul continente. Sono stati gli uomini del continente a passare lo stretto con la pretesa di venire a comandare in Sicilia".
Nelle ballate dei cantastorie dispensatori di onore e di destrezza persino a chi non li meritava non c’è traccia d’imprese marinare, non si narra di partenze gioiose cariche di aspettative bensì di bastimenti carichi d’emigranti con le lacrime agli occhi. In letteratura, poi, è un mare foriero di tragedie, il mare patrigno dei ’Malavoglia’ e di ’Horcynus Orca’. Un mare di paura e di destini segnati, un mare di sventura e mai di avventura, un mare sul quale non sono cresciuti né grandi condottieri né capitani coraggiosi né esploratori. Un mare considerato quale semplice passatempo e banco di prova delle giovani leve, che, però non ha cresciuto velisti, canoisti, canottieri, nuotatori di piscina e di gran fondo, pallanotisti in grado di primeggiare. Soltanto nell’ultimo decennio il nostro accentuato gusto per il paradosso ha regalato una stupefacente fioritura di pallanotiste.
Lontano dalle chiacchiere salottiere, dalla vanagloria, dalle parole e parole di progetti turistici sempre rimasti sulla carta, il mare non è più la prova di una particolare benevolenza, ma di una condanna divina. I pescatori si sentono gli ultimi dannati della terra, salgono sulle barche con la stessa rassegnazione con cui i minatori gallesi scendevano nelle gallerie sottoterra. Il presente e il passato sono uniti da racconti di sacrifici, di privazioni, di lutti. Tutto si tiene: dall’imperversare degli elementi alle mitragliatrici delle motovedette tunisine e libiche. A esse è riservato il ruolo classico dei cattivi. Ci si addolora per i tragici bollettini di motopescherecci colpiti e catturati nel canale di Sicilia, viene però nascosto che quei motopescherecci hanno invaso le acque altrui e le motovedette, esasperate dal ripetersi di tali infrazioni, hanno semplicemente difeso lo spazio territoriale. Quella dei pescatori è una sfida quotidiana, abbisogna di fegato e di spregiudicatezza. Le doti che sono mancate per impedire a Cosa Nostra di allungare le mani sul mercato del pesce. Uomini che in mare affrontano la morte, a terra diventano succubi di chi li sfrutta, di chi con la sopraffazione succhia la loro stessa vita.
Il pescespada e il tonno costituiscono la ricchezza delle acque siciliane. Per controllarne la vendita si sono combattute sanguinose guerre di mafia. Agli acquirenti quotidiani il pescespada costa dai 25 ai 35 euro al chilo. I pescatori sono costretti a cederlo per 3-4 euro. Una cifra ridicola dalla quale bisogna detrarre il 10% incamerato dalle ’famiglie’ per non tradire l’implacabile legge del ’pizzo’. Va anche peggio con il tonno. Il suo valore commerciale è ridotto, non figura tra i rinomati piatti di pesce fresco. L’eccezione sono i giapponesi, che ne consumano grandi quantità. Gli importatori del Sol Levante trattano grosse partite, ma i pescatori faticano a consorziarsi per venderle direttamente. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno gioco facile nell’imporre i propri intermediari: ai pescatori non vanno mai più di 4 euro a chilo, agli intermediari il quadruplo. Nessuno, però, denuncia. Ogni tanto qualche pestaggio - di cui la vittima non sa indicare responsabili e movente - induce magistratura e polizia a indagare. Scattano gli arresti, i sequestri di società, le confische di beni, poi tutto ritorna come prima.
A Catania esiste un mare dell’innocenza ed esiste un mare dell’ambiguità.
Il mare dell’innocenza è verso sud, in direzione di Siracusa: spiagge di sabbia tenera, acqua opaca, fondali bassissimi pieni di telline. Le mamme ci portano i bambini perché giocano a pallone, perché difficilmente annegano (l’unico pericolo sono le fosse scavate dai pescatori per coltivare le telline), perché trovano compagnia adeguata. Da quelle spiagge siamo passati tutti. I pediatri ne magnificano le virtù curative. Nei sei mesi di sole a picco, di caldo opprimente, di afrori carnali che si mescolano ai profumi delle granite, delle brioches calde, della schiuma dello zabaione, nei sei mesi della lunga estate che incomincia il 1° maggio e finisce il 31 ottobre, si scorgono file di bimbi sdraiati sulla sabbia, i più ubbidienti ne vengono perfino ricoperti. Fanghi rudimentali, che nelle raccomandazioni di nonne e di mamme sono l’antidoto più efficace alle influenze e alle tonsilliti invernali.
Il gran privilegio di nascere e di vivere in Sicilia.
Oggi come ieri viene detto ai siciliani di domani che la Sicilia è un paradiso naturale senza eguali, che è stata creata da Dio in un momento di particolare altruismo, che è amata, desiderata, invidiata in tutto il mondo. Noi ci abbiamo creduto e immaginiamo che ci abbiano creduto quelli che avranno vent’anni nel 2010 e che ci crederanno quelli che avranno vent’anni nel 2020. Ma voltandoci indietro ci accorgiamo che il nostro destino è stato deciso dal treno su cui siamo saliti non per sfuggire a una realtà che comunque amavamo, ma perché c’impedivano di fare l’unico mestiere per il quale ci sentivamo tagliati. Non siamo scampati al peggio per nostra scelta, ma perché un signore ci ha detto no, ci ha indotti a emigrare. Grazie a quel cortese rifiuto abbiamo assistito da lontano al massacro di una generazione dentro cui potevamo essere risucchiati. E sarebbe troppo comodo dire che ci saremmo trovati dalla parte giusta. Sulla sponda del diritto e sulla sponda del sopruso si sono affrontati volti conosciuti, volti amati, volti di ragazzi assieme ai quali abbiamo condiviso gli sbadigli in classe e le partite di calcio sulla spiaggia vicino al mare dell’innocenza. Quanti morti, quante lacrime. Eppure ci sentivamo tutti figli di un Dio Maggiore, l’espressione più riuscita di una razza eletta. Ciascuno è andato a morire per dimostrarlo. Ci si fa ammazzare dalla mafia per gli stessi motivi per i quali la mafia ammazza. L’Eterno Paradosso Siciliano nella sua estrinsecazione più atroce. I camposanti sono pieni di siciliani uccisi per non essersi lasciati incantare dal clima, dal mare, dal sole, dagli aromi, dagli odori, per non aver ceduto alla suggestione degli uomini di rispetto, degli Amici, dei Bravi Ragazzi, degli ’sperti e malandrini’, dei gattopardi, dei galantuomini, dei compari. I migliori di noi sono finiti sotto una croce per testimoniare che esiste un’altra Sicilia, che questa Sicilia non si arrende e non si arrenderà mai, che ci sarà sempre una voce libera pronta ad alzarsi contro l’assuefazione al peggio, contro il ributtante imbroglio che sia esistita una mafia buona, un’onorata società con le sue regole, con i suoi uomini d’onore, con le sue donne sante e ignare di tutto. Nello stesso minuto in cui voi leggete queste righe almeno mille siciliani sono pronti a giocarsi la vita per non partecipare all’immondo carnevale che impazza nelle nostre strade e nelle nostre piazze.
Il mare dell’ambiguità è verso nord, in direzione di Taormina. Ad Aci Castello comincia la riviera dei Ciclopi, dirimpetto ad Aci Trezza si stagliano i Faraglioni (gli enormi coni di pietra lavica scagliati, secondo la leggenda, da Polifemo contro Ulisse in fuga), sotto Acireale sembra di stare dentro un cratere dell’Etna. Questa costa è figlia del vulcano, le rocce hanno l’identica matrice. Un legame fortissimo, saldato da visceri millenarie. Da secoli gli abitanti convivono con la diceria dell’eruzione che si mangerà Catania, ma il vero terrore è il sottosuolo che si scuote, la terra che si apre, il mare che si alza. Quand’è pulita, è l’acqua più verde e più trasparente che si possa trovare. Ma è verde e trasparente un giorno su cento, gli altri novantanove è torbida per gli scarichi delle migliaia di villini sorti lungo la costa in assenza di piani regolatori. Quell’acqua - come potrebbe essere, com’è - rispecchia la Sicilia: come sarebbe potuta essere, com’è. In uno degli angoli più suggestivi della riviera costruirono all’inizio degli anni Settanta un residence. Doveva essere il primo passo per lo sfruttamento turistico della zona. Nell’attesa del secondo passo il residence divenne il luogo di villeggiatura dei fratelli Calderone, i capi della ’famiglia’ mafiosa. Vi trascorrevano l’intera estate assieme a luogotenenti e guardaspalle. Quando furono detronizzati da Santapaola, anche il residence cambiò clientela: a soggiornarvi furono il popolare Nitto, il ragazzo più in gamba della città, e i suoi cari. I quali rimasero ospiti graditi e riveriti anche nei lunghi anni, undici, in cui il capofamiglia, in tutti i sensi, era costretto a fare il latitante.
Siamo sempre stati un mondo a parte. Isolati e soli. Da sempre marginali benché ci atteggiamo a protagonisti. Lontana la Sicilia dalla Capitale di pertinenza; lontani i latifondi dai centri del potere; lontani Enna e Caltanissetta da Palermo e Catania; lontani i paesi dalle città; lontane le campagne dai paesi. I siciliani hanno sempre escluso che ci fosse un giudice a Palermo, a Catania; hanno appreso che poteva essercene uno a Berlino, ma i prussiani, purtroppo, sono stati fra i pochi a non attraversare lo Stretto. All’interno di questa società chiusa le mire e le prepotenze di una minoranza hanno avuto il sopravvento sui sogni, sulle aspirazioni, sui desideri della maggioranza. In ottocento anni è cambiato pochissimo della struttura dei siciliani e dei meccanismi del potere. Dai normanni in avanti la classe dominante ha dato il massimo appoggio a ogni conquistatore. Per un intreccio d’ignoranza, di cecità, di arretratezza civile, solitamente spacciato per superiore qualità umana, gli sfruttati non hanno mai ambito a eliminare gli sfruttatori, bensì a farne parte. Tutti attratti dall’esercizio della supremazia, che spesso si trasforma nell’esercizio della soverchieria. Non abbiamo mai ritenuto che ’u cumannari fosse megghiu du futturi’ per il semplice fatto che il ’futturi’ è parte integrante del ’cumannari’. Che cos’altro è la nascita della mafia se non l’uso dell’arbitrio da parte dei massari nei confronti dei contadini? Un arbitrio protetto dai proprietari terrieri, unici interlocutori dell’autorità, che ai massari chiedevano il soddisfacimento dei bisogni materiali, le rendite per vivere bene in città.
E’ così incominciata una gara al peggio mai conclusasi. A parte le normali eccezioni, non è stata inseguita una maggiore giustizia o minore ingiustizia. I servi della gleba hanno aspirato a diventare massari, i massari proprietari. La voglia indistinta e generalizzata è stata ed è la roba. Un’accumulazione selvaggia: il gusto di possedere, non di fare. Le disfide imprenditoriali non attraevano e non attraggono. Le dinastie del lavoro si contano sulle dita di una sola mano. Da secoli dominano gli stessi cinquanta cognomi e gli stessi dieci nomi in un rincorrersi di nonni, di padri, di nipoti, di cugini, di zii. Hanno avuto e hanno una sola stella cometa: il potere. Per non perderlo hanno tradito, hanno spergiurato, hanno complottato, hanno baciato tutti i deretani continentali in circolazione, si sono truccati ora da sfrenati progressisti ora da seriosi conservatori.
Amiamo il tutto e subito, per questo motivo era piaciuto Internet. Aveva scatenato una sorta di corsa all’oro, sui giornali si è scritto di una ’Etna Valley’: speriamo che sia meno iettatorio di quando Piovene definì Catania la ’Milano del Sud’. Finora il meglio del nostro ingegno l’abbiamo dispiegato nel non sfruttare le strabilianti risorse del clima e della natura. Ma il turismo presuppone organizzazione, rispetto della collettività, tutela d’interessi molteplici. Difficile accordarlo con la voglia esplicita d’imporre il proprio tornaconto, con il timore che se non viene accolto il nostro punto di vista ne riceveremo un danno. Non è soltanto egocentrismo o, peggio, malafede, gioca pure una scarsa educazione a comprendere le ragioni altrui. L’ambiente insegna che soltanto chi prevale merita rispetto. E più i metodi sono spregiudicati, più si è rispettati.
La stessa mafia imprenditrice è una pia invenzione. Le sole imprese che si sono sviluppate l’hanno fatto all’ombra degli appalti pubblici con il capo bastone a fungere da garante e da collettore. Le proteste, le rivolte hanno riguardato la salvaguardia di un privilegio. La nostra storia è piena di episodi nei quali la speranza di un miglioramento si è legata all’intervento del re - fosse quello di Spagna o, addirittura, il Borbone di Napoli - giacché soltanto dal trono poteva giungere una soluzione meno iniqua. La Sicilia non si è mai sollevata nel nome di un bene comune, di un obiettivo condiviso. Persino la fiammata dell’indipendentismo nel ’44-’46 fu espressione di un’esigua minoranza massone, detentrice di sterminati terreni, allacciata con la mafia. Agitando la bandiera di una nazione siciliana, alla quale la maggioranza dei siciliani rimaneva indifferente, il vertice indipendentista difendeva precise convenienze. Coincidevano con i feudi dei possidenti. Costoro temevano la democrazia, temevano la minaccia rossa, temevano di esser costretti a misurarsi con la modernità. Da quel giorno il contesto non è mutato. Ogni volta che appare una sigla indipendentista, ogni volta che un nuovo partito proclama di esser stato fondato per il riscatto della Sicilia, dietro si agita la mafia, dietro si muovono gli intrallazzatori.
Raramente i siciliani militano al servizio di un’idea. Troviamo molto più consono che sia l’idea a mettersi al nostro servizio. Abbiamo allevato generazioni e generazioni di voltagabbana. Ci sono siciliani che hanno indossato più magliette di quanti capelli hanno in testa. A ogni tornata elettorale lo sforzo maggiore è d’intuire su chi si poserà l’aureola del trionfatore. Nelle tante votazioni del 2001 il Polo delle Libertà ha colto una straripante affermazione. Ha giocato a suo favore il desiderio di vendicarsi della pressione imposta per dieci anni dal partito dei professionisti dell’antimafia, tuttavia la spinta maggiore è giunta dalle budella profondamente amorali dell’isola. Un’amoralità ecumenica, che a secondo dei bisogni spazia da destra a sinistra e quindi è in grado di coprire ogni spostamento, ogni alleanza fatta in nome del bottino. Nel dopoguerra questa amoralità ha trovato la sua degna rappresentazione nella democrazia cristiana. Una dc senza nerbo, senza cuore, senz’anima, che sollecitò l’iscrizione dei grandi boss - Vizzini, Genco Russo, Navarra, Sacco, i cugini Greco di Ciaculli - e dei loro picciotti. Sparita la dc, sono comparse altre sigle: ma quella e queste non sono state e non sono che il sembiante del Partito Unico Siciliano, capace al momento opportuno di amalgamare gli interessi più disparati. Il Pus vince sempre: vince con la faccia di Lima, vince con la faccia di Orlando Cascio, vince con la faccia di Miccichè, vince con la faccia di Mattarella, vince con la faccia di La Loggia. Facce importanti, facce che contano: dietro ognuna di esse si dipanano decenni di tradizione, di esperienze, di consolidati rapporti parentali. E i pochi che credono nella Destra e nella Sinistra - ieri fascisti e comunisti, oggi conservatori e progressisti - rimediano la figura di utili idioti, se alleati, di poveri gonzi, se avversari.
Ogni elezione è un mercato a cielo aperto nel quale la mafia sta da pascià. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno bisogno della democrazia per mettere a frutto il bene più prezioso: il ferreo controllo del territorio. In una dittatura senza libere elezioni la mafia appassisce, è ridotta al ruolo di spettatore, come capitò durante il ventennio fascista. Con il sistema dei partiti, quando ogni singola preferenza ha un valore, le azioni di Cosa Nostra volano. Alle elezioni nazionali del maggio 2001 sono stati offerti pacchetti di voto a 100.000 lire l’uno, alle regionali il costo è aumentato in proporzione al numero dei candidati. Gli Amici e i Bravi Ragazzi hanno votato e fatto votare rappresentanti di tutti i partiti: l’accordo è con la singola persona, mai con ciò che rappresenta. Gli Amici e i Bravi Ragazzi sono sicuri che nel momento del bisogno la concretezza, i ’piccioli’ - l’appalto da un lato, la tangente dall’altro - prevarranno sul resto: ideologia, disciplina di partito, coerenza personale. In passato è capitato perfino con gli esponenti del vecchio Pci. Erano quelli che spiegavano di non voler criminalizzare i siciliani, Riina compreso; che sostenevano di essere aperti a comprendere le ragioni di tutti. La genia non si è estinta: alcuni esponenti della sinistra sono sotto inchiesta per voto di scambio.
Cosa Nostra racchiude e sublima la zavorra che abbiamo accumulato in trenta secoli di megalomania, di vittimismo, di magniloquenza, di presunzione, di alterigia, di eccesso d’intelligenza. Gli Amici e i Bravi Ragazzi non hanno inventato il peggio della Sicilia, ne sono semplicemente l’espressione più compiuta. I genitori che consegnano il figlio collaboratore di giustizia ai suoi carnefici affinché costoro lavino con il sangue l’onta di avere in casa un ’infame’; la madre che distrugge la lapide della figlia ribellatasi all’omertà e accusatrice degli assassini del padre e del fratello; il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre e che con il proprio silenzio e con la complicità dei parenti copre il vero colpevole, un cugino in ’carriera’, non sono la raccapricciante manifestazione di una mentalità mafiosa, ma il cascame della cultura siciliana.
- acquista il libro on line torna all’archivio |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |