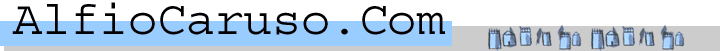
|
|
|
|
1
All’inseguimento di una palla
(1887-1918)
 Il 15 maggio 1910 è una domenica. A Milano il cielo è bigio. Il più emozionato di tutti è forse Umberto Meazza. Passeggia lungo i Navigli prima di salire sul tram elettrico, lui che ricorda benissimo l’ultimo tram a cavalli. Compie l’intero percorso del centro: via San Vittore, piazza Sant’Ambrogio, via Sant’Agnese, corso Magenta, via San Giovanni sul Muro, via Dante, via Mercanti. Poi prosegue a piedi fino ai portici dietro piazza Duomo. Qui ci sono le sale del ristorante Orologio. In mezzo ai camerieri intenti a preparare i tavoli per il pranzo domenicale, Umberto si ritaglia un cantuccio per sfogliare il Corriere della Sera. L’apertura del giornale è dedicata alla riforma della tassa sugli affari. Di spalla campeggiano le dichiarazioni del governo Luzzatti sugli scontri fra operai e reali carabinieri in Romagna. Meazza scorre frettolosamente le pagine, si sofferma appena sugli ultimi echi della successione di Giorgio V a Edoardo VII sopra il trono imperiale britannico; sulla rievocazione della battaglia di Calatafimi a firma di Alessandro Luzio, è il cinquantenario dei Mille; sulla suora francese decorata con la Legion d’Onore, ma denunciata per truffa da un gioielliere parigino in Avenue de l’Operà: gli aveva sottratto preziosi del valore di 580 mila lire (poco più di 2 milioni di euro). Finalmente in fondo al giornale Meazza trova l’articolo che cercava: due mezze colonne a centro pagina. Sotto l’occhiellino Football, il titolo recita: "Italia contro Francia - L’incontro delle due squadre nazionali a Milano".
Meglio di niente, però Meazza confidava in un po’ di considerazione in più: l’incontro viene pure disputato all’Arena. Con che invidia Meazza guarda lo spazio e l’attenzione dedicati all’imminente conferenza romana dell’esploratore statunitense Robert Peary alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Un mezzo lestofante questo Peary, sbrigativo l’anno prima ad annunciare di aver toccato il Polo Nord, mentre si era fermato, nella più favorevole delle ipotesi, 5 miglia prima. L’articolo sulla nazionale di calcio è quasi un comunicato stampa, le formazioni sono ignote, il pronostico è definito incerto. La squadra transalpina ha incassato sonore scoppole nei due incontri fin qui disputati - 10-1 a Londra contro l’Inghilterra, 4-0 contro il Belgio a Parigi -, l’Italia è al suo esordio e nessuno ne conosce lo spessore, neppure Meazza, benché figuri quale allenatore, scelto da una commissione tecnica composta da sei dirigenti di quattro società milanesi. Umberto ha ventotto anni, un solido passato da sportman, cioè di gran curioso di molte attività agonistiche, una laurea in legge, una professione di avvocato esercitata nel tempo libero, ma di tempo libero il football da un anno chiamato calcio gliene lascia ben poco. Meazza è dirigente, arbitro, organizzatore d’incontri, componente della neonata federazione, quando può, continua pure a giocare. I sussurri della città lo indicano come il più fuori di testa dei fuori di testa, che corrono dietro il pallone.
Il Paese palpita per le sorti di tre rarissimi esemplari d’uccelli, i ’Cavalieri d’Italia’ appartenenti alla famiglia degli scolopacidi, feriti dalle fucilate di un improvvido cacciatore della borgata di Zinola, vicino Genova, mentre si rivela abbastanza tiepido nei confronti del pallone. Al pari dell’automobilismo è considerato un simbolo della modernità. Rompe gli schemi tradizionali dello sport unendo forza fisica e leggerezza di movimenti; si pratica in gruppo, ma conta l’individualità. Coloro che hanno buone letture alle spalle ripetono il motto dei moschettieri di Dumas: tutti per uno, uno per tutti.
A portare la prima sfera di cuoio in Italia è stato, nel 1887, un commerciante torinese di origine svizzere, Edoardo Bosio, lo stesso volto sputato di Freddy Mercury. Trattava articoli ottici, gli affari l’hanno spesso condotto in Inghilterra: lì ha scoperto la disciplina, che insieme con il rugby ha conquistato i cuori dei cittadini dell’unica potenza mondiale. I dipendenti di Bosio si sono impratichiti con il gioco, due anni dopo li ha sfidati una squadra imbottita di giovin signori savoiardi, il duca degli Abruzzi, il marchese Ferrero di Ventimiglia, il conte Nasi. Proletari e patrizi si sono mescolati in allegria fra gran pedate e scarsa tecnica. Non si parlava di tattiche, la tentazione era di correre tutti dietro il pallone. Esisteva già il fuorigioco, la porta misurava due metri e mezzo d’altezza per sette di larghezza, si avanzava palla al piede fino a consegnarla all’avversario, i passaggi non si usavano. La confusione dominava sovrana.
Molti degli adepti provenivano dalle società di ginnastica e di scherma. I cultori di spaccate e giravolte, di parate e risposte guardavano con snobistico cipiglio quanti emergevano dalla polvere di quei campi di sterpi a malapena delimitati con lo spago. Lo chiamavano «gioco di società con i piedi importato dall’Inghilterra». Per motivi di noblesse la plebea attività veniva sconsigliata ai soci. Allora molti sono fuoriusciti, hanno creato nuovi sodalizi. La preparazione di base acquisita nelle palestre ha consentito agli ex ginnasti di primeggiare. L’epoca è refrattaria all’attività fisica: la si fa sgobbando nei campi o durante la ferma. Ogni disciplina è praticata in maniera empirica, di allenatori se ne vedono pochi. Gli atleti sono autodidatti: si cresce e si migliora sulla spinta dell’esperienza. Il fisico risulta una macchina sconosciuta, le sue possibilità, i suoi limiti tutti da scoprire. I gran borghesi si dedicano all’equitazione, alla scherma, alle rombanti automobili; la ginnastica s’adatta agli studenti; i proletari si rivolgono al ciclismo, le cui corse appaiono una sorta di massacro organizzato: vince chi resiste in sella; l’atletica incomincia a far proseliti sulla scia delle Olimpiadi ridestate nel 1896 dal barone De Coubertin. Con la sua aspirazione alla presunta purezza incarnata da un dilettantismo totale, il nobile francese ha riservato lo sport soltanto ai parigrado, gli unici a poter disporre del tempo libero per allenarsi. Ne discende che dopo un approccio iniziale spesso dettato dal gusto della scoperta, ciascun aspirante atleta ha dovuto fare i conti con la disponibilità economica. Terminate le dodici ore in fabbrica, al tornio, nei cantieri edili, sulle zolle agresti, allenarsi è dura per chiunque. La passione può anche essere smisurata, ma se ci fossero pure un paio di lirette, il sacro fuoco si accenderebbe ancora meglio. Dunque non stupisce che pure il calcio, al pari delle altre attività agonistiche, si sia sviluppato soprattutto nel triangolo Torino-Milano-Genova, dove un po’ di benessere ha toccato la popolazione. Studenti e perditempo cominciano ad essercene in discreto numero e chi ha il problema del pane e companatico qualche modesto compenso sottobanco lo può arraffare.
L’Italia conta 35 milioni di abitanti, 16 milioni sono analfabeti, 10 milioni con la seconda o la terza elementare, i laureati sono soltanto 50 mila. Fatta eccezione per un po’ d’industria al Nord, dominano l’agricoltura e la pastorizia. In ogni regione, in particolare negli sterminati latifondi del Meridione, la fame è tanta e si porta appresso la pellagra, il vaiolo, la tubercolosi. Dal Veneto alla Sicilia l’emigrazione sembra a molti l’unica speranza di un domani migliore: dall’inizio del secolo otto milioni di persone hanno lasciato l’Italia. In politica domina Giovanni Giolitti, piemontese taciturno e musone, primo capo di governo senza benemerenze risorgimentali. Nel 1910 si è però tirato in disparte presentendo aria di burrasca per la riforma elettorale. Nelle liste sono iscritti tre milioni di cittadini: il progetto del nuovo capo di governo, l’economista Luigi Luzzatti, vorrebbe estendere il suffragio a tutti gli alfabetizzati, cioè un altro milione e mezzo di persone. Una cifra assai contenuta, tuttavia in grado di spostare gli equilibri politici a favore della parte conservatrice: verrebbero, difatti, coinvolte le masse rurali assai legate alla Chiesa e ostili ai sindacati. Di conseguenza i partiti di sinistra sono contrarissimi al progetto di Luzzatti, tuttavia non possono opporsi a una riforma smaccatamente democratica: si sono nascosti dietro l’assoluta necessità del suffragio universale, donne escluse beninteso. E su questo irraggiungibile tutto e subito il Parlamento si è infognato.
Accanto alla maggioranza giolittiana misuratamente riformista, ma irrimediabilmente spaccata, si agitano le forze che non hanno fatto il Risorgimento e sono cresciute sul suo rifiuto, cattolici e socialisti. I primi hanno preso a frequentare le urne, benché dicano di farlo a titolo personale: il Non expedit (Non conviene) pronunciato da Pio IX è stato attenuato nel 1905 dall’enciclica, Il fermo proposito, di Pio X. I secondi oscillano fra l’estremismo barricadiero e un cauto progressismo. Un esempio lo fornisce proprio la netta divisione sul valore dello sport (abbreviazione inglese del francese arcaico se desporter, in italiano diporto cioè svago, divertimento). Al terzo congresso dei giovani socialisti la quasi totalità dei partecipanti si pronuncia contro qualsiasi impegno sportivo: viene accusato di debilitare il corpo umano contribuendo alla degenerazione della specie. L’Avanti invita i lettori e i compagni a boicottare le corse ciclistiche seminando chiodi lungo il percorso. A insorgere, sullo stesso Avanti, è un big del partito, Ivanoe Bonomi: scrive che la bici ha avuto il merito di accorciare le distanze fra le classi, di essere lo strumento di una nuova democrazia.
Il football è rimasto lontano dalle polemiche. L’ha lodato un rivoluzionario come Gramsci: «Un modello della società individualistica, vi si esercita l’iniziativa, ma essa è definita dalla legge». Ha conosciuto uno sviluppo uniforme da un estremo all’altro della Penisola, tuttavia, appena superato il Po a Piacenza, le informazioni scarseggiano. Il clou dell’attività si è quindi concentrato all’interno del triangolo industriale, malgrado esista dal 1898 un organismo ufficiale, la Federazione italiana football (Fif) incaricato di provvedere alla sua diffusione. Il congresso è avvenuto in marzo a Torino dietro sollecitazione di tre società cittadine - Internazionale, Ginnastica, Football club - alle quali si è unito il Genoa. Alla vigilia della riunione è stato disputato al Velodromo un triangolare tra Internazionale, Ginnastica e Football Club, il cui vicepresidente, il marchese Alfonso Ferrero di Ventimiglia ha richiesto con lettera al sindaco la presenza di otto guardie municipali per garantire l’ordine. Il sindaco le avrebbe accordate, a patto che le società si assumessero le spese del servizio. Al termine della laboriosa trattativa il marchese ha dichiarato di essere «pronto a soddisfare il regolare pagamento», 6 lire, di tre guardie. Dalla relazione di una di esse, il vice brigadiere Torchio, sappiamo che ogni partita è durata 45 minuti e che il pubblico non superava le 500 unità, in gran parte «studenti e persone di nazionalità estere».
Altre società, come l’Alessandria e le milanesi, non hanno aderito all’iniziativa di consorziarsi per protesta contro l’egemonia piemontarda. Il cervello della svolta è stato un comitato presieduto dal conte Enrico d’Ovidio, illustre accademico, personaggio di punta del partito liberale, vicepresidente della Società Ginnastica, nella quale hanno appena lanciato la sezione calcio. Totalmente ignorante di pallone, D’Ovidio ha accettato l’incarico per le supplichevoli pressioni di un suo ex allievo di gran prestigio, il duca degli Abruzzi alla vigilia delle famose esplorazioni, innamorato perso dell’anglofilo passatempo e persuaso che abbia bisogno di una guida dall’indiscusso prestigio. Accanto a D’Ovidio si è indaffarato un attempato ingegnere, Mario Vicary, esperto in opere pubbliche, appassionatosi al pallone durante le trasferte in Europa. Insomma, sin dall’inizio sono un nobile e un gran borghese a guidare le sorti di un fenomeno, che nella sua storia secolare sarà sempre in mano a dilettanti raramente di pregio, privi di qualsiasi esperienza diretta, sospinti dall’ambizione più che da una disinteressato trasporto.
D’Ovidio ha dunque presieduto la costituente, Vicary dopo dieci giorni è stato nominato presidente della Fif. La sede è stata fissata in un famoso negozio di maglierie e cravatte, in piazza Castello, all’angolo di via Barbaroux: appartiene a un commerciante inglese, Adolf Jordan, designato segretario per la sua competenza. Ma a seppellire la notizia hanno provveduto le cannonate di Bava Beccaris contro i dimostranti milanesi. Due mesi più tardi, l’8 maggio, è stato assegnato, in una sola giornata, il primo titolo italiano. Hanno partecipato le quattro società fondatrici della Federazione. In gennaio a ranghi misti si erano affrontate a Genova sull’accidentato campaccio di Ponte Carrega, accanto al torrente Bisagno: avevano vinto gli ospiti torinesi. Il marchese Ventimiglia ne ha lasciato un effervescente resoconto, il padre dei miliardi d’articoli che saranno successivamente dedicati al calcio. Sul terreno del Velodromo torinese il Genoa al mattino ha eliminato la Ginnastica per 2-1, l’Internazionale il Football club per 1-0. Nella finale del pomeriggio ha prevalso, al termine dei supplementari, il Genoa per 2-1, arbitro di tutti gl’incontri l’instancabile Jordan. Quando hanno saputo del torneo a Udine si sono levate alte proteste. Alla Società Udinese ginnastica e scherma erano convinti di esser loro i campioni in carica avendo vinto il torneo organizzato sulla spianata trevigiana di Piazza d’Armi dal 6 all’8 settembre del 1896. A poche settimane dalla conclusione ad Atene dei primi giochi olimpici dell’era moderna, la Società ginnastica velocipedistica trevigiana aveva pensato a una piccola replica locale con la disciplina di cui tutti parlavano. Gl’inviti non avevano superato i confini del Triveneto. Quelli di Udine avevano battuto in semifinale i giovinetti dell’istituto Turazza di Treviso (3-1) e in finale la Società palestra ginnastica di Ferrara (2-0). A Udine i nomi di quegli undici sono tuttora scolpiti nel marmo; uno di essi, Augusto Tam, si era aggiudicato pure il torneo di tennis, ma nel resto del Paese risultavano perfetti sconosciuti. Di conseguenza le proteste dei friulani per l’onore accordato al Genoa e per il mancato invito sono state catalogate come le solite bizze degli inguaribili provinciali.
La denominazione completa dei nuovi campioni era Genoa Cricket and Athletic Club: gran sacerdote della fondazione il console di Gran Bretagna, Payton, a ispirarla il trentenne James Spensley. Lavorava da medico a bordo di una nave inglese. Dopo lo sbarco in Liguria vi si era fermato per curare la folta colonia britannica, che con l’apertura del canale di Suez aveva trasferito i propri affari a ridosso della Lanterna. Anche i camalli erano diventati pazienti di Spensley e lui si era dato a propagandare il verbo calcistico tra quei rudi portuali. Spensley giocava in porta con risultati modesti, ma essendo l’anima della squadra, l’organizzatore di allenamenti e partitelle, l’ispiratore del modulo, era l’unico sicuro del posto. Ed era stato sempre lui a selezionare i titolari, ad aprire le porte del club agli italiani fin lì tenuti ai margini. D’altronde, anche il campo l’avevano messo a disposizione due industriali scozzesi. Nell’undici laureatosi campione d’Italia stranieri e oriundi rappresentavano la maggioranza essendovi anche i fratelli Pasteur nati in città da genitori svizzeri. In onore di tale successo l’Athletic della denominazione originale è stato mutato in Football. La storia si è messa in cammino, malgrado mancassero ancora le leggendarie casacche rossoblù. Giocavano tutti con la camiciola bianca, che era a buon mercato, di facile reperibilità: per vedere i numeri sulla schiena dovranno trascorrere quarant’anni; i pantaloni si portavano lunghi, le scarpe erano quelle da passeggio, taluni preferivano gli scarponi da montagna. Quelli del Genoa hanno aggiunto cravattino e berrettino seconda tipica usanza inglese (ancora oggi in Gran Bretagna le presenze in squadra vengono indicate con il termine cap).
Poliglotta, cultore di religioni orientali, convinto assertore dello scoutismo da poco fondato in Inghilterra, disinteressato benefattore di orfanelli e di bambini abbandonati, Spensley ha funzionato da calamita per l’intera comunità. Il Genoa ha vissuto stagioni irripetibili: ha rivinto il titolo nel ’99, nel ’900, nel ’902, nel ’903, nel ’904; ha suscitato tale invidia da sollecitare la nascita di un’altra formazione cittadina, l’Andrea Doria. A interrompere l’irritante dominio hanno provveduto nel 1901 il Milan, sotto l’ala protettrice del giovanissimo Alberto Pirelli, e nel 1905 la Juventus. Il campionato si è allargato: dalle selezioni regionali si è giunti al girone finale a tre con partite di andata e ritorno. La Juventus ha preceduto di un punto il Genoa: l’hanno fondata nel 1897 i liceali del Massimo D’Azeglio abituati a ritrovarsi su una panchina di corso Re Umberto (tra i cimeli nell’attuale sede del club). I suoi ideatori di alta estrazione e ammalati di esterofilia avevano i soldi per ordinare a una ditta specializzata di Nottingham la muta di maglie. Nell’ordinazione latitava l’indicazione del colore, gl’inglesi hanno perciò spedito lo stesso equipaggiamento fornito al club cittadino ed è stato il bianconero per sempre. Pur espressione di una borghesia in rampa di lancio, la Juve ha vissuto gli inizi in un caotico regime assembleare. L’imprenditore svizzero Alfred Dick è stato nominato presidente per uscire dall’eccesso di democrazia; nonostante l’insperato successo in campionato, lo spogliatoio ne ha decretato la defenestrazione. E’ andato via sbattendo la porta: l’anno successivo insieme con un gruppo di transfughi bianconeri ha costituito, al termine di una serata in birreria, il Torino Football Club.
Il 15 maggio 1910 è una domenica. A Milano il cielo è bigio. Il più emozionato di tutti è forse Umberto Meazza. Passeggia lungo i Navigli prima di salire sul tram elettrico, lui che ricorda benissimo l’ultimo tram a cavalli. Compie l’intero percorso del centro: via San Vittore, piazza Sant’Ambrogio, via Sant’Agnese, corso Magenta, via San Giovanni sul Muro, via Dante, via Mercanti. Poi prosegue a piedi fino ai portici dietro piazza Duomo. Qui ci sono le sale del ristorante Orologio. In mezzo ai camerieri intenti a preparare i tavoli per il pranzo domenicale, Umberto si ritaglia un cantuccio per sfogliare il Corriere della Sera. L’apertura del giornale è dedicata alla riforma della tassa sugli affari. Di spalla campeggiano le dichiarazioni del governo Luzzatti sugli scontri fra operai e reali carabinieri in Romagna. Meazza scorre frettolosamente le pagine, si sofferma appena sugli ultimi echi della successione di Giorgio V a Edoardo VII sopra il trono imperiale britannico; sulla rievocazione della battaglia di Calatafimi a firma di Alessandro Luzio, è il cinquantenario dei Mille; sulla suora francese decorata con la Legion d’Onore, ma denunciata per truffa da un gioielliere parigino in Avenue de l’Operà: gli aveva sottratto preziosi del valore di 580 mila lire (poco più di 2 milioni di euro). Finalmente in fondo al giornale Meazza trova l’articolo che cercava: due mezze colonne a centro pagina. Sotto l’occhiellino Football, il titolo recita: "Italia contro Francia - L’incontro delle due squadre nazionali a Milano".
Meglio di niente, però Meazza confidava in un po’ di considerazione in più: l’incontro viene pure disputato all’Arena. Con che invidia Meazza guarda lo spazio e l’attenzione dedicati all’imminente conferenza romana dell’esploratore statunitense Robert Peary alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Un mezzo lestofante questo Peary, sbrigativo l’anno prima ad annunciare di aver toccato il Polo Nord, mentre si era fermato, nella più favorevole delle ipotesi, 5 miglia prima. L’articolo sulla nazionale di calcio è quasi un comunicato stampa, le formazioni sono ignote, il pronostico è definito incerto. La squadra transalpina ha incassato sonore scoppole nei due incontri fin qui disputati - 10-1 a Londra contro l’Inghilterra, 4-0 contro il Belgio a Parigi -, l’Italia è al suo esordio e nessuno ne conosce lo spessore, neppure Meazza, benché figuri quale allenatore, scelto da una commissione tecnica composta da sei dirigenti di quattro società milanesi. Umberto ha ventotto anni, un solido passato da sportman, cioè di gran curioso di molte attività agonistiche, una laurea in legge, una professione di avvocato esercitata nel tempo libero, ma di tempo libero il football da un anno chiamato calcio gliene lascia ben poco. Meazza è dirigente, arbitro, organizzatore d’incontri, componente della neonata federazione, quando può, continua pure a giocare. I sussurri della città lo indicano come il più fuori di testa dei fuori di testa, che corrono dietro il pallone.
Il Paese palpita per le sorti di tre rarissimi esemplari d’uccelli, i ’Cavalieri d’Italia’ appartenenti alla famiglia degli scolopacidi, feriti dalle fucilate di un improvvido cacciatore della borgata di Zinola, vicino Genova, mentre si rivela abbastanza tiepido nei confronti del pallone. Al pari dell’automobilismo è considerato un simbolo della modernità. Rompe gli schemi tradizionali dello sport unendo forza fisica e leggerezza di movimenti; si pratica in gruppo, ma conta l’individualità. Coloro che hanno buone letture alle spalle ripetono il motto dei moschettieri di Dumas: tutti per uno, uno per tutti.
A portare la prima sfera di cuoio in Italia è stato, nel 1887, un commerciante torinese di origine svizzere, Edoardo Bosio, lo stesso volto sputato di Freddy Mercury. Trattava articoli ottici, gli affari l’hanno spesso condotto in Inghilterra: lì ha scoperto la disciplina, che insieme con il rugby ha conquistato i cuori dei cittadini dell’unica potenza mondiale. I dipendenti di Bosio si sono impratichiti con il gioco, due anni dopo li ha sfidati una squadra imbottita di giovin signori savoiardi, il duca degli Abruzzi, il marchese Ferrero di Ventimiglia, il conte Nasi. Proletari e patrizi si sono mescolati in allegria fra gran pedate e scarsa tecnica. Non si parlava di tattiche, la tentazione era di correre tutti dietro il pallone. Esisteva già il fuorigioco, la porta misurava due metri e mezzo d’altezza per sette di larghezza, si avanzava palla al piede fino a consegnarla all’avversario, i passaggi non si usavano. La confusione dominava sovrana.
Molti degli adepti provenivano dalle società di ginnastica e di scherma. I cultori di spaccate e giravolte, di parate e risposte guardavano con snobistico cipiglio quanti emergevano dalla polvere di quei campi di sterpi a malapena delimitati con lo spago. Lo chiamavano «gioco di società con i piedi importato dall’Inghilterra». Per motivi di noblesse la plebea attività veniva sconsigliata ai soci. Allora molti sono fuoriusciti, hanno creato nuovi sodalizi. La preparazione di base acquisita nelle palestre ha consentito agli ex ginnasti di primeggiare. L’epoca è refrattaria all’attività fisica: la si fa sgobbando nei campi o durante la ferma. Ogni disciplina è praticata in maniera empirica, di allenatori se ne vedono pochi. Gli atleti sono autodidatti: si cresce e si migliora sulla spinta dell’esperienza. Il fisico risulta una macchina sconosciuta, le sue possibilità, i suoi limiti tutti da scoprire. I gran borghesi si dedicano all’equitazione, alla scherma, alle rombanti automobili; la ginnastica s’adatta agli studenti; i proletari si rivolgono al ciclismo, le cui corse appaiono una sorta di massacro organizzato: vince chi resiste in sella; l’atletica incomincia a far proseliti sulla scia delle Olimpiadi ridestate nel 1896 dal barone De Coubertin. Con la sua aspirazione alla presunta purezza incarnata da un dilettantismo totale, il nobile francese ha riservato lo sport soltanto ai parigrado, gli unici a poter disporre del tempo libero per allenarsi. Ne discende che dopo un approccio iniziale spesso dettato dal gusto della scoperta, ciascun aspirante atleta ha dovuto fare i conti con la disponibilità economica. Terminate le dodici ore in fabbrica, al tornio, nei cantieri edili, sulle zolle agresti, allenarsi è dura per chiunque. La passione può anche essere smisurata, ma se ci fossero pure un paio di lirette, il sacro fuoco si accenderebbe ancora meglio. Dunque non stupisce che pure il calcio, al pari delle altre attività agonistiche, si sia sviluppato soprattutto nel triangolo Torino-Milano-Genova, dove un po’ di benessere ha toccato la popolazione. Studenti e perditempo cominciano ad essercene in discreto numero e chi ha il problema del pane e companatico qualche modesto compenso sottobanco lo può arraffare.
L’Italia conta 35 milioni di abitanti, 16 milioni sono analfabeti, 10 milioni con la seconda o la terza elementare, i laureati sono soltanto 50 mila. Fatta eccezione per un po’ d’industria al Nord, dominano l’agricoltura e la pastorizia. In ogni regione, in particolare negli sterminati latifondi del Meridione, la fame è tanta e si porta appresso la pellagra, il vaiolo, la tubercolosi. Dal Veneto alla Sicilia l’emigrazione sembra a molti l’unica speranza di un domani migliore: dall’inizio del secolo otto milioni di persone hanno lasciato l’Italia. In politica domina Giovanni Giolitti, piemontese taciturno e musone, primo capo di governo senza benemerenze risorgimentali. Nel 1910 si è però tirato in disparte presentendo aria di burrasca per la riforma elettorale. Nelle liste sono iscritti tre milioni di cittadini: il progetto del nuovo capo di governo, l’economista Luigi Luzzatti, vorrebbe estendere il suffragio a tutti gli alfabetizzati, cioè un altro milione e mezzo di persone. Una cifra assai contenuta, tuttavia in grado di spostare gli equilibri politici a favore della parte conservatrice: verrebbero, difatti, coinvolte le masse rurali assai legate alla Chiesa e ostili ai sindacati. Di conseguenza i partiti di sinistra sono contrarissimi al progetto di Luzzatti, tuttavia non possono opporsi a una riforma smaccatamente democratica: si sono nascosti dietro l’assoluta necessità del suffragio universale, donne escluse beninteso. E su questo irraggiungibile tutto e subito il Parlamento si è infognato.
Accanto alla maggioranza giolittiana misuratamente riformista, ma irrimediabilmente spaccata, si agitano le forze che non hanno fatto il Risorgimento e sono cresciute sul suo rifiuto, cattolici e socialisti. I primi hanno preso a frequentare le urne, benché dicano di farlo a titolo personale: il Non expedit (Non conviene) pronunciato da Pio IX è stato attenuato nel 1905 dall’enciclica, Il fermo proposito, di Pio X. I secondi oscillano fra l’estremismo barricadiero e un cauto progressismo. Un esempio lo fornisce proprio la netta divisione sul valore dello sport (abbreviazione inglese del francese arcaico se desporter, in italiano diporto cioè svago, divertimento). Al terzo congresso dei giovani socialisti la quasi totalità dei partecipanti si pronuncia contro qualsiasi impegno sportivo: viene accusato di debilitare il corpo umano contribuendo alla degenerazione della specie. L’Avanti invita i lettori e i compagni a boicottare le corse ciclistiche seminando chiodi lungo il percorso. A insorgere, sullo stesso Avanti, è un big del partito, Ivanoe Bonomi: scrive che la bici ha avuto il merito di accorciare le distanze fra le classi, di essere lo strumento di una nuova democrazia.
Il football è rimasto lontano dalle polemiche. L’ha lodato un rivoluzionario come Gramsci: «Un modello della società individualistica, vi si esercita l’iniziativa, ma essa è definita dalla legge». Ha conosciuto uno sviluppo uniforme da un estremo all’altro della Penisola, tuttavia, appena superato il Po a Piacenza, le informazioni scarseggiano. Il clou dell’attività si è quindi concentrato all’interno del triangolo industriale, malgrado esista dal 1898 un organismo ufficiale, la Federazione italiana football (Fif) incaricato di provvedere alla sua diffusione. Il congresso è avvenuto in marzo a Torino dietro sollecitazione di tre società cittadine - Internazionale, Ginnastica, Football club - alle quali si è unito il Genoa. Alla vigilia della riunione è stato disputato al Velodromo un triangolare tra Internazionale, Ginnastica e Football Club, il cui vicepresidente, il marchese Alfonso Ferrero di Ventimiglia ha richiesto con lettera al sindaco la presenza di otto guardie municipali per garantire l’ordine. Il sindaco le avrebbe accordate, a patto che le società si assumessero le spese del servizio. Al termine della laboriosa trattativa il marchese ha dichiarato di essere «pronto a soddisfare il regolare pagamento», 6 lire, di tre guardie. Dalla relazione di una di esse, il vice brigadiere Torchio, sappiamo che ogni partita è durata 45 minuti e che il pubblico non superava le 500 unità, in gran parte «studenti e persone di nazionalità estere».
Altre società, come l’Alessandria e le milanesi, non hanno aderito all’iniziativa di consorziarsi per protesta contro l’egemonia piemontarda. Il cervello della svolta è stato un comitato presieduto dal conte Enrico d’Ovidio, illustre accademico, personaggio di punta del partito liberale, vicepresidente della Società Ginnastica, nella quale hanno appena lanciato la sezione calcio. Totalmente ignorante di pallone, D’Ovidio ha accettato l’incarico per le supplichevoli pressioni di un suo ex allievo di gran prestigio, il duca degli Abruzzi alla vigilia delle famose esplorazioni, innamorato perso dell’anglofilo passatempo e persuaso che abbia bisogno di una guida dall’indiscusso prestigio. Accanto a D’Ovidio si è indaffarato un attempato ingegnere, Mario Vicary, esperto in opere pubbliche, appassionatosi al pallone durante le trasferte in Europa. Insomma, sin dall’inizio sono un nobile e un gran borghese a guidare le sorti di un fenomeno, che nella sua storia secolare sarà sempre in mano a dilettanti raramente di pregio, privi di qualsiasi esperienza diretta, sospinti dall’ambizione più che da una disinteressato trasporto.
D’Ovidio ha dunque presieduto la costituente, Vicary dopo dieci giorni è stato nominato presidente della Fif. La sede è stata fissata in un famoso negozio di maglierie e cravatte, in piazza Castello, all’angolo di via Barbaroux: appartiene a un commerciante inglese, Adolf Jordan, designato segretario per la sua competenza. Ma a seppellire la notizia hanno provveduto le cannonate di Bava Beccaris contro i dimostranti milanesi. Due mesi più tardi, l’8 maggio, è stato assegnato, in una sola giornata, il primo titolo italiano. Hanno partecipato le quattro società fondatrici della Federazione. In gennaio a ranghi misti si erano affrontate a Genova sull’accidentato campaccio di Ponte Carrega, accanto al torrente Bisagno: avevano vinto gli ospiti torinesi. Il marchese Ventimiglia ne ha lasciato un effervescente resoconto, il padre dei miliardi d’articoli che saranno successivamente dedicati al calcio. Sul terreno del Velodromo torinese il Genoa al mattino ha eliminato la Ginnastica per 2-1, l’Internazionale il Football club per 1-0. Nella finale del pomeriggio ha prevalso, al termine dei supplementari, il Genoa per 2-1, arbitro di tutti gl’incontri l’instancabile Jordan. Quando hanno saputo del torneo a Udine si sono levate alte proteste. Alla Società Udinese ginnastica e scherma erano convinti di esser loro i campioni in carica avendo vinto il torneo organizzato sulla spianata trevigiana di Piazza d’Armi dal 6 all’8 settembre del 1896. A poche settimane dalla conclusione ad Atene dei primi giochi olimpici dell’era moderna, la Società ginnastica velocipedistica trevigiana aveva pensato a una piccola replica locale con la disciplina di cui tutti parlavano. Gl’inviti non avevano superato i confini del Triveneto. Quelli di Udine avevano battuto in semifinale i giovinetti dell’istituto Turazza di Treviso (3-1) e in finale la Società palestra ginnastica di Ferrara (2-0). A Udine i nomi di quegli undici sono tuttora scolpiti nel marmo; uno di essi, Augusto Tam, si era aggiudicato pure il torneo di tennis, ma nel resto del Paese risultavano perfetti sconosciuti. Di conseguenza le proteste dei friulani per l’onore accordato al Genoa e per il mancato invito sono state catalogate come le solite bizze degli inguaribili provinciali.
La denominazione completa dei nuovi campioni era Genoa Cricket and Athletic Club: gran sacerdote della fondazione il console di Gran Bretagna, Payton, a ispirarla il trentenne James Spensley. Lavorava da medico a bordo di una nave inglese. Dopo lo sbarco in Liguria vi si era fermato per curare la folta colonia britannica, che con l’apertura del canale di Suez aveva trasferito i propri affari a ridosso della Lanterna. Anche i camalli erano diventati pazienti di Spensley e lui si era dato a propagandare il verbo calcistico tra quei rudi portuali. Spensley giocava in porta con risultati modesti, ma essendo l’anima della squadra, l’organizzatore di allenamenti e partitelle, l’ispiratore del modulo, era l’unico sicuro del posto. Ed era stato sempre lui a selezionare i titolari, ad aprire le porte del club agli italiani fin lì tenuti ai margini. D’altronde, anche il campo l’avevano messo a disposizione due industriali scozzesi. Nell’undici laureatosi campione d’Italia stranieri e oriundi rappresentavano la maggioranza essendovi anche i fratelli Pasteur nati in città da genitori svizzeri. In onore di tale successo l’Athletic della denominazione originale è stato mutato in Football. La storia si è messa in cammino, malgrado mancassero ancora le leggendarie casacche rossoblù. Giocavano tutti con la camiciola bianca, che era a buon mercato, di facile reperibilità: per vedere i numeri sulla schiena dovranno trascorrere quarant’anni; i pantaloni si portavano lunghi, le scarpe erano quelle da passeggio, taluni preferivano gli scarponi da montagna. Quelli del Genoa hanno aggiunto cravattino e berrettino seconda tipica usanza inglese (ancora oggi in Gran Bretagna le presenze in squadra vengono indicate con il termine cap).
Poliglotta, cultore di religioni orientali, convinto assertore dello scoutismo da poco fondato in Inghilterra, disinteressato benefattore di orfanelli e di bambini abbandonati, Spensley ha funzionato da calamita per l’intera comunità. Il Genoa ha vissuto stagioni irripetibili: ha rivinto il titolo nel ’99, nel ’900, nel ’902, nel ’903, nel ’904; ha suscitato tale invidia da sollecitare la nascita di un’altra formazione cittadina, l’Andrea Doria. A interrompere l’irritante dominio hanno provveduto nel 1901 il Milan, sotto l’ala protettrice del giovanissimo Alberto Pirelli, e nel 1905 la Juventus. Il campionato si è allargato: dalle selezioni regionali si è giunti al girone finale a tre con partite di andata e ritorno. La Juventus ha preceduto di un punto il Genoa: l’hanno fondata nel 1897 i liceali del Massimo D’Azeglio abituati a ritrovarsi su una panchina di corso Re Umberto (tra i cimeli nell’attuale sede del club). I suoi ideatori di alta estrazione e ammalati di esterofilia avevano i soldi per ordinare a una ditta specializzata di Nottingham la muta di maglie. Nell’ordinazione latitava l’indicazione del colore, gl’inglesi hanno perciò spedito lo stesso equipaggiamento fornito al club cittadino ed è stato il bianconero per sempre. Pur espressione di una borghesia in rampa di lancio, la Juve ha vissuto gli inizi in un caotico regime assembleare. L’imprenditore svizzero Alfred Dick è stato nominato presidente per uscire dall’eccesso di democrazia; nonostante l’insperato successo in campionato, lo spogliatoio ne ha decretato la defenestrazione. E’ andato via sbattendo la porta: l’anno successivo insieme con un gruppo di transfughi bianconeri ha costituito, al termine di una serata in birreria, il Torino Football Club.
L’impetuosa crescita del calcio in Europa e nell’America del Sud ha portato, nel 1905, alla creazione della Fifa (Federation internazionale de football association). Gl’italiani sono stati subito accolti. La Fif, trasferitasi da Torino a Milano, è stata rappresentata dal neo numero uno, Giovanni Silvestri, titolare di un’importante azienda siderurgica, la «Miani e Silvestri». Silvestri non era solo ricco, suo il palazzo più imponente di corso Venezia, costituiva anche lo snodo di consolidati intrecci finanziari: banche, industrie metallurgiche, seterie, la costruzione dei cantieri navali di Porto Marghera. I congiurati, che avevano in animo di mandare a casa il vertice torinese, si sono dati appuntamento a pranzo nel ristorante delle Industrie Seriche con Silvestri nelle vesti di chaperon. Il calcio veniva già ritenuto un’importante vetrina per quanti desiderassero acquisire una visibilità pubblica: malgrado si dovesse arrabattare in mezzo a discipline più popolari o più elitarie, era percepito come il mastice in grado di unificare gli entusiasmi del Paese e quindi di regalare la massima ribalta. D’altro canto da una decina di anni ha cominciato le pubblicazioni la Gazzetta dello Sport. Si tratta di un bisettimanale subito gradito ai lettori: la vendita sin dal primo numero di 20 mila copie ha fatto stappare più di una bottiglia. Uno dei due direttori, Eliso Rivera, aveva l’abitudine di girare in bici. L’ha usata anche per seguire da vicino le manifestazioni di proteste del 1898: è stato incarcerato con l’accusa di essere un anarchico. Liberato dopo ventidue giorni per insufficienza di prove, ha abbandonato la città e la Gazzetta. Il calcio all’inizio non compariva fra le discipline curate dai cinque redattori, vi è entrato gradualmente ricavandosi uno spazio accanto all’amatissimo ciclismo, benché il traguardo delle 100 mila copie non sia stato tagliato con il varo del Giro d’Italia, bensì con il titolo mondiale nella lotta greco-romana conquistato da Giovanni Raicevich a Parigi nel 1909. Assieme al leggendario color rosa, la Gazzetta è cresciuta con il calcio, ha aumentato i giorni di uscita, in taluni periodi ha assunto una cadenza quotidiana. Ha rappresentato il tocco definitivo alla cassa di risonanza assunta dalle vicende pallonare. Sennò un padrone delle ferriere come Silvestri non si sarebbe lasciato accalappiare. Classico cummenda, prossimo senatore del regno, il suo merito principale è consistito nell’aver nominato segretario Luigi Bosisio, ginnasta della Pro Patria, calciatore della Mediolanum, di sicuro il miglior dirigente ante guerra. Dopo un anno la consueta congiura di palazzo ha spodestato Silvestri. La scusa è stata la mancanza di provvedimenti disciplinari per le scazzottature fra juventini e genoani con partita dapprima sospesa a Torino e poi disputata sul neutro di Milano. Nella realtà alla dirigenza nazionale importava ben poco del movimento, in continua espansione di praticanti e d’interesse: stava molto più attenta alle scaramucce di potere, spesso estrinsecate dalla stucchevole modifica della formula. Di conseguenza non ha sorpreso che al posto di Silvestri sia stato insediato il principe Emiliano Barbiano di Belgioioso d’Este, proprietario della villa più invidiata e più ricca di storia sul lago di Como. Al pari dei predecessori pure Barbiano di Belgioioso era disposto a spendere del proprio purché il giocattolo fosse solo suo. Ma non è stato facile tenere a bada le arrembanti pretese delle società. La doppietta del Milan nel 1906 e 1907, con la squadra inzeppata di stranieri, ha indotto la federazione a un’innovazione rivoluzionaria: solo italiani in campo. Sdegnati e con problemi di formazione Milan, Torino e Genoa - abbandonato da Spensley voglioso di nuove esperienze - non hanno partecipato al campionato del 1908. A vincere sono stati i ginnasti della Pro Vercelli convertitisi al calcio sotto la spinta di Marcello Bertinetti, ingegnere e schermidore di classe purissima (due argenti olimpici nella sciabola a squadre a Londra, sempre nel 1908, e a Parigi nel ’24; oro nel ’28 ad Amsterdam, quarantatreenne, nella spada a squadre). Bertinetti ha tradotto dall’inglese i manuali del calcio, li ha fatti imparare ai compagni e poi ha spiegato che spingere la palla oltre la linea della porta sarebbe stato semplicissimo per atleti di simile stazza: il loro vanto consiste nell’affrontare le trasferte in bicicletta - una sorta di riscaldamento prolungato prima di schierarsi in campo -, di essere tutti vercellesi e di rifiutare i forestieri tanto in auge fra i rivali. Così alla prima esperienza le «bianche casacche» con calzoncini neri hanno beffato avversari dati sulla carta per favoritissimi. Ritiratasi la Juve dopo le prime due partite, hanno preceduto di un punto l’Unione sportiva milanese. I vercellesi hanno bissato il successo l’anno seguente. Milan, Torino e Genoa erano rientrati, è stato inserito anche il Venezia. La finale ha visto la Pro sbarazzarsi ancora dell’Unione. Bertinetti si è accomodato fra le riserve, il resto della squadra ha sviluppato la solita supremazia fisica. Quando Giuseppe Milano, perno del centrocampo e campione provinciale di lancio del sasso, si rimboccava le maniche della maglia per i compagni era il segnale che bisognasse lanciarsi all’assalto degli avversari. Raccontato con enfasi dagli aedi dei giornali, il gesto ha prodotto un’espressione gergale ancora viva. Un altro dei grandi del centrocampo, Guido Ara, ha sintetizzato l’essenza del modulo proclamando: «Il calcio non è sport per signorine». La necessità di infoltire le file del campionato ha scatenato il solito tourbillon dirigenziale. Ne ha fatto le spese nel 1909 Barbiano di Belgioioso defenestrato dal segretario Luigi Bosisio, l’unico per altro a capirne di regolamenti e di regole di gioco. Con la sua presidenza la federazione ha assunto la denominazione tuttora in auge, Figc (Federazione italiana gioco calcio), è stata creata l’impalcatura che da oltre un secolo regge l’intera struttura. Si sono allacciati rapporti con le lontane province meridionali: viaggiatori provenienti dall’interno hanno garantito che venissero tirati calci al pallone dalle parti del Colosseo e a Mergellina; pare che anche in quell’isola dell’Africa, che gli italiani si ostinano a chiamare Sicilia, fossero stati liberati spiazzi acconci a ospitare le turbolente masnade all’inseguimento della sfera di cuoio. Eppure, come succede adesso nella finanza, nelle banche e nei consigli d’amministrazione, faceva fino preferire la terminologia inglese a quella casereccia, dire penalty anziché rigore, ball anziché palla, inside anziché terzino, referee anziché arbitro, goalkeeper anziché portiere, corner anziché calcio d’angolo, back anziché terzino, centerforward anziché centravanti, linesman anziché guardalinee; solo gol, pronuncia del sostantivo goal, era destinato a imporsi e ad attraversare confini e continenti. Lingua o non lingua, chi abita a Torino e a Milano non ha alcuna intenzione di salire su un treno diretto al Sud. Molto più facile che si muovano le squadre d’oltrefrontiera com’è capitato nella Pasqua 1909 a Torino. Sir Thomas Lipton, reso miliardario dal commercio del tè, desiderava ricambiare casa Savoia, che l’aveva nominato commendatore del regno d’Italia in riconoscimento dei suoi meriti nell’import-export lungo l’asse Londra-Torino. Gli è sembrato che un torneo internazionale sotto la Mole rappresentasse il ringraziamento più moderno e più chic. Hanno partecipato lo Stoccarda, il Red Star di Zurigo, la Juventus e l’unica formazione inglese, che si è fatta convincere dalle sterline del munifico mecenate. Si trattava dei minatori del West Auckland, contea di Durham: nella finale hanno piegato i bianconeri. Sir Lipton è rimasto così entusiasta da programmare per l’anno successivo la seconda edizione. E dire che l’identica iniziativa approntata dodici mesi prima a Palermo è passata pressoché sotto silenzio. Per darle un po’ di rilievo non è bastato il favore accordato al football dai Florio, invidiatissimi e imitatissimi Signori della Sicilia, che con l’Inghilterra hanno un continuo scambio di mode e d’affari. Il 1910 si è presentato come l’anno della definitiva consacrazione internazionale. Sono stati messi in calendario una riunione della Fifa a Milano e l’esordio della rappresentativa italiana contro la Francia: per l’occasione, anziché nel campo di via Stelvio, si sarebbe giocato all’Arena. Alcuni notabili hanno protestato contro la profanazione dell’impianto napoleonico, ma la mobilitazione dei volti più gettonati dei salotti meneghini non solo ha sopito le polemiche, ha anche creato la giusta atmosfera. Purtroppo sull’esordio della nazionale ha pesato l’inghippo scaturito dal campionato, disputato su un girone unico comprendente nove squadre. Hanno concluso in testa con 25 punti la Pro Vercelli e l’Internazionale, nata due anni prima dalla scissione nel Milan per un litigio sugli stranieri da utilizzare. L’anima della rottura è stato il pittore Giorgio Muggiani; lo svizzero Hernst Marktl, tra i fondatori del diavolo rossonero, è stato nominato capitano della nuova formazione. L’atto costitutivo è avvenuto all’Orologio, ormai la tana dei patiti di calcio: i padri nerazzurri sono stati poi fotografati in bombetta e grisaglia d’ordinanza. Per lo spareggio, fissato in casa dei vercellesi grazie alla differenza reti, la federazione ha proposto tre date:17, 24 aprile e 1º maggio. Il presidente della società piemontese, l’avvocato Luigi Bozino erede di una celebre dinastia di patrioti cavouriani, ha rifiutato il 17 con la scusa di un torneo studentesco, al quale i suoi ragazzi non hanno però partecipato. Carlo De Medici, fresco presidente dell’Internazionale, ha rifiutato il 1º maggio, un mercoledì, che gli spensierati milanesi avrebbero sfruttato per allungare il week end. Rimaneva il 24 aprile, ma quattro della Pro, Giuseppe Milano, il fratello Felice, il portiere Innocenti e il centravanti Fresia, avevano da onorare la convocazione dell’esercito per un torneo militare. Colpito da tanta dedizione Bosisio ha promesso a Bozino che lo spareggio sarebbe stato effettuato dopo l’impegno con la Francia. Al contrario il direttivo federale ha scelto il 24 aprile. Apriti cielo: Bozino dapprima ha accusato l’Inter di voler approfittare dello spirito patriottico dei vercellesi per lucrare un’immeritata vittoria, poi ha denunciato il vile asservimento dei dirigenti ai desiderata del nemico. Non per niente la federazione teneva casa a Milano… Il 24 Bozino, osannato dai concittadini, ha mandato in campo la quarta formazione, quella formata dai ragazzini fra gli undici e i quattordici anni. Insultata e spernacchiata dal primo all’ultimo minuto l’Internazionale ha stravinto. Il risultato finale è ballerino da oltre cent’anni: si va da 9-3 a 11-3. Fra i babies della Pro si sono distinti due futuri protagonisti del futuro ultimo scudetto vercellese, quello del ’21, Mario Ardissone e Alessandro Rampini, che al momento superava a stento il metro di altezza. I festeggiamenti nerazzurri nello spogliatoio sono stati interrotti dagli urli e dagli spintoni del pubblico di casa voglioso di allestire un altro tipo di festa. Sono stati vissuti lunghi minuti di tensione. La tradizione orale, chissà quanto sincera, ha tramandato che a guidare gli esagitati fossero Ara e Carlo Rampini, il fratello maggiore di Alessandro. Sono dovute arrivare in fretta le forze dell’ordine per evitare che qualcuno degli ospiti finisse all’ospedale. L’arbitro dell’impari disfida è stato Meazza. Incolpevolmente ne ha pagato anche il prezzo più alto. Da selezionatore della nazionale è stato privato dei giocatori della Pro Vercelli subito squalificati assieme ai dirigenti. Nelle due partite di preparazione, il 5 e l’8 maggio, «probabili» contro «possibili», Umberto ha cercato d’individuare le acconce soluzioni. Alla fine ha scelto nove giocatori di Milano, due di Torino e uno di Genova, Franz Calì, il capitano, terzino dell’Andrea Doria, nativo di Riposto (Catania), emigrato con la famiglia in Svizzera dopo che un assalto di pirati ha mandato gambe all’aria il commercio di vini del padre in Sicilia. Paradossalmente c’è un solo titolare dell’Internazionale, il capitano Virgilio Fossati. Nella foto prima della gara è l’unico a tenere l’ultimo bottone della casacca chiuso. Il colore delle maglie è il solito bianco, su cui è stato cucito lo scudetto tricolore. Secondo l’usanza del rugby, ciascun giocatore porta i calzettoni e i pantaloncini del club di appartenenza. Quindi in quattro, Calì, Trerè, Capello e Rizzi, oltre al portiere De Simoni li hanno neri. Aldo Cevenini, il maggiore di una famosa dinastia di fratelli, esibisce un buffo copricapo bicolore. Tra accenni di pancetta e rotolini dispettosi sui fianchi si respira un’aria gozzaniana, di piccole cose non sempre di pessimo gusto, di bicchierini di rosolio, di vellutati divani, di sospirosi desideri. Questi undici e la loro sfera di cuoio provengono dal passato, ma anticipano il futuro. Tutti sono consapevoli che il meglio sia rimasto fuori. I cattivi pensieri, che hanno frastornato la vigilia di Meazza, di Bosisio, di coloro che si erano invano prodigati per evitare la squalifica dei vercellesi e di coloro che, sotto sotto, avevano operato per favorire l’Internazionale non prevedendo le traumatiche conseguenze, sono spazzati via dall’imperiosa partita della nazionale. Il 6-2 conclusivo ha trascinato all’entusiasmo i quattromila spettatori. Così numerosi a Milano mai si sono visti. La monumentale Arena ha fornito una cornice mozzafiato per chi è abituato a spelacchiati terreni di gioco attorno ai quali vengono montate traballanti tribunette in legno. E possiamo credere che sul risultato non abbia inciso l’arbitro, Harry Goodley, di passaporto inglese, ma uno di famiglia. E’ un apprezzato tecnico tessile nell’industria di Dick. Ha provato a giocare nella Juve, ma non è stato valutato all’altezza. Si è adattato a fare il referee aggiungendo che per aiutarlo a essere imparziale sarebbe stato il caso di riconoscergli un piccolo rimborso per il panino e la birretta. Il giorno dopo anche il Corriere mostra un minimo di attenzione. Nelle quattro colonne, su sei, occupate dallo sport a pagina 4, l’apertura è dedicata all’affermazione di Etoile de Feu nel Gran Premio Commercio di galoppo all’ippodromo di San Siro, ma a centro pagina due colonne danno conto di quanto avvenuto all’Arena: "Il vittorioso incontro della squadra nazionale di football con la squadra francese". La cronaca vibra di legittimo orgoglio: che gusto aver dato una ripassata agli altezzosi cugini per di più rappresentanti di un Paese con il quale sulla carta siamo rivali. La Francia assieme all’Inghilterra e alla Russia sta nell’Intesa ed è fiera oppositrice alle nostre mire colonialistiche in Africa, visto che noi stiamo nella Triplice con gl’Imperi di Germania e Austria-Ungheria. Nell’articolo non si parla di tattiche, di schemi, di azioni: l’ignoranza è crassa a ogni livello, le regole non del tutto chiare, che sul campo ci si possa organizzare lontano dalla palla o in attesa di riceverla, che si possa giocare in orizzontale per liberare un compagno e non soltanto in verticale per puntare in qualsiasi modo verso la porta, assomiglia a un mistero per niente gaudioso. Il brillante e non scontato successo serve da antidoto alle velenose scie lasciate dallo spareggio. L’attenzione è rivolta al prossimo impegno della nazionale, il 26 maggio a Budapest contro i maestri dell’Ungheria. La lungimiranza dell’anziano Francesco Giuseppe, il Cicco Peppe di tanta pubblicistica risorgimentale, ha consentito ai diversi popoli del suo variegato Impero di coltivare un’impronta nazionalistica nello sport. I fieri magiari ne hanno subito approfittato trasformando le travolgenti vittorie della squadra in altrettante manifestazioni per l’autonomia. Il viaggio della nazionale è lunghissimo. Si va in treno fino a Trieste. La polizia austro-ungarica con la scusa di scortare i giocatori dalla stazione al porto impedisce che gli irredentisti giuliani usino il passaggio degli italiani per sventolare il tricolore o per invocare l’apertura della sospirata Università italiana. Lo rievocherà Nereo Rocco, il cui padre, che di cognome faceva ancora Rock, si era casualmente ritrovato in mezzo a chi applaudiva la comitiva. Con il piroscafo viene raggiunta Fiume e da qui un’altra spanciata di terza classe fino a Budapest. Trerè è incaricato di custodire il borsone con le vivande per sfamare la truppa fino al ritorno a Milano: pane, mortadella, salame, formaggio, fiaschi di vino. Le finanze federali possono garantire un solo pernottamento e il pranzo prima dell’incontro. Trerè assolve con tale scrupolo il compito da dimenticare sul vagone lo zaino contenente le sue scarpette - i calzolai nostrani hanno cominciato a copiare i modelli importati dalla Gran Bretagna - e quelle di Cevenini. Rimediano con le scarpe usate durante il viaggio. Ma non è questo il motivo della scoppola rimediata al Millenaris Sporttelep, 6-1. Risultiamo inferiori per tecnica e per tenuta atletica, privi di una qualsiasi idea di schema. Non a caso, il migliore è apparso il portiere, Mario De Simoni. Sul 6-0, agli italiani è stato concesso il golletto della consolazione, realizzato da Rizzi. Ha esordito da mezzala Renzo De Vecchi, sedici anni compiuti in gennaio, terzino del Milan talmente virtuoso da indurre i tifosi a definirlo Figlio di Dio. Il totale dominio dei padroni di casa è stato accompagnato dal garrire delle vecchie bandiere del Regno magiaro ormai estinto. I dodicimila spettatori hanno ritmato battimani e calpestio all’urlo: Magyarország. A settant’anni di distanza, l’episodio sarà narrato con le lacrime agli occhi da Ferenc Puskas, il più grande calciatore d’Ungheria, che l’aveva udito glorificare centinaia di volte durante l’infanzia. Più largo di una botte, ormai quasi sessantenne, ma con i due piedini sempre magici, Ferenc voleva ribadire il forte significato simbolico assunto, già agli albori, dal calcio. Gli serviva per spiegare il motivo che aveva indotto lui e gli altri dell’Honved a non rientrare a Budapest dopo l’irruzione dei carri armati sovietici nel ’56: se i giocatori, che fra il ’52 e il ’56 avevano dominato il mondo, fossero rimasti lontani dalle grinfie dell’Urss, l’Ungheria avrebbe avuto una voce in più per farsi ascoltare. E loro tanti begli ingaggi in dollari. La bruciante sconfitta riaccende le polemiche in federazione. A Bosisio viene accollata per intero la responsabilità del pasticciato spareggio con la conseguente sospensione dei vercellesi, la cui assenza si è potuta pesare a Budapest. Al posto di Bosisio viene eletto un altro milanese, Felice Radice. S’inizia una giostra di presidenti al ritmo di uno l’anno, e a volte anche più, ai quali si accoppia la ridondante commissione tecnica somigliante alla hall di un grande albergo con gente che va e gente che viene. Alla sarabanda non sarebbe estranea una lotta intestina fra logge e obbedienze massoniche. Rilievo o accusa, che da oltre un secolo accompagna la tumultuosa esistenza del calcio sia in Italia, sia all’estero. D’altronde, per chi crede alle coincidenze, la riunione tra i rappresentanti delle dieci società inglese e delle tre scozzesi che ha aperto, in ogni senso, i giochi è avvenuta il 26 ottobre 1863 alla Free Masons Tavern. Bisognava risolvere il dissidio tra i fautori dell’uso delle mani, delle spinte, dei placcaggi e i puristi che non desideravano andare oltre i piedi. Alla fine è stato sancito di separare le strade: da un lato il rugby, dall’altro il football a ribadire sin dalla denominazione che gli unici arti autorizzati a toccare la palla erano quelli inferiori. Il riassetto federale produce l’immediata riabilitazione di giocatori e dirigenti della Pro Vercelli. Binaghi, che soffia il posto a Calì, Ara, Giuseppe Milano, nuovo capitano, Leone, Carlo Rampini, Corna tornano buoni per la rivincita con l’Ungheria. E’ fissata il 6 gennaio 1911 all’Arena. Malgrado Roma rimanga ai confini del movimento, dalla corte si è manifestato interesse per il passatempo capace di attirare un consenso trasversale. Nel 1900, qualche settimana prima di essere ammazzato da Bresci, Umberto aveva varato la coppa del Re. Adesso si desidera marcare in maniera pregnante la vicinanza della dinastia reale al calcio. Pare che il suggerimento ai dirigenti federali sia provenuto, fra un’esplorazione e l’altra, dal duca degli Abruzzi: non si potrebbe adottare per le maglie il colore tipico di Casa Savoia, cioè l’azzurro dello stendardo con aggiunta dello scudetto sabaudo? Il battesimo della nuova tenuta, completata dai calzoni neri fino al ginocchio, avviene nel gelido venerdì milanese. Scrive il Corriere. « L’Arena Civica aveva un aspetto delizioso di ghiaccia foderata di neve. Ma sulla neve dagli spalti verso il centro una fascia nera di 5.000 spettatori s’era distesa. Sul prato sbarazzato dalla neve e ancora umido 22 uomini si sono disputati la vittoria con accanimento: 11 ungheresi in maglia bianca con lo stemma magiaro sul petto e 11 italiani nella nuova maglia azzurro crociata». L’arbitro è il solito Goodley, sul punto di essere cooptato dalla commissione tecnica, dove Meazza continua a essere il primus inter pares. Formazione rivoluzionata e rafforzata, ma l’Ungheria resta su un livello superiore. Gli azzurri hanno il merito di difendere la sconfitta, 0-1, e di riuscire a limitare il passivo. I cinquemila infreddoliti dell’Arena non sembrano gradire l’ammissione della propria inferiorità. Invano Milano ha provato a rimboccarsi le maniche della casacca: si è sbattuti contro un muro. Decenni dopo De Vecchi garantirà a Bernardini che i magiari viaggiavano già con un preparatore fisico, all’occasione anche massaggiatore, e con un medico meticoloso nell’indicare le pietanze più acconce. Insomma, non c’era corsa. Per i ragazzi della pianura padana, anche per coloro che giocano in nazionale, sedersi a tavola tre volte al dì rappresenta una rimarchevole conquista. I pasti devono riempire lo stomaco. L’alternanza di carboidrati e proteine, la limitazione dell’alcol, l’importanza dei legumi e della frutta sono una conquista alimentare di là da venire. Formaggi, pane, salumi, polenta, patate, riso costituiscono il menù abituale; una bottiglia di vino è sempre la benvenuta; carne, olio, zucchero, pomodori, frutta vengono considerati roba da ricchi. I più avvertiti nell’ambiente suggeriscono il digiuno prima delle partite per evitare imbarazzanti situazioni gastriche. Sono le usanze di un Paese proletario, benché la monarchia e le classi di vertice si sentano vocate a stare fra i grandi e l’inaugurazione del ’Vittoriano’ a Roma, in occasione del cinquantenario dell’Unità, è parso ai Savoia e al governo il modo migliore di riaffermarlo. A simile ambizione manca, per altro, il supporto principale: l’esercito. Il nostro ha fornito prove disastrose in terra e in mare. Pure il resto fa a pugni con le aspirazioni di grandezza. In percentuale contiamo il maggior numero di analfabeti in Europa, il 37,6 per cento, ma nel Mezzogiorno si tocca il 60 per cento. Il 55 per cento della popolazione lavora nelle campagne; l’età media è molto bassa, 28 anni, al pari dell’altezza, 166 centimetri. L’esposizione internazionale di Torino è stata ammirata più all’estero che in Veneto, in Friuli, in Meridione. Quasi nessuno ha visto il documentario Le officine della Fiat, primo omaggio all’impetuoso sviluppo dell’azienda automobilistica di monsù Giovanni Agnelli. Lo stesso si può dire della pellicola La fiera della vanità, quasi una primizia dopo che l’anno precedente negli Stati Uniti Griffith ha girato il primo film della storia, Old California. Ci mancano risorse naturali e struttura statuale. Appena reinsediato alla guida del governo, Giolitti vara la riforma elettorale su basi molto più ampie di quelle previste da Luzzatti, nonostante in privato l’abbia definito «l’apoteosi dell’ignoranza»: coinvolge ben quattro milioni e mezzo di cittadini. A vecchiaia e invalidità degli stessi si promette di pensare con il monopolio delle società assicurative: i loro utili serviranno, per l’appunto, a costituire la Cassa Nazionale di Previdenza. In simile panorama il calcio rappresenta un tuffo nell’avvenire, apre le porte del mondo, sveglia i cervelli, obbliga diversi a varcare confini, non solo geografici, che mai avrebbero attraversato. E pazienza se la nazionale continua a faticare, nonostante l’assiduo impiego dei vercellesi, che in campionato si confermano dominatori incontrastati. Un pareggio rimediato nel finale a Parigi contro la Francia, 2-2, stesso risultato all’Arena contro la Svizzera e una settimana più tardi secca sconfitta (0-3) nella rivincita a Chaux-de-Fonds. I giornali ne chiedono conto e ragione: nessun esame critico dei giocatori o della tattica, intriga soltanto il risultato finale. Tocca al solito Meazza, che ha trovato pure il tempo di fondare e presiedere l’associazione degli arbitri, metterci la faccia. La scusa della scoppola diventa la gita in montagna effettuata dagli azzurri la mattina dell’incontro: un guasto alle auto ha obbligato la comitiva a un rientro a piedi e i muscoli si sono imballati. Ma ciò che deve bastare per l’opinione pubblica è causa, invece, dell’ennesimo ribaltone federale: stavolta pagano i milanesi. Gli uffici ritornano a Torino. Viene eletto presidente un personaggio inattaccabile, Ferrero di Ventimiglia: oltre all’antica e cristallina militanza, può vantare di essere tra gli azionisti della Fiat, cui dalla Juve si rivolgono sguardi pieni di speranza. La squadra veleggia sul fondo della classifica ed evita con opportuni ripescaggi un paio di retrocessioni. Nell’intento di snellire e rivitalizzare l’organizzazione, il marchese sceglie un segretario estraneo alle camarille, il ventisettenne Vittorio Pozzo, umili origini biellesi, studi non completati, però perfetta conoscenza dell’inglese e del francese, del tedesco e dello spagnolo. Pozzo ha imparato a vestire elegante, usa sempre giacca e cravatta con tagli e tonalità alla moda; la folta capigliatura ben curata e con perfetta riga a sinistra gli conferisce un’aria dottorale. Per necessità è stato in Francia, in Gran Bretagna, in Svizzera: ha lavorato e giocato a pallone. E’ ritornato a Torino nel 1906, ha partecipato alla fondazione del club granata, vi ha militato fino alla vigilia della nomina in federazione. Per mangiare è stato assunto all’ufficio propaganda della Pirelli. Utilizza fine settimana e vacanze nello studio del calcio altrui: Svizzera e Francia sono le mete abituali; allorché ha più tempo raggiunge l’amata Inghilterra e sale sui treni speciali, che vengono allestiti per trasportare i tifosi da una città all’altra. E’ l’unico italiano del pallone conosciuto al di là delle Alpi. In ossequio ai nuovi equilibri l’abituale confronto con la Francia, marzo del ’12, viene spostato da Milano a Torino, campo di via Filadelfia. I seimila spettatori giunti anche dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia assaporano l’inizio di una bella era. Al contrario si registra un’altra delusione. I grossolani errori di Vittorio Faroppa, il portiere del Piemonte, aprono la strada al primo successo transalpino (3-4). I giornali milanesi titolano «Disastro Faroppa»: così i torinesi imparano a sostituire l’idolo locale, De Simoni. E fa niente se il bel Mario non sia il massimo della sicurezza, se abbia problemi seri con il regolamento: a Parigi ha subito entrambi i gol per non essersi liberato subito del pallone. Secondo consolidata usanza britannica, la carica al portiere è ammessa: il centravanti della Francia, Maes, per due volte ha mandato con una spinta l’esterrefatto De Simoni dentro la porta. In ogni caso per quelli di Milano De Simoni non andava toccato. L’avete fatto? Avete perso? Ora pagate. In federazione succede il solito trambusto. La sconfitta con la Francia ha tirato in mezzo secoli di storia, dal De bello gallico alla disfida di Barletta. Urge individuare i colpevoli. Nel sottofondo ribolliscono diversi malumori: i primi casi di professionismo, una gestione ambigua delle squalifiche per il comportamento in campo, il malcontento delle società metropolitane per la nuova formula del campionato secondo criteri geografici. Il titolo si è in pratica assegnato nel girone ligure-lombardo-piemontese, dove la Pro Vercelli ha preceduto di un punto il Milan. In finale i pluricampioni se la sono vista con il Venezia, vittorioso nell’esangue girone veneto-emiliano, tre sole partecipanti. Non c’è stata storia: 6-0 all’andata, 7-0 al ritorno. A far le spese è Ferrero di Ventimiglia. Anche la commissione tecnica viene azzerata. Sorgono molti dubbi sulla partecipazione della nazionale alle Olimpiadi di Stoccolma. Dal governo fanno, però, sapere che lo status di potenza coloniale raggiunto dall’Italia con la conquista della Tripolitania e della Cirenaica non ammette assenze nell’arengo internazionale. Alla squadra azzurra guardano anche i nazionalisti di Enrico Corradini fautori di un espansionismo militare capace di riscuotere consensi crescenti tra gli universitari: intanto ci pensasse la nazionale a portare in alto il nome dell’Italia. Nel coinvolgimento operato dai nazionalisti serpeggia, tuttavia, un secondo fine: sfiduciare in caso d’insuccesso il vertice dirigenziale, sospettato di appartenenza alla disprezzata massoneria, per giungere a una sorta di guida assembleare con i tifosi e i giocatori. Tanta responsabilità precipita sulle spalle di Pozzo. In mancanza di alternative gli affidano il compito di selezionatore. Lui accetta a patto di non percepire alcun compenso. In quell’Italia ancora impregnata di De Amicis, di Collodi, di Salgari funziona così. L’impegno più gravoso è ristabilire una parvenza di armonia tra milanesi e piemontesi. I giocatori s’incontrano a Verona. Il comitato organizzatore garantisce vitto e alloggio solo per quattordici giocatori e non uno di più ne convoca la federazione. Mancano quelli sotto le armi: il ministero ha negato ogni deroga. Bisogna rinunciare a Rampini e Milano II; Ara è alle prese con la tesi di laurea in medicina, Fossati ha problemi in casa. A Berardo l’istituto San Paolo di Torino nega il permesso, lui allora si mette in ferie. I quattordici, Piero Campelli è l’unico portiere, percepiscono 6 lire di diaria (5 euro), il viaggio avviene in seconda classe. Appena superata la frontiera fanno tutti il cambio in terza classe e intascano la differenza. In Svezia l’ambiente non è favorevole: avvengono manifestazioni di simpatia nei confronti dei ribelli libici, che in Africa Settentrionale si oppongono alla conquista italiana. Ma a turbare i giocatori, almeno nei resoconti di Pozzo, è il contatto con le disinibite fanciulle scandinave. Per ragazzi abituati soltanto ai casini quella facilità di contatti è stordente. Le rigide regole imposte da Pozzo vengono infrante in allegria. E’ una gioia cadere in tentazione. Diversi s’informano se sia possibile essere ingaggiati dai club svedesi. Poi ci sarebbe anche da giocare e qui cominciano le note dolenti. Al primo turno ci elimina nei supplementari (2-3) la sconosciuta Finlandia, l’arbitro è Hugo Meisl, il boemo tra i massimi tecnici a cavallo della prima guerra mondiale. Finiamo nel girone di consolazione, mentre la Gran Bretagna veleggia sicura verso la quarta medaglia d’oro consecutiva. Un gol dell’interno destro interista Franco Bontadini consente di superare (1-0) i padroni di casa, che ci sommergono di fischi inneggiando ai combattenti tripolitani. Nella semifinale ecco l’Austria, sicura alla vigilia dei Giochi di poter puntare alla vittoria assieme all’altra metà dell’Impero, l’Ungheria. Il responso del campo è stato differente. Sulla panchina dei bianchi danubiani ritroviamo Meisl nelle vesti, stavolta, di allenatore. E’ al debutto, ma l’aspetta un grande futuro: ce ne accorgiamo quel 3 luglio. Nonostante gli accordi politici-militari all’interno della Triplice siano stati appena rinnovati, il 5-1 subito dalla nazionale viene equiparato in Italia a un’altra Custoza, a un’altra Lissa. Non sono accettate scuse, inutilmente Pozzo prova a spiegare che i suoi giovanotti avevano dato il meglio in altre tenzoni, che parecchi mai avevano dormito nel proprio letto. Consueto cataclisma federale. Pozzo si dimette da ogni incarico, torna alla Pirelli e al Torino. Va a casa anche il presidente federale Vittorio Rignon, tuttavia il successore, Luigi Derossi, rifiuta la nomina. S’invocano misure in grado di assicurare, a prescindere, la supremazia della rappresentativa azzurra. In caso contrario, i più accesi tra i nazionalisti propongono la rinuncia alle competizioni internazionali. Vista l’impossibilità di mandare a casa i massoni, teniamo almeno a casa la nazionale, che non consente di far sventolare in alto il tricolore. L’esperienza svedese ha dimostrato l’importanza dei bacini d’utenza: un migliaio scarso di tesserati su oltre 35 milioni di abitanti costituiscono un’evidente stonatura. L’impellente bisogno di allargare la base induce il vertice a varare il primo campionato nazionale: il Nord e il Centro-Sud vengono divisi in sei gironi, con quello campano composto dalle due sole squadre di Napoli. Invano dalla Sicilia hanno domandato di essere ammessi: i Florio sono oramai in caduta libera e pure la richiesta dei messinesi di un occhio di riguardo per aiutare la ripresa della città dopo il terremoto del 1908 non incontra orecchie interessate. La scusa ufficiale è la distanza, l’impossibilità di fare avanti e indietro nella giornata di domenica avendo il lunedì da presentarsi al lavoro o all’università. Servirebbero stipendi e ricompense economiche, ma i dirigenti, che provengono dall’imprenditoria, dalle professioni, dalla nobiltà dei feudi e che i soldi li hanno, spregiano quanti li vorrebbero guadagnare, cioè i giocatori. E poco importa se oramai il professionismo dilaga in Europa, se le società inglesi si rivolgono a lotterie, concorsi, autotassazione per reperire i fondi necessari alle compravendite, se in Gran Bretagna, in Francia, in Austria già si acquistano calciatori stranieri. Le aspirazioni di riscatto della nazionale, riaffidata a una pletorica commissione, subiscono un micidiale uno-due a cavallo dell’anno nuovo. Perde (1-3) in dicembre a Genova con lo spauracchio Austria e perde in gennaio a Parigi con la Francia (0-1). Per risollevare lo spirito viene organizzata l’amichevole con il Belgio, sulla carta quasi una vittima sacrificale. Appuntamento a Torino nel nuovo stadio di Piazza d’Armi un giovedì di festa, 1º maggio 1913. S’annunciano rappresentanze del governo e della monarchia, viene sussurrato che persino Vittorio Emanuele III si sia interessato all’esito, l’aggettivo usato è «curioso». Per addolcire il destino l’arbitraggio è assegnato a Goodley, componente della commissione tecnica. Il povero Meazza, l’uomo dei momenti difficili, va sul sicuro: ne schiera nove della Pro Vercelli alla vigilia di vincere il suo ennesimo titolo (straccerà per 6-0 la Lazio nello spareggio di Genova). Gli unici estranei sono De Vecchi e il poderoso centravanti dell’Andrea Doria, Attilio Fresia. Da Vercelli si sposta a Torino gran parte della cittadinanza: i diciottomila paganti regalano un incasso insperato alla federazione e segnalano che il calcio si appresta a vincere la competizione con le altre discipline. Vince pure l’Italia con un siluro di Ara su generosa punizione concessa da Goodley. A sera dall’ufficio postale di Torino parte un telegramma diretto a un indirizzo di Vercelli: «La Pro ha battuto il Belgio». Il difficile arriva un mese dopo a Vienna, quando bisogna restituire la visita all’Austria. Il blocco vercellese e un gran catenaccio non bastano a evitare l’ennesima sconfitta (2-0). La presupponenza dei vincitori tocca anche i compatrioti indifferenti al pallone: il generico desiderio d’impartire una lezione all’Italia, giudicata inaffidabile e traditrice, ha trovato momentanea soddisfazione nel successo sportivo. Da noi le miserie di una squadra molto al di sotto del presunto blasone patriottardo vengono allontanate dall’irruzione del mercato, che ufficialmente non esiste, però è già tanto attivo. I trasferimenti sono fin lì avvenuti tra squadre della stessa città; i passaggi di denaro sono rimasti abbastanza al coperto; lo sconcerto dei duri e puri federali non è andato al di là di accigliati avvertimenti a non straripare nell’esecrato professionismo. Ha rappresentato un’eccezione il trasloco di Fresia dal Torino all’Andrea Doria. La possente struttura fisica lo ha messo in risalto sui campacci spesso ridotti dalla pioggia a poltiglie fangose. Fremente di tornare in vetta, il Genoa lo ha acquistato per 400 lire (circa 1500 euro), all’epoca un operaio guadagna due lire al giorno. I custodi dell’ortodossia si sono imbizzarriti: hanno bloccato il trasferimento, è stata aperta un’inchiesta sul Genoa, i giornali hanno scritto di possibile radiazione. L’imbarazzante stallo viene superato grazie alla tournèe del Reading invitato ad affrontare i grandi club del Settentrione. Agli inglesi sono stati garantiti vitto, alloggio, viaggi e 18 sterline (circa 8 mila euro). Gli ospiti stupiscono con gli abiti eleganti e di ottimo taglio, con le divise da gioco tutte eguali, con le scarpette chiodate su misura. E poi sul campo scattano lontano dal pallone, fintano con i movimenti del corpo, dribblano: dimostrano, insomma, che le cariche forsennate palla al piede sono espedienti da cavernicoli, che esistono geometrie da osservare, spazi da occupare. Incomincia la nostra alfabetizzazione pedatoria. Il Reading gioca quattro partite in cinque giorni: batte il Milan, il Genoa, infligge un devastante 6-0 alla pro Vercelli. Stanchi, pieni di alcol e dopo una serata al casino gli ospiti perdono soltanto dal Casale, che gioca su un campo spelacchiato più piccolo del normale, assai ostico per chi proviene dai meravigliosi rettangoli verdi d’Albione. Nella partita con il Genoa i dirigenti inglesi sono stati colpiti dalla prestazione di Freia, autore dei due gol liguri. Sulla panchina genoana siede William Garbutt, ex giocatore del Reading: a lui si rivolgono i connazionali per acquistare quell’ iradiddio. Garbutt sta al Genoa da un anno, ma gode di grande prestigio e di notevole autorità. La sua carriera nel Blackburn è stata bloccata da un incidente durante la partita con il Manchester United, sotto gli occhi di Pozzo confuso tra il pubblico. A 29 anni, nel 1912, Garbutt è stato assunto presso una compagnia marittima e assegnato alla sede di Genova. A fine giugno gli hanno offerto la guida della squadra rossoblù. E’ stato il primo tecnico professionista: ha introdotto una specifica preparazione fisica e i rudimenti degli schemi. Incute una tal soggezione ai giocatori, che si rivolgono a lui con l’appellativo di «mister Garbutt». E così è nata la figura del mister perdurante nel calcio italiano. L’ingaggio di Freia costa al Reading l’intero ricavato della tournèe. Le pratiche burocratiche sono complesse: la cessione oltre frontiera rappresenta per la federazione un garbuglio di non semplice soluzione. Soltanto a dicembre il centravanti potrà giocare nel nuovo club: la delusione sarà pari alle aspettative. Sui soffici terreni seminati e preparati per il football Freia si mostrerà del tutto fuori ruolo. Nella primavera del 1914 sarà già di ritorno sulla sponda doriana. Il Genoa investe il ricavato della vendita di Freia nella costosissima campagna di rafforzamento finanziata dalle palanche degli armatori: il pallone può contribuire a tener buoni i camalli in un periodo di furibonde rivendicazioni sindacali. Presidente è Geo Davidson ricchissimo imprenditore nato in Scozia, ma trapiantato in Liguria dal 1873: è stato perfino campione italiano di ciclismo nell’86 e selezionato per le Olimpiadi di Parigi del 1900. L’acquisto più luccicante è Renzo De Vecchi. Il «piede di Dio» lascia il Milan dietro ingaggio di 24 mila lire (circa 85 mila euro), quaranta volte lo stipendio annuale di un operaio. Per salvare le apparenze del dilettantismo di facciata Renzo prosegue nel lavoro di fattorino in banca dal lunedì al sabato. Ma tra permessi e allenamenti in ufficio lo vedono con il lanternino. Dopo lo scudetto sarà formalmente promosso fattorino di direzione con lieve aumento di stipendio e un premio speciale di tre marenghi d’oro, valgono 100 lire l’uno. Davidson predispone pure l’ingaggio di Aristodemo Santamaria, che tutti chiamano Emilio, ed Enrico Sardi, formidabile coppia di mezzali dell’Andrea Doria. Il compenso è di 3 mila lire. I due vanno in banca per incassare l’assegno e hanno la sfortuna d’incappare in un cassiere di fede doriana. Non gli pare manco vero di poter denunciare i due «traditori». La federazione è costretta a intervenire. Squalifica di due anni, poi ridotta a uno con multa a ognuno di 1000 lire, sempre bene accetti nelle casse esangui. L’operazione De Vecchi, le stesse stangate a Santamaria e a Sardi accrescono il fascino del calcio nelle classi sociali più povere: coloro che gli preferivano il ciclismo e la boxe per mettersi in tasca un po’ di spiccioli, si accorgono che il pallone può assicurare un lunario più che confortevole. C’è chi ne trae vantaggio all’istante e c’è chi si vergogna di farsi rimborsare persino il biglietto del tram. Ben presto i primi sommergeranno i secondi. La prevalenza del quattrino viene esemplificata dall’ascesa del Casale, i vicini di casa della Pro Vercelli. Le aziende vinicole e i cementifici in sfolgorante sviluppo sovvenzionano i sogni di gloria di una comunità fin lì dedicatasi al pallone elastico, al tamburello, al pallone con il bracciale. Salita alla ribalta in poche stagioni, la squadra domina il campionato del ’14 trascinata dal primo «trio meraviglia» del campionato, Mattea-GallinaII-Varese. Su di essi punta Meazza per l’ennesima sfida con l’Austria in gennaio a Milano. Viene ripescato De Simoni in porta, la fascia di capitano è consegnata a Virgilio Fossati, giocatore-allenatore dell’Inter. L’Arena è piena all’inverosimile. Si sono accalcati anche i reduci dalle manifestazioni interventiste, che da mesi inzeppano piazze e strade: pur nella diversità di slogan, propositi, pretese, a far da mastice è riemerso il vasto risentimento nei confronti dell’Austria, nemico del Risorgimento. E’ lo stesso che serpeggia sui gradoni dell’Arena, che sospinge la nazionale. I danubiani vengono fermati, lo 0-0 suona anzi riduttivo per la foga dell’Italia. Gli spettatori sfollano con la convinzione che il vento della Storia stia cambiando. La stagione prosegue bene. In marzo sconfitta (2-0) la Francia a Torino; in aprile beffardo 1-1 con la Svizzera a Genova. Ma il ritorno a Berna regala la prima soddisfazione in trasferta (1-0), preceduta da infinite discussioni sui titolari all’interno della commissione tecnica. Ciascuno dei componenti ha patrocinato una soluzione in grado di privilegiare i giocatori della società di riferimento. Se la composizione dell’attacco è stata facile con i due esterni della Pro, Berardo e Corna, accanto al trio casalese, la composizione della linea mediana ha costretto a estenuanti riunioni. I primi due difensori fanno da centrali in area, i mediani laterali svolgono funzioni da terzini e il centrosostegno da regista arretrato. Proprio qui sta il rebus. Bisognava scegliere tra Fossati, unico milanese convocato, Milano e Luigi Barbesino, sospinto in alto dall’exploit del Casale. Significava scontentare o i dirigenti della metropoli meneghina o la Pro Vercelli dell’assai influente avvocato Bozino o il Casale, di cui si favoleggia che goda di altissime protezioni lasciando volutamente nel vago se il riferimento sia alla monarchia, al governo, alla massoneria. La soluzione è stata individuata da Francesco Mauro, uno svelto ingegnere chiamato il «re del ghiaccio» per la sua attività nel campo della refrigerazione, abbastanza smagato da aver intuito le mille porte che possono aprire lo sport e il calcio in particolare. I ricordi di chi come Annibale Frossi ebbe la ventura di conoscere i protagonisti del tempo hanno tramandato che fu per l’appunto Mauro, reggente della federazione, a imporre la scelta di schierare i tre galli insieme. E il gol risolutivo realizzato da Barbesino sembrò benedire quello che Frossi definiva il primo compromesso geopolitico, dal quale sarebbero discesi tutti gli altri. In giugno l’uccisione a Sarajevo dell’erede al trono imperiale, Francesco Ferdinando, e della consorte sprofonda l’Europa nel vortice di una guerra campale. Con mille distinguo l’Italia resta alla finestra. Il marchese di San Giuliano, ministro degli Esteri, insegue un’entrata nel conflitto confortata dal 99 per cento di probabilità di successo: quindi nell’attesa di sposare le ragioni del più forte, ci s’aggrappa alla neutralità, con cui teniamo entrambi i piedi in entrambi gli schieramenti (Austria-Germania-Turchia contro Russia-Gran Bretagna-Francia). Il clima nel Paese s’arroventa. All’inizio l’opinione pubblica è divisa a metà, ma gradualmente gl’interventisti prendono il sopravvento, malgrado lo scetticismo di Giolitti sulla valentia dei nostri generali e la Storia gli darà ragione anche su questo. I favori vanno alle Nazioni dell’Intesa amate dagli irredentisti in odio a Cicco Peppe. I seguaci di Corradini - intrigati solo dal menar le mani, chi se ne frega dell’alleato - si lasciano convincere. Anche il calcio ne risente. La guida viene consegnata nelle mani di un onorevole liberale, ufficiale d’artiglieria, decorato nella campagna tripolina. Carlo Montù è uno specchiato gentiluomo torinese: ingegnere elettronico con la passione degli aerei, ha trasportato nello sport il concetto e il comportamento cavallereschi, che si leggono nei manuali e non si applicano nella vita d’ogni giorno. Membro del Comitato olimpico internazionale (Cio), è tra i più attivi promotori del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) nato in giugno. La sua presidenza deve affrontare e risolvere il dilemma sul campionato: fermarlo o meno? Diverse società spingono per l’interruzione dell’attività: temono che la cartolina precetto li privi di parecchi giocatori, temono ancor più che le roventi polemiche su guerra e neutralità distraggano i tifosi dal recarsi allo stadio. Dal ministero sussurrano che una sosta equivarrebbe ad ammettere che l’Italia è sul punto di schierarsi nel conflitto. Non è vero e soprattutto non conviene. Montù è ben felice di adeguarsi alle superiori direttive coincidenti, tra l’altro, con ciò che gli suggerisce il cuore. Il campionato, dunque, prosegue, anzi s’impingua con ben trentasei squadre partecipanti nei sei gironi settentrionali, tredici nei due gironi centrali e le solite due napoletane nel girone meridionale. Durante la preparazione estiva il Torino con Pozzo va in Sud America. Gioca e vince in Brasile e in Argentina. Dall’Italia telegrafano di aspettare la fine della guerra prima d’imbarcarsi per il rientro: l’Atlantico è infestato da corazzate avide di prede, cercano la minima scusa per sparare su tutto ciò che si muove; e poi a casa sono convinti che entro Natale sarà firmata la pace. Al contrario lo scannamento continua, allora la comitiva s’imbarca alla bell’e meglio sul Duca degli Abruzzi: una traversata con il cuore in gola. Li ferma una nave inglese, si porta via i passeggeri di nazionalità tedesca. Sbarcano finalmente a Genova. Sul molo ad attendere il gruppone granata vi sono i familiari: sventolano le cartoline precetto. Pozzo rammenterà a lungo quei colori: «Verdi per gli alpini, granata per i bersaglieri, gialli per gli artiglieri». Poco prima di essere richiamato nell’esercito e assegnato al battaglione della scuola aviatori, Montù s’industria di organizzare una partita della nazionale. Ma c’è il divieto governativo di rivolgersi ai Paesi in guerra, ammesso che qualcuno di essi abbia voglia di allestire una formazione, per non manifestare compromettenti simpatie. Non resta allora che la Svizzera, contro la quale si gioca una fredda domenica del gennaio 1915 a Torino. Squadra azzurra rivoluzionata dalle assenze dei tanti in grigioverde, nessuno del Casale ed esordio di Luigi Cevenini, il terzo e più bravo dei cinque famosi fratelli, con l’ansia di apparire un inappuntabile borghese. Quel giorno fa coppia con Aldo il maggiore, uno dei reduci assieme a capitan Fossati dell’esordio all’Arena contro la Francia: hanno la fortuna di segnare entrambi (3-1). L’arbitro è uno dei Pasteur nati a Genova da genitori elvetici nonché componente della commissione tecnica, che ha silurato Meazza e designato Nino Resegotti. La nazionale in pratica si scioglie per mancanza di avversari. Rimane il campionato nel quale svetta il Genoa rinvigorito dalle cure di Garbutt e dagli innesti procurati dai suoi danarosi dirigenti. A Torino i tifosi della Juve stampano il papà dei periodici dedicati alla squadre del cuore, Hurrà. Il 23 maggio negli spogliatoi di Genova, Milano, Roma e Pisa alle squadre in procinto di scendere in campo viene letto il seguente telegramma «In seguito mobilitazione per criteri opportunità sospendesi ogni gara». Il Genoa e la Lazio, che quel giorno dovrebbero affrontare Torino e Lucca, sono a un passo dalla qualificazione alla finalissima, ma dopo la guerra il titolo sarà misteriosamente assegnato al Genoa per… presunta superiorità: sul groppone della Lazio pesano, al di fuori ogni logica, le sconfitte nelle due finali precedenti contro Pro Vercelli e Casale. Il giorno dopo nell’esercito italiano in marcia verso la frontiera sono tantissimi i giocatori e i dirigenti di primo piano. A differenza di quanto capiterà nel 1940, c’è stata la gara ad arruolarsi. Nonostante l’età avanzata lo ha fatto pure Spensley nella sanità britannica. Viene catturato durante la prima battaglia della Marna, in seguito alle ferite cessa di vivere nel carcere di Magonza, dove soltanto nel 1993 la sua tomba verrà individuata da due tifosi rossoblù. L’elenco dei caduti in combattimento è aperto in luglio sul monte Piana dal sottotenente Erminio Brevedan, attaccante del Milan; il 23 agosto a Cima Maggio è colpito il tenente Luigi Ferraris, ingegnere, centromediano del Genoa, volontario, cui sarà dedicato lo stadio di Marassi; a fine ottobre, nella terza battaglia dell’Isonzo, cade Enrico Canfari, uno dei liceali fondatori della Juve, giocatore e secondo presidente del club, dopo il fratello Eugenio, in seguito tesserato dal Milan e presidente degli arbitri; nel prosieguo della terza battaglia sull’Isonzo muore in novembre a Zagora Felice Milano, l’ala della Pro Vercelli dei cinque titoli e della nazionale. Nella stessa zona opera in divisa da ufficiale austroungarico Hugo Meisl, l’allenatore della rappresentativa danubiana, mentre Pozzo sta fra gli alpini sulle Dolomiti. Alla fine del 1915 sono 27 i calciatori defunti. Non c’è società che non pianga i propri caduti. Oltre ai giocatori, il Milan perde il vice presidente, il marchese Gilberto Porro Lambertenghi - autore assieme al conte Alberto Bonacossa del primo manuale sul tennis - e uno dei soci fondatori, Glauco Nulli, ufficiale dei bersaglieri, che ha guidato i suoi alla conquista di Col Bricon: lo ricompensano con la medaglia d’oro. La più colpita è l’Internazionale: fra dirigenti e atleti lamenta 26 morti. Non tornano più di metà dei titolari del Verona e dell’Udinese. Rimane mutilato Attilio Trerè, il terzino destro della squadra scesa in campo nel 1910 contro la Francia. Viene gravemente ferito nei giorni di Caporetto Giovanni Moscardini, ventanni, centravanti lucchese, prossimo titolare in nazionale, rientrato dalla Scozia dove la famiglia era emigrata da Badia. E’ ucciso Gavinelli ala destra degli azzurri a Parigi nel 1911. Così porta nella tomba il piccolo mistero della sua identità. Secondo l’annuario del football 1913-1914, si chiama Rodolfo è del 1895, fa il contabile e in tal modo strapperebbe a De Vecchi il primato di più giovane esordiente; in seguito verrà, invece, precisato che si chiamava Pietro Antonio ed era del 1893. L’unica notizia sicura è il suo ritorno dalla Francia per crepare con il grigioverde. Virgilio Fossati, capitano dell’esercito, oltre che dell’Internazionale e dell’Italia, sarà l’ultimo di questo triste elenco: se ne andrà nella tarda primavera del ’18 sul Carso nell’assalto alla postazione nemica. Di pochi mesi l’ha preceduto il compagno di reparto e amicissimo Giuseppe Caimi. Nel dicembre del ’17 a Cima Valderoa, sul Monte Grappa, dopo esser scappato dall’ospedale ha guidato il plotone incursori in una mischia furibonda. Gli daranno la medaglia d’oro: mezzo secolo dopo Pozzo ancora rimpiangerà di non averlo portato alle Olimpiadi di Stoccolma, ma preferiva troppo le gonnelle agli allenamenti e per don Vittorio rappresentava l’insubordinazione più grave. In Italia i terreni di gioco sono stati riempiti dai ragazzini. Dopo l’ultima leva del ’99 e di alcuni del ’900, vengono organizzati tornei per quindicenni e sedicenni. Dal fronte l’inarrestabile Montù ha messo a disposizione una coppa per il primo trofeo giovanile organizzato in Lombardia. Proprio la sua lontananza consente all’ingegner Mauro di avocare a sé la reggenza della federazione. Gli dà una mano il fratello minore Giovanni, avvocato di convincente oratoria, tra i fondatori dell’Inter, arbitro, dirigente, cui la divisa di tenente degli alpini conferisce un’opportuna autorevolezza. Vengono varate una coppa federale, vinta dal Milan nel ’16, e una coppa Mauro. Non le ferma nemmeno la disfatta di Caporetto. Le cronache ci parlano di una Nazione allibita e atterrita di veder bivaccare gli austriaci in piazza San Marco a Venezia, tuttavia tre giorni dopo, il 28 ottobre 1917, Milan e Unione Sportiva Milanese si affrontano al campo sportivo di via Stelvio. In quelle stesse ore si disputano altre dodici partite di campionati minori. E non basta l’atmosfera di emergenza collettiva e di spontanea solidarietà a evitare le camarille di sempre. Il Milan risulta vincitore della coppa Mauro, però non gliel’assegnano per le polemiche e le proteste scatenate dal tardivo ripensamento dell’arbitro meneghino Rigoletto Terzi: sostiene di voler annullare ciò che aveva convalidato, cioè il gol con cui il Legnano ha sconfitto l’Internazionale. I dirigenti del Legnano, dell’Enotria, del Saronno insorgono contro Mauro accusato di aver tramato per favorire il successo del Milan ai danni del Legnano. Ci vanno di mezzo altri arbitri e dirigenti federali. Mauro, tifoso dell’Internazionale, di cui diventerà presidente, preferisce azzerare il torneo per sventare la scissione di alcune società pronte a passare con l’Unione libera italiana del calcio (Ulic), fondata dal farmacologo Luigi Maranelli convinto assertore di un movimento senza tessere e regolamenti. Il cuore dell’Ulic batte a Milano, che a livello federale continua a considerarsi defraudata dai torinesi. Il successo è immediato: i suoi tornei attirano gli spettatori, tentano i giocatori delle grandi squadre. Vi partecipano nei periodi di licenza. I fratelli Cevenini sono capaci di giocare due volte al giorno in club differenti, benché il cambio di casacca sia consentito da una domenica all’altra. L’allegra anarchia della Ulic farà concorrenza per dieci anni alla Figc prima di pagare lo scotto dell’eccessivo spontaneismo e di venire normalizzata. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |
